3- Elia
Il libretto di Elia: Qol Demamah Daqqah - voce di silenzio svuotato
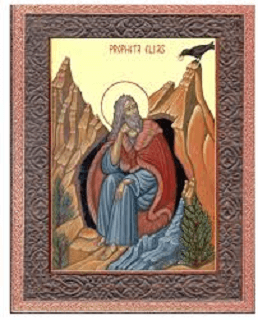
Lettura 1 1 Re 17,1 Il Personaggio Elia e la sua (?) profezia
Premessa
Un autore serio scrive pensando ai suoi lettori e adatta la narrazione e il linguaggio ai suoi lontani interlocutori che gli studiosi chiamano sinteticamente "lettori impliciti".
Anche la Bibbia suppone un lettore implicito, le caratteristiche del quale possono apparire differenti a seconda del genere letterario, della storia delle tradizioni, delle varie redazioni, ecc. (vedi in Glosse, nota esegetica 4).
Il "libretto di Elia" esige un lettore implicito molto attento e critico.
"Critico" non vuol dire "demolitore", ma capace di dare giudizi riflessi e meditati perché, certo, la Bibbia è Parola di Dio, ma "Parola" che acquista il significato e valore nel suo insieme o, meglio, nella sua unità.
Una frase estrapolata dal suo contesto può trasformare una Parola di Dio in una parola contro Dio.
Maestro di questo genere di estrapolazione e interpretazione distorta è Satana come raccontano le tentazioni di Gesù nel deserto (Mt 4,1-11 e paralleli). Satana è un buon conoscitore della Bibbia, ma la usa in modo distorto,
La lettura del "libretto di Elia" richiede appunto di verificare passo passo quando il testo è parola che viene da Dio e quando non viene da Lui.
I personaggi principali sono Elia e il suo Dio che, però è sempre fuori campo anche se è coprotagonista e regista. Gli altri personaggi, anche se hanno nomi diversi, potremmo essere noi; i loro dubbi, le loro domande sono le nostre oppure... oppure, perché no, potremmo identificarci con lo stesso Elia.
Nota bene, diciamo: "Libretto di Elia" perché nella Bibbia non esiste un libro di Elia, la vicenda di Elia si trova a cavallo di 1Re e 2 Re e tuttavia ha delle caratteristiche particolari che lo staccano dai due libri citati.
Iniziamo dal primo versetto che già di per sé ci sorprende:
1 Re 17,1«Elia, il Tisbita, uno degli abitanti di Gàlaad, disse ad Acab: «Per la vita di JHWH, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo dirò io».
Elia compare improvvisamente: non c'è una presentazione, non c'è un racconto di vocazione, non c'è il nome del padre, ma solo il luogo di provenienza: Tisbe di Galaad.
Improvvisa è la sua apparizione come improvvisa sarà la sua scomparsa alla fine del racconto.
Chi è questo Elia? È un profeta? È un ciarlatano? È un uomo di Dio o un furbastro? Il lettore deve riflettere e rispondersi. Il libretto di Elia, come abbiamo detto, è fatto per pensare perché se lo si prende alla lettera si rischia di non comprenderlo.
Elia si rivolge direttamente ad Acab, re d'Israele, come fosse un uomo di Dio, ma non c'è la formula del messaggero come: "Dice il Signore" oppure "Così dice JHWH" o anche "Oracolo del Signore".
Ci dovrebbe sorprendere anche la chiusura della profezia: "fino a quando lo dirò io", ma "io" chi? Io, io o io JHWH?
Però uno che esprime un giuramento a riguardo della sua profezia con quel giuramento: "sulla vita del Signore alla cui presenza io sto", beh, con uno che sta lì alla presenza del Signore c'è poco da scherzare, però... però nel libro di Esodo non abbiamo mai trovato un'espressione del genere. Quattro volte si trova, in forma di preghiera la frase di Mosè: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi", ma è un'affermazione che originariamente parte da Dio che gli aveva rivelato: "Tu (Mosè) hai trovato grazia ai miei occhi".
Infatti nessuno può essere sicuro di essere ammesso alla presenza di Dio se non è Dio stesso che glielo rivela.
Per esempio, in una anafora, la preghiera del Canone della Messa, il celebrante rivolto al Padre dice:"... Tu che ci hai resi degni di essere ammessi alla tua presenza..." perché si ritiene che solo Dio può ammettere qualcuno alla sua presenza.
È una affermazione sconvolgente perché vuol dire che uno che è lì a Messa, qualunque sia la sua situazione morale, fisica, politica, etnica, culturale, ecc., per il semplice fatto di essere lì, è degno di essere ammesso alla presenza di Dio perché questa è opera Sua. Non sono io che mi rendo degno, ma è Dio che mi rende tale, che mi "fa trovare grazia ai suoi occhi".
Così, nel nostro testo, Elia si rivolge a re Acab senza preamboli giustificando il suo comportamento con il fatto che lui (Elia) sta alla presenza di Dio. Si vede che ha un rapporto con Dio ancor più diretto che quello di Mosè.
D'altra parte, tutti sanno che Dio fa quello che vuole: "come i cieli sono distanti dalla terra così i Miei pensieri sono distanti dai vostri" e nei Vangeli si dice che "raccoglie dove non ha seminato".
Si vede che Elia ha un filo rosso diretto con Dio.
E comunque uno che parla così ha una fede che può fare qualunque cosa... molto di più che trasportare la montagne!
Ce ne fossero di uomini con una fede simile!
Lettura 2 1 Re 17,1 La reazione di re Acab
La reazione di re Acab alla profezia di Elia è un assurdo silenzio.
"Assurdo" perché non è richiesta una spiegazione, una preghiera, un eventuale domanda di perdono, nulla, solo silenzio.
Eppure la siccità in quella terra, senza fiumi importanti e in quel clima costituisce un pericolo mortale perché alla siccità segue inevitabilmente la carestia. Poi quando le riserve d'acqua si riducono bisogna uccidere gli animali e infine segue la morte del popolo. Vedremo più avanti.
Però di fronte a questa terribile prospettiva abbiamo da parte del re solo il suo imbarazzante silenzio, per di più aggravato dalla prevista durata della siccità minacciata da Elia: "in questi anni". Quindi non una stagione, ma un lungo tempo.
Possiamo tentare di spiegare il perché di un "castigo" così duro. E allora dobbiamo riferirci agli eventi precedenti narrati dal libro di 1Re.
Nel 931 a. C. abbiamo lo scisma politico seguito alla morte di Salomone. La parte più grande e ricca del territorio, che è anche oggetto del nostro testo, con Geroboamo, costituisce a Nord il Regno d'Israele e capitale Samaria mentre a Sud rimane il piccolo Regno di Giuda in parte arroccato sulle montagne e in parte costituito da grandi pianure desertiche inabitabili.
Raccontati questi fatti il libro di1 Re, come poi farà anche 2Re, passa in rassegna la successione dei regnanti i due regni, riportando sinteticamente le loro imprese ed esprimendo via via un giudizio su di essi. È un giudizio che prende in considerazione non tanto la grandezza storico-politica, ma soprattutto la fedeltà all'Alleanza, tema fondamentale per il popolo di Dio. Dell'Alleanza abbiamo trattato lungamente nel libro di Esodo.
Ora, il Regno del Nord viene considerato "geneticamente" infedele perché Geroboamo, allo scisma politico, aveva aggiunto lo scisma religioso per troncare anche i legami religiosi con Gerusalemme. Aveva quindi ricostruito due templi a Betel e a Dan ponendovi i famosi due vitelli d'oro, come narrato in 1 Re 12,26 ss.
Di Acab viene espresso questo giudizio:
1 Re 16,27 «Le altre gesta di Omri, tutte le sue azioni e le sue prodezze, sono descritte nel libro delle Cronache dei re di Israele. 28 Omri si addormentò con i suoi padri e fu sepolto in Samaria. Al suo posto divenne re suo figlio Acab.
29 Acab figlio di Omri divenne re su Israele nell'anno trentottesimo di Asa re di Giuda. Acab figlio di Omri regnò su Israele in Samaria ventidue anni. 30 Acab figlio di Omri fece ciò che è male agli occhi di JHWH, peggio di tutti i suoi predecessori. 31 Non gli bastò imitare il peccato di Geroboamo figlio di Nebàt; ma prese anche in moglie Gezabele figlia di Et-Bàal, re di quelli di Sidone, e si mise a servire Baal e a prostrarsi davanti a lui. 32 Eresse un altare a Baal nel tempio di Baal, che egli aveva costruito in Samaria. 33 Acab eresse anche un palo sacro e compì ancora altre cose irritando JHWH Dio di Israele, più di tutti i re di Israele suoi predecessori.
34 Nei suoi giorni Chiel di Betel ricostruì Gerico; gettò le fondamenta sopra Abiram suo primogenito e ne innalzò le porte sopra Segub suo ultimogenito, secondo la parola pronunziata dal Signore per mezzo di Giosuè, figlio di Nun».
Quindi Acab, oltre a proseguire nel solco tracciato dai suoi predecessori, sposa una principessa straniera, Gezabele, che introduce nel paese culti di altri dèi.
Il v 34 a mo' di giudizio conclusivo, denuncia la rifondazione di Gerico la cui prosperità sarebbe assicurata dal sacrificio rituale di due ragazzi, pratica idolatrica particolarmente raccapricciante.
Ma tutto questo giustifica la siccità annunciata da Elia?
Un governante così "infedele" può giustificare un castigo tanto duro da parte di Dio?
E nel popolo sono tutti idolatri?
Il lettore implicito è perciò costretto a riflettere e continuare ad interrogare il testo.
Lettura 3 1 Re 17,2-7 La prima fuga di Elia
Adesso è Dio che parla:
1 Re 17, 2 «A lui fu rivolta questa parola di JHWH: 3 «Vattene di qui, dirigiti verso oriente; nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. 4 Ivi berrai al torrente e i corvi per mio comando ti porteranno il tuo cibo». 5 Egli eseguì l'ordine di JHWH; andò a stabilirsi sul torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. 6 I corvi gli portavano pane al mattino e carne alla sera; egli beveva al torrente.
7 Dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non pioveva sulla regione».
Elia, ubbidiente, esegue l'ordine e si nasconde in riva al torrente Cherit.
Forse il comando di Dio ha lo scopo di proteggerlo dalla rappresaglia di re Acab.
Se si tratta di nascondimento la località è pensata bene perché il torrente Cherit, citato solo qui in tutta la Bibbia, risulta ancora del tutto sconosciuto.
Lì Elia trova il suo nutrimento giornaliero: pane e carne, secondo la parola di JHWH, mentre l'acqua è "assicurata" dal torrente... che però ad un certo punto si secca.
E poi, che strano, Dio fornisce il cibo mediante i corvi che sono animali impuri come recita il libro del Levitico:
Lv 11,13 «Fra i volatili terrete in abominio questi, che non dovrete mangiare, perché ripugnanti: l'aquila, l'ossìfraga e l'aquila di mare, 14 il nibbio e ogni specie di falco, 15 ogni specie di corvo, 16 lo struzzo, la civetta, il gabbiano e ogni specie di sparviere, 17 il gufo, l'alcione, l'ibis, 18 il cigno, il pellicano, la fòlaga, 19 la cicogna, ogni specie di airone, l'ùpupa e il pipistrello».
Ma perché Dio usa dei corvi che sono impuri?
E perché Elia si nutre di quel cibo che, toccato dai corvi, è divenuto a sua volta impuro?
Allora Elia non rispetta la Legge?
Però il comando viene da Dio.
E ad un certo punto il torrente si secca. Lo sanno tutti che un corso d'acqua si definisce "torrente" proprio perché il suo flusso non è costante.
E perché Dio non gli procura anche l'acqua?
Il v 7 è sibillino: «Dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non pioveva sulla regione».
Allora il comando di Dio al v4 "ivi berrai al torrente" è una presa in giro.
Non è che Elia è vittima della siccità che lui stesso ha provocato?
Ma lui è l'uomo di Dio e Dio lo protegge... gli da cibo mattina e sera!
La prima lettura ricordava che Elia ha annunciato la siccità a re Acab senza la "formula del messaggero".
Non è che l'acqua viene a mancare secondo "la parola di Elia"?
Il testo continua ad essere intrigante e ci costringe a riflettere, ad andare avanti e a rileggere il già letto.
Deve essere continuamente interrogato.
Lettura 4 1Re 17,8-16 Zarepta di Sidone Prima scena
1Re 17,8 «JHWH parlò a lui e disse:
9 «Alzati, và in Zarepta di Sidòne e ivi stabilisciti. Ecco io ho dato ordine a una vedova di là per il tuo cibo».
10 Egli si alzò e andò a Zarepta. Entrato nella porta della città, ecco una vedova raccoglieva due legni. La chiamò e le disse: «Prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere».
11 Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Prendimi anche un pezzo di pane».
12 Quella rispose: «Per la vita di JHWH tuo Dio, non ho alcuna cosa cotta (provvista), ma solo un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per me e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo».
13 Elia le disse: «Non temere; va', fa' come hai detto, ma prepara prima una piccola focaccia (19,6) per me e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio,
14 poiché dice JHWH: La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra».
15 Quella andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono essa, lui e il figlio di lei per diversi giorni.
16 La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per mezzo di Elia».
Seccato il torrente Elia si trova nella situazione della terra priva di pioggia, condannato a morire di sete, come accadrà più avanti nel deserto, ma Dio interviene e lo manda a Zarepta di Sidone, dove una vedova ha ricevuto l'ordine di provvedere a lui. È lo stesso compito svolto prima dai corvi.
Zarepta è una città fenicia sulla costa a più di 200 Km da Samaria, e potremmo ritenere preservata dalla siccità.
Elia ubbidisce ma giunto a Zarepta dovrebbe attendere il segno che indichi la vedova che lo deve incontrare, invece alla prima donna che trova, senza alcuna grazia, le chiede da bere e poi pretende anche da mangiare. Lo fa con una prepotenza e con un'arroganza che ce lo rende insopportabile.
Elia poi aveva una presenza tutt'altro che gradevole perché 2 Re 1,8 lo descrive così: « era un uomo peloso e una cintura di cuoio gli cingeva i fianchi».
In quel tempo gli orfani e le vedove erano le persone più fragili della società perché, senza il padre di famiglia, non avevano alcun sostentamento economico. Loro dovevano essere aiutate! È un ritornello che scandisce molte pagine della Bibbia; ma qui succede esattamente il contrario. E per giunta nella forma di "pretesa" avanzata senza un minimo di gentilezza.
Questa donna è straniera, della stessa stirpe della regina Gezabele sposata a suo tempo da re Acab, quella che aveva introdotto in Israele il culto di Baal, come abbiamo visto nella lettura 2.
Sono due figure contrapposte che dovremo confrontare.
Il fatto che la vedova sia straniera suggerisce che l'itinerario spirituale proposto dal nostro libretto sia universale, cioè, non rivolto soltanto a Israele, ma tutti gli uomini compresi i Fenici che la Bibbia chiama Filistei, gli acerrimi nemici degli ebrei; un altro tema che dovremo tenere presente e sul quale riflettere.
Comunque questa vedova, forse impressionata dal personaggio inteso come uomo del Dio di Israele, con un giuramento su JHWH mette subito in chiaro la sua condizione: potrà mangiare solo una volta, lei e il figlio e poi attendere la morte. È ancora conseguenza della siccità voluta da Elia? Ma qui non siamo nel regno d'Israele per il quale era stata annunciata la siccità.
Ma tutto questo ad Elia non interessa perché vuole mangiare e non esita a tirare in ballo anche Dio (v 14).
Infatti se osserviamo la scena, notiamo che egli non muove un dito mentre tutti i verbi di movimento riguardano la donna che prepara la focaccia per l'ospite.
Nella sua frenetica attività in v10 e in v12 si parla della raccolta di "due pezzi di legno" e la vedova dice di "non avere niente di cotto", elementi che al momento sembra che non abbiano alcun significato, ma c'è un allusione al fuoco: manca il fuoco. Esattamente quel fuoco che concluderà il ciclo di Elia.
Se rispettasse il buon senso questa donna (e soprattutto Elia) dovrebbe dare l'ultimo cibo di cui dispone al figlio e poi allo straniero, ma d'altra parte essa è vincolata al dovere dell'ospitalità, una norma sacra per tutti i popoli dell'Oriente.
E ci dobbiamo chiedere: prima il figlio o prima l'ospite?
E poi: al v14 abbiamo a che fare con la Parola del Signore o con la parola di Elia? Il dubbio è più che legittimo.
E la donna agisce in base alla promessa di questo tipaccio o al dovere dell'ospitalità?
Il v 16 sembra affermare che era parola di Dio.
Ma non è che Dio sia stato costretto ad intervenire per salvare la faccia del suo profeta?
Oppure qui è accaduto qualcosa di grandioso: questa condivisione dell'ultima manciata di farina e di olio che si è moltiplicata per molti giorni, non rimanda alla moltiplicazione dei pani e dei pesci che avverrà 900 anni più tardi sulle rive del lago di Tiberiade? Anche lì un ragazzino, l'unico "previdente", che si era portato in tasca la sua merenda, l'ha messa a disposizione perché sfamasse a più di 5000 uomini?
Allora è lecito chiederci se il merito di questo prodigio sia di Elia o della vedova, che sottolineiamo, era straniera e nella sua miseria ha trovato il coraggio di condividere quel niente che aveva
... ma rimane il dubbio di fondo, della vedova e nostro: ma chi è questo Elia?
Uomo di Dio o sbruffone?
Lettura 5 1Re 17,17-24 Zarepta di Sidone Seconda scena
1Re 17,17 « In seguito il figlio della padrona di casa si ammalò. La sua malattia era molto grave, tanto che rimase senza respiro».
Siamo in pieno territorio della Fenicia e i fenici, adoratori di Baal, usavano sacrificare i figli agli dèi per propiziarseli, come ricorda il brano della presentazione di Acab che abbiamo visto alla fine della Lettura 2:
1Re 16,34 «Nei suoi giorni Chiel di Betel ricostruì Gerico; gettò le fondamenta sopra Abiram suo primogenito e ne innalzò le porte sopra Segub suo ultimogenito, secondo la parola pronunziata dal Signore per mezzo di Giosuè, figlio di Nun».
Però non sembra che questa vedova sia molto felice di quanto sia accaduto al figlio e allora dobbiamo riflettere sulle relazioni effettivamente esistenti all'interno delle famiglie fenicie.
18 «Essa allora disse a Elia: «Che c'è fra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia iniquità e per uccidermi il figlio?».
19 Elia le disse: «Dammi tuo figlio». Glielo prese dal seno, lo portò al piano di sopra, dove abitava, e lo stese sul letto. 20 Quindi invocò il Signore: «Signore mio Dio, forse anche contro questa vedova farai del male, tanto da farle morire il figlio?». 21 Si distese tre volte sul bambino e invocò il Signore: «Signore Dio mio, il respiro del fanciullo torni nel suo corpo».
22 Il Signore ascoltò il grido di Elia; l'anima del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere.
23 Elia prese il bambino, lo portò al piano terreno e lo consegnò alla madre. Elia disse: «Guarda! Tuo figlio vive».
24 La donna disse a Elia: «Ora so che tu sei uomo di Dio e che la vera parola di JHWH è sulla tua bocca».
In questa seconda scena si sono invertite le parti rispetto alla precedente. I verbi di azione riguardano Elia, (lo prese, lo portò, lo stese; una preghiera e nuovamente lo prese, lo portò, lo consegnò, mentre la donna è trepidante in attesa.
E la figura di Elia diventa ancor più enigmatica!
A seguito della morte del bambino si radicalizza nella madre il dubbio lasciato in sospeso prima: chi è costui? è un uomo di Dio o di un essere malvagio? «Che c'è fra me e te uomo di Dio »?
E vediamo che essa nutre l'idea di un Dio vendicativo capace di uccidere un figlio per castigare le iniquità della madre.
Allora emerge il problema di fondo di tutto il libretto di Elia: qual è l'idea o l'immagine di Dio?
«...Elia porta il ragazzo al piano di sopra...». Storicamente il piano di sopra era la stanza degli ospiti, ma in questo caso il significato non è quello di una traslazione spaziale, ma spirituale, religioso: indica un salto di qualità.
Infatti siamo costretti a cogliere una novità: dopo la morte del ragazzo, Elia, provocato dalla donna, per la prima volta si rivolge a Dio con una preghiera accorata. Adesso non è più prepotente!
Forse si è reso conto che qui è in gioco la credibilità del suo Dio e che il suo rapporto con Lui non è stato proprio di sottomissione. E se c'è in gioco qualche "iniquità" è sua e non della vedova.
Se la lettura precedente aveva lasciato in sospeso la risposta alla domanda: "chi è Elia" ora troviamo la risposta al v24: La donna disse a Elia: «Ora so che tu sei uomo di Dio e che la vera parola di JHWH è sulla tua bocca».
Certamente, Elia è uomo di Dio, ma quale Dio? Meglio, qual è l'idea del Dio in cui crede Elia?
Perché per qualunque uomo è un dramma se non crede nel Dio giusto...
E non dobbiamo perdere di vista il tema della "rinascita": il bambino muore alla vita e rinasce grazie alla mediazione dell'uomo di Dio.
È la rinascita ad una vita nuova, non come quella di prima... è avvenuta "al piano di sopra".
Ma è solo un'anticipazione!
C'è qualcuno che deve morire e rinascere...
APPENDICE
Alcuni studiosi, come Paul Beauchamp, che hanno tentato di costruire un teologia biblica, sostengono che le Scritture contengono poche figure le quali attraverso lo svolgersi della storia, composta da molti racconti e diversi generi letterari, in realtà presentano, approfondiscono, ribadiscono sempre le stesse "figure".
Infatti nel vangelo di Giovanni troviamo un testo parallelo.
Gv 4,43 «Trascorsi due giorni, partì di là per andare in Galilea. 44 Ma Gesù stesso aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella sua patria. 46 Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario imperiale (romano), che aveva un figlio malato a Cafarnao. 47 Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e lo pregò di scendere a guarire suo figlio poiché stava per morire. 48 Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». 49 Ma il funzionario romano insistette: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». 50 Gesù gli risponde: «Va', tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino. 51 Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i servi a dirgli: «Tuo figlio vive!». 52 S'informò poi a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno la febbre lo ha lasciato». 53 Il padre riconobbe che proprio in quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive» e credette lui con tutta la sua famiglia».
Consideriamo l'apertura nel v 44 in cui Gesù dichiara che un profeta non è considerato tale in patria, quindi in quel posto si sente estraneo. E così ribadisce il detto popolare: "nessuno è profeta in patria". Inoltre la Galilea era ritenuta pagana dai giudei che la chiamavano "Galilea delle genti".
Allora l'evangelista ci vuol evidenziare che il segno avviene in territorio straniero. Il ragazzo guarito è anch'esso straniero, come il figlio della vedova di Zarepta e altrettanto straniero è il padre del ragazzo, probabilmente un ufficiale romano.
A differenza di Elia, Gesù non ha bisogno di eseguire alcun gesto taumaturgico gli basta la parola... e la fede dell'ufficiale romano.
Quindi Gesù è più di Elia.
E dobbiamo rilevare un'istanza presente sin dalle origini della religione giudeo cristiana: l'apertura universale, la destinazione della salvezza a tutti gli uomini.
Lettura 6 1Re 18,1- 19 Elia e Acab
Dal punto di vista strutturale riconosciamo nel brano seguente quattro scene di cui la quarta conclude e apre al racconto successivo. Tutta la pericope è scandita dal verbo andare nella voce: "va'", che la traduzione CEI non rispetta.
1^ scena =>18, 1 «Dopo molto tempo, il JHWH disse a Elia, nell'anno terzo: «VA', mostrati ad Acab; io concederò la PIOGGIA alla terra». 2 Elia andò a farsi vedere da Acab. In Samaria c'era una grande carestia.
2^Scena =>3 Acab convocò Abdia maggiordomo. Abdia temeva molto Dio; 4 quando Gezabele uccideva i profeti di JHWH, Abdia prese cento profeti e ne nascose cinquanta alla volta in una caverna e procurò loro pane e acqua. 5 Acab disse ad Abdia: «VA' nel paese verso tutte le sorgenti d'ACQUA e tutti i torrenti d'ACQUA della regione; forse troveremo erba per tenere in vita cavalli e muli e non dovremo uccidere una parte del bestiame». 6 Si divisero la regione da percorrere; Acab andò per una strada e Abdia per un'altra.
3^ Scena => 7 Mentre Abdia era in cammino, ecco farglisi incontro Elia. Quegli lo riconobbe e si prostrò con la faccia a terra dicendo: «Non sei tu il mio signore Elia?». 8 Gli rispose: «Lo sono; VA' di' dal tuo padrone: C'è qui Elia». 9 Quegli disse: «Che male ho fatto perché tu consegni il tuo servo ad Acab perché egli mi (1)uccida? 10 Per la vita di JHWH tuo Dio, non esiste un popolo o un regno in cui il mio padrone non abbia mandato a cercarti. Se gli rispondevano: Non c'è! egli faceva giurare il popolo o il regno di non averti trovato. 11 Ora tu dici: VA', dì al tuo signore: C'è qui Elia! 12 Appena sarò partito da te, lo spirito del Signore ti porterà in un luogo a me ignoto. Se io vado a riferirlo ad Acab egli, non trovandoti, mi (2) ucciderà; ora il tuo servo teme JHWH fin dalla sua giovinezza. 13 Non ti hanno forse riferito, mio signore, ciò che ho fatto quando Gezabele sterminava tutti i profeti di JHWH, come io nascosi cento profeti, cinquanta alla volta, in una caverna e procurai loro pane e acqua?
14 E ora tu comandi: VA', dì al tuo signore: C'è qui Elia? Egli mi (3) ucciderà». 15 Elia rispose: «Per la vita di JHWH degli eserciti, alla cui presenza io sto, oggi stesso io mi mostrerò a lui».
4^ Scena => 16 Abdia andò incontro ad Acab e gli riferì la cosa. Acab si diresse verso Elia. 17 Appena lo vide, Acab disse a Elia: «Sei tu la rovina/ AKOR di Israele!». 18 Quegli rispose: «Io non rovino/AKOR Israele, ma piuttosto tu insieme con la tua famiglia, perché avete abbandonato i comandi del Signore e tu hai seguito Baal.
19 VA', con un ordine raduna tutto Israele presso di me sul monte Carmelo insieme con i quattrocento-cinquanta profeti di Baal e con i quattrocento profeti di Asera, che mangiano alla tavola di Gezabele».
1^ - Dio ed Elia. La parola di Dio invia Elia da re Acab per annunciare l'invio della pioggia. E veniamo a sapere che la siccità dura da tre anni; quindi mancano tre raccolti e il paese vive una carestia molto grave.
Dio non aveva mai detto: "non darò la pioggia". È stato Elia a dire al re Acab: "Non ci sarà né rugiada né pioggia finché lo dirò io..." Infatti il nostro Dio non è quello che «fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti»? Mt 5,45
Allora la parola di Elia andava in direzione opposta a quella di Dio?
2^ - Re Acab e Abdia. Comunque questa siccità è molto grave « In Samarìa c'era una grande carestia» v2, al punto che anche re Acab si preoccupa. Sì, ma per i cavalli, non per il popolo. Così grave da inviare in cerca d'acqua anche il primo ministro... sempre per i cavalli!
Quindi Dio invia Elia, il suo ministro, re Acab invia Abdia, il suo primo ministro; come svolgeranno il loro compito?
Nella comprensione biblica il cavallo è citato quasi sempre in senso negativo. In un paese prevalentemente montagnoso, come nelle nostre valli alpine, il mezzo di trasporto prevalente era il mulo che può portare carichi molto pesanti per i sentieri più impervi e pericolosi e così diventava compagno di lavoro per l'uomo. Non invece il cavallo che vuole terreni e strade adatte; molto usato per la corsa e la guerra.
Il mulo è una figura di pace, il cavallo è una figura di guerra.
L'inserzione di questa "ricerca regale" è intrigante perché insinua nel lettore una domanda sibillina: se re Acab non si preoccupa per le condizioni del popolo, se ne occupa forse Elia?
Però adesso possiamo stare tranquilli perché è stato inviato da Dio per annunciare la fine della siccità.
Ma Elia sarà un obbediente ambasciatore di giustizia e di pace?
3^ - Abdia ed Elia. Il nome completo del primo ministro tradotto con Abdia in ebraico è Abad-ja, abbreviazione di Abad-JHWH , cioè "Servo di JHWH".
Sappiamo che per gli antichi il nome non era un semplice suono, ma un programma di vita per chi lo portava.
Allora è vero che Abdia è servo di JHWH?
I vv 3-4 dicono: «Abdia temeva molto Dio, quando Gezabele uccideva i profeti di JHWH, Abdia prese cento profeti e ne nascose cinquanta alla volta in una caverna e procurò loro pane e acqua».
Poi al v12: «... ora il tuo servo teme JHWH fin dalla sua giovinezza».
Quindi siamo di fronte ad una figura di fede silenziosa, lontana dal chiasso e dalle manifestazioni di potenza che opera efficacemente a favore dei fratelli di fede in pericolo.
Non possiamo fare a meno di rilevare l'abilità di questo narratore che indirettamente ci mette davanti una figura di contrasto. Verso chi? Lo scrittore non lo dice perché è il lettore implicito che rispondere o rispondersi e cercare la risposta nel seguito.
E quelle poche righe che ci presentano la figura del re sono un giudizio su Acab o sull'istituzione monarchica? E noi potremmo aggiungere: su coloro che sono responsabili della vita dei popoli.
Elia inviato ad annunciare l'invio della pioggia chiede al primo ministro Abdia di essere presentato al re e dalla risposta di Abdia veniamo a sapere che in Samarìa era in corso una persecuzione dei fedeli di JHWH e che lo stesso Elia era un "ricercato". Così comprendiamo perché Dio l'aveva "nascosto", prima presso il torrente Cherit e poi a Zarepta.
Il testo mette in campo non solo il tema della fede ma anche quello dell'obbedienza. Abdia riesce ad essere obbediente al re e a Dio. Ed Elia riesce ad essere obbediente a Dio?
Notiamo anche che Abdia non ha avuto bisogno di pronunciare giuramenti per esprimere la sua fede, ma l'ha testimoniata rischiando la vita per essa, (3 volte il verbo uccidere) mentre Elia ancora una volta al v15 deve pronunciare il suo giuramento: «Per la vita di JHWH degli eserciti,alla cui presenza io sto» al fine di convincere Abdia. Forse perché tutti ritenevano che le sparava sempre molto grosse?
4^ - Elia e re Acab
In questa scena è in gioco il termine "rovina" che in ebraico suona "acor" o "akor" e le cui radicali sono anche quelle di Carmelo.
Questo termine è usato dal redattore perché rimanda alla località di Akor, un luogo maledetto, il cui significato si trova in Gs 7,24 ss. e Gs 6,18ss. (che consigliamo di leggere integralmente) come eziologia di un grande mucchio di pietre che si trovava della valle di Akor.
Brevemente. Quando Giosuè conquista Gerico la città è condannata allo herem, cioè allo sterminio, distruzione totale di abitanti, animali, case e oggetti di ogni genere. Nessuno deve usare qualcosa che provenga da Gerico. Però un certo Acan portò via degli oggetti d'oro e altre cose. Di seguito accade che Israele in una guerriciola perde la battaglia con diversi morti. Giosuè si rivolge al Signore il quale gli rivela che Israele ha peccato perché non ha rispettato lo sterminio. Fatte le dovute ricerche e trovato il colpevole eseguono il giudizio:
Gs 7,24 «Giosuè allora prese Acan di Zerach e l'argento, il mantello, il lingotto d'oro, i suoi figli, le sue figlie, il suo bue, il suo asino, le sue pecore, la sua tenda e quanto gli apparteneva. Tutto Israele lo seguiva ed egli li condusse alla valle di Akor. 25 Giosuè disse: «Come tu hai portato sventura a noi, così il Signore oggi la porti a te!». Tutto Israele lo lapidò, li bruciarono tutti e li uccisero tutti a sassate. 26 Eressero poi sul posto un gran mucchio di pietre, che esiste fino ad oggi. Il Signore allora desistette dal suo tremendo sdegno. Per questo quel luogo si chiama fino ad oggi Valle di Akor».
Quando Elia e Acab si accusano a vicenda di essere la rovina / "akor" di Israele, hanno in mente questo fatto.
E vanno avanti: "la rovina sei tu". No, la rovina sei tu"...
Il risultato dell'incontro, o dello scontro, è la sfida del Monte Carmelo che anch'esso richiama Akor.
Ma, ci chiediamo: Elia non era stato inviato da Dio a re Acab per comunicare l'invio della pioggia?
Elia è profeta fedele a Dio? lui, che dice sempre: "alla cui presenza io sto"?
Certo, il re nella carestia prodotta dalla siccità, non si preoccupa della situazione del popolo, ma dei cavalli, ma Elia cosa fa di diverso dal re?
Lo zelo di Elia ha avuto il sopravvento sul compito ricevuto da Dio; l'annuncio della pioggia si è trasformato in una sfida sanguinosa.
Appendice sulla valle di Akor
Il profeta Osea ritiene che Israele possa abbandonare gli idoli per un intervento di amore appassionato di Dio trasformando la «valle di Akor in porta di speranza» e scrive:
Os 2,16 Perciò, ecco, la attirerò a me, / la condurrò nel deserto / e parlerò al suo cuore.
17 Le renderò le sue vigne /e trasformerò la valle di Akor / in porta di speranza. /Là canterà come nei giorni della sua giovinezza, / come quando uscì dal paese d'Egitto.
18 E avverrà in quel giorno / - oracolo del Signore - / mi chiamerai: Marito mio,
e non mi chiamerai più: Mio padrone.
19 Le toglierò dalla bocca /i nomi dei Baal, / che non saranno più ricordati.
20 In quel tempo farò per loro un'alleanza / con le bestie della terra / e gli uccelli del cielo / e con i rettili del suolo;/ arco e spada e guerra / eliminerò dal paese; / e li farò riposare tranquilli.
21 Ti farò mia sposa per sempre, / ti farò mia sposa / nella giustizia e nel diritto, / nella benevolenza e nell'amore,/ 22 ti fidanzerò con me nella fedeltà / e tu conoscerai il Signore.
23 E avverrà in quel giorno / - oracolo del Signore - / io risponderò al cielo / ed esso risponderà alla terra;
24 la terra risponderà con il grano, / il vino nuovo e l'olio / e questi risponderanno a Izreèl.
25 Io li seminerò di nuovo per me nel paese / e amerò Non-amata; /e a Non-mio-popolo dirò: Popolo mio,
ed egli mi dirà: Mio Dio.
Lettura 7 1Re 18,20 - 40 La sfida del Carmelo
1^ Scena => 18,20 «Acab convocò tutti gli Israeliti e radunò i profeti sul monte Carmelo. 21 Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando danzerete a doppio ritmo? ( Cei: zoppicherete con i due piedi) Se JHWH è Dio, seguitelo! Se invece lo è Baal, seguite lui!». Il popolo non gli rispose nulla. Elia aggiunse al popolo: «Sono rimasto solo, come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono quattrocentocinquanta. 23 Dateci due giovenchi; essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il FUOCO. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il FUOCO.
24 Voi invocherete il nome del vostro dio e io invocherò quello del Signore. La divinità che risponderà concedendo il fuoco è Dio!». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona!».
2^scena => 25 Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi il giovenco e cominciate voi perché siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il FUOCO». 26 Quelli presero il giovenco, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: «Baal, rispondici!». Ma non si sentiva un alito, né una risposta. Quelli continuavano a saltare intorno all'altare che avevano eretto. 27 Essendo già mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo: «Gridate con voce più alta, perché egli è un dio! Forse è soprappensiero oppure indaffarato o in viaggio; caso mai fosse addormentato, si sveglierà». 28 Gridarono a voce più forte e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. 29 Passato il mezzogiorno, quelli ancora agivano da invasati ed era venuto il momento in cui si sogliono offrire i sacrifici, ma non si sentiva alcuna voce né una risposta né un segno di attenzione.
3^ Scena => 30 Elia disse a tutto il popolo: «Avvicinatevi!». Tutti si avvicinarono. Si sistemò di nuovo l'altare del Signore che era stato demolito. 31 Elia prese dodici pietre, secondo il numero delle tribù dei discendenti di Giacobbe, al quale il Signore aveva detto: «Israele sarà il tuo nome». 32 Con le pietre eresse un altare al Signore; scavò intorno un canaletto, capace di contenere due misure di seme. 33 Dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna. 34 Quindi disse: «Riempite quattro brocche d'ACQUA e versatele sull'olocausto e sulla legna!». Ed essi lo fecero. Egli disse: «Fatelo di nuovo!». Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: «Per la terza volta!». Lo fecero per la terza volta. 35 L'ACQUA scorreva intorno all'altare; anche il canaletto si riempì d'ACQUA.
36 Al momento dell'offerta si avvicinò il profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, oggi si sappia che (1) tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che (3) ho fatto tutte queste cose per tuo comando. 37 Rispondimi, JHWH, rispondimi e questo popolo (2)sappia che tu sei JHWH Dio e che converti il loro cuore!».
4^ Scena => 38 Cadde il FUOCO DI JHWH e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. 39 A tal vista, tutti si prostrarono a terra ed esclamarono: «JHWH è Dio! JHWH è Dio!». 40 Elia disse loro: «Afferrate i profeti di Baal; non ne scappi uno!». Li afferrarono. Elia li fece scendere nel torrente Kison, ove li scannò».
Sul Monte Carmelo, che vuol dire "Campo Sacro", sono stati trovati i resti di un santuario che risalgono al 1500 a. C., cioè 250 anni prima dell'Esodo dall'Egitto. Evidentemente un santuario dedicato a qualche divinità antica. Segno che le religioni passano, ma i luoghi sacri restano.
Osserviamo che al nostro redattore piace lavorare con gli elementi cosmici: se nell'episodio di Zarepta c'era una timida allusione al fuoco e nell'episodio precedente dominava l'acqua, in questo pur non mancando il riferimento all'acqua e alla terra, l'elemento risolutore è il fuoco.
È presente anche il modulo strutturale 3+1, cioè 3 scene di cui la più importante è la quarta che apre poi al brano successivo.
1^ Elia e il popolo.
v 21 "doppio passo di danza" oppure "doppio ritmo di danza" (CEI: zoppicherete con due piedi). "Doppio o diviso" vuol dire ballare contemporaneamente due danze cultuali: quella per Baal e quella per JHWH.
v22 "sono rimasto io solo" espressione che sta a dire che i profeti di JHWH sono stati uccisi dalla regina Gezabele o hanno abiurato diventando profeti di Baal o sono andati a casa. Ma non c'erano i cinquanta più cinquanta profeti salvati da Abdia come abbiamo visto nella lettura precedente? Questa è una frase che ritornerà a tempo debito.
In questo brano emergono diverse forme di religiosità:
1- la religiosità militante di Gezabele che non esista a sopprimere gli avversari con la spada e il potere che le dà l'essere regina
2- la religiosità popolare che ha bisogno di segni spettacolari del divino, disposta a mescolare divinità, culti, riti, cioè incline al sincretismo religioso e sempre incapace di fare una scelta univoca.
3- la religiosità di Elia che presenta molti risvolti problematici.
4- la religiosità del re Acab che teoricamente dovrebbe essere il custode dell'Alleanza e invece appare incapace di prendere decisioni perché è sempre succube della moglie.
2^ Preparativi dei profeti di Baal
Le pratiche attuate dai sacerdoti di Baal sono tipiche del mondo pagano: tendono a "forzare" la volontà del dio attraverso rituali magici e violenti che mirano ad appropriarsi della potenza della divinità.
La preghiera biblica è invece offerta da Dio stesso, che addirittura mette a disposizione un formulario di preghiere: il libro dei Salmi; è una preghiera che vuole anzitutto ribadire il "senso della relazione": mi rivolgo ad un Tu che mi è sempre vicino tanto che anche i capelli del capo sono oggetto della sua cura. Il nostro Dio è quello che mette al primo posto l'Alleanza delle quale anche le stesse clausole vengono dopo, perché a Lui preme la "relazione" e chiede sempre di conoscere la Sua volontà per attuarla.
Comunque pur se JHWH è Dio di tutte le creature la preghiera dei profeti di Baal non viene esaudita, tanto che Elia li prende in giro disprezzandoli.
3^ Preparativi di Elia
L' altare fatto con dodici pietre grezze, non toccate da ferro, rimanda agli altari costruiti da Abramo, da Mosè, da Giacobbe; ma Giacobbe non è diventato Israele, che vuol dire "hai lottato con Dio e hai vinto"?
L'acqua sparsa tre volte rimanda può richiamare Lv 1,9 che prescrive il lavaggio delle interiora delle vittima ma in questo caso gioca il ruolo di elemento cosmico.
Osserviamo che per tre volte riempiono il canaletto la cui capacità e "due misure da seme" cioè: 45 x 2= 90 litri d'acqua che in totale fanno 270 litri d'acqua; ma non c'era la siccità?
Osserviamo la preghiera di Elia v36-37. Dio è chiamato ad intervenire per tre motivi:
1- si sappia che tu sei Dio in Israele
2- il popolo sappia che sei JHWH, Dio che conosce il loro cuore.
3- che io Elia, sono il tuo servo e ho fatto questo per tuo comando
Le prime due richieste sono coerenti con il Dio dell'Alleanza, ma l'ultima è una richiesta impertinente perché Dio non gli aveva ordinato di organizzare una sfida, ma di annunciare la fine della siccità e l'invio della pioggia.
Allora anche Elia cerca di forza la volontà di Dio, proprio come i profeti dia Baal.
Siamo di fronte ad una lotta con Dio. Secondo la sua "fede" Dio è presente solo se lui, Elia, appare vittorioso. E se risultasse perdente Dio sarebbe assente?
Ma ci chiediamo: Dio è presente solo nella vittoria? e nella sconfitta? e per i morti ammazzati?
Ancora una volta il lettore implicito è messo con le spalle al muro; deve continuare ad interrogare il testo.
4^ La vittoria di Elia
Con la discesa del fuoco che brucia ogni cosa la sfida risulta vincente. Adesso il popolo è pronto ad acclamare "JHWH è nostro Dio". Una fede abbastanza debole perché fondata sul prodigioso. E infatti segue una scena paradossale o ironica se non fossero anche tragica.
Elia che sgozza i quattrocentocinquanta profeti di Baal. Facciamo qualche conto. Se avesse impiegato un minuto a testa ci sono voluti 450 minuti pari a circa 7 ore e mezza.
E i quattrocento profeti di Asera dove sono finiti?
Ma Elia non era stato mandato da Dio per annunciare l'invio della pioggia?
Forse che Dio gli aveva chiesto di sgozzare quattrocentocinquanta profeti di Baal?
Se Elia agisce così qual è la differenza tra la sua religiosità e quella di gezabele?
Perché lo sgozzamento avviene nel torrente Kison? Ai tempi di Debora, uno di giudici di Israele (anche le donne nell'antico Israele avevano un ruolo importante), nei pressi di quel torrente accadde che il capo dell'esercito nemico fuggito dopo una battaglia venne ucciso da una donna, Debora appunto, mentre il comandante di Israele con tutto l'esercito lo stava cercando (Gdc 4,7ss.). Quindi Kison è luogo di derisione perché una donna ha fatto quello che l'intero esercito non è riuscito a compiere.
Ma con questa citazione il nostro redattore chi vuole prendere in giro?
Altra domanda che chiede una risposta.
Lettura 8 1 Re18,41 - 46 La pioggia
Notiamo che nel brano precedente l'elemento cosmico risolutore è stato il fuoco, in questo sarà l'acqua. Ancora una volta l'agiografo richiama la nostra attenzione su di essi perché più avanti acquisiranno un significato importante.
Dopo la vittoria di Elia sui profeti di Baal e il ritorno (?) del popolo alla fede dei padri, troviamo un breve brano, una sorta di intermezzo composto da tre scene, la quarta essendo tutto il capitolo di 19 che è il centro del Libretto di Elia.
Poiché la sfida del Carmelo ha avuto termine, Elia finalmente comunica a re Acab il motivo per cui aveva chiesto di incontrarlo: "annunciargli l'invio della pioggia". Infatti il messaggio di Dio in 18,1 era: «Va mostrati a re Acab; io invierò la pioggia alla terra». Ma ancora una volta Elia va un po' oltre e dice:
1^ scena => 41 «Elia disse ad Acab: «(1) Sali, mangia e bevi, perché sento un rumore di PIOGGIA torrenziale». 42 Mentre Acab (2) saliva a mangiare e a bere...»
Secondo la parola di Elia la pioggia è imminente, ma non pare che Dio abbia deciso in tal senso e infatti
Elia comincia a preoccuparsi:
2^ scena =>«...Elia (3) salì sulla cima del Carmelo; gettatosi a terra, pose la faccia tra le proprie ginocchia.
43 Quindi disse al suo ragazzo: « (4) Sali, guarda verso il mare». Quegli (5) salì, guardò e disse. «Non c'è nulla!». Elia disse: «Tornaci ancora per sette volte».
44 La settima volta riferì: «Ecco, una nuvoletta, come una mano d'uomo, (6) sale dal mare». Elia gli disse: «(7) Sali a dire ad Acab: Attacca i cavalli al carro e scendi perché non ti sorprenda la PIOGGIA!».
La postura di Elia non viene spiegata dal redattore, ma uno che sta con la testa tra le ginocchia rende l'idea dello stato di drammatico disagio e sconforto in cui si trova: ha annunciato una pioggia torrenziale e questa non arriva.
E per di più Dio tace!
Potremmo anche considerarlo un atteggiamento di umiltà, ma come mai non vi è alcun accenno di preghiera?
Una spiegazione potrebbe essere reperibile nel testo ebraico che riporta sette volte il verbo "salire"; numero che indica pienezza. Che però non sembra avvenga qui. Avevamo già incontrato il tema del "salire" esattamente le parole "piano di sopra" alla lettura 5, che non indicava semplicemente uno spostamento spaziale, ma una qualità spirituale. A maggior ragione in questo caso, "salire" indica qualcosa di più. È solo un annuncio, un breve accenno, che in modo sibillino il redattore butta lì. C'è qualcuno che deve "salire" o deve fare una salita da qualche parte e questo dovrebbe allertare l'attenzione del lettore.
In questo caso è il ragazzo che "sale" ma, forse, non è lui che deve salire.
3^ scena => 45 «Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento; la PIOGGIA cadde a dirotto. Acab montò sul carro e se ne andò a Izrèel (seconda capitale del regno).
46 La mano di JHWH fu sopra Elia che, cintosi i fianchi, corse davanti ad Acab finché giunse a Izrèel».
Finalmente la pioggia arriva e il profeta ritrova tutto il suo vigore tanto da superare nella corsa i cavalli del re.
La scena più che ironica è assurda, ma "la mano di JHWH" sopra Elia" fa pensare che al di là della sua esuberanza che spesso diventa disobbedienza, Dio vede con simpatia questo "Suo" passionale profeta.
Lettura 9 1 Re 19,1-3a Bersabea
1 Re 19,1 «Acab riferì a Gezabele ciò che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti.
2 Gezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: «Gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso te come uno di quelli».
3 Elia, vide [Cei: impaurito], si alzò e se ne andò per mettersi in salvo. Arrivò a Bersabea che si trova in Giuda... »
Elia nella sfida del Carmelo è risultato vincitore alla grande e per di più è arrivata la pioggia che aveva annunciato; il popolo viste tutte queste cose è ritornato alla religione dei padri e così lo possiamo definire "Eroe di JHWH".
Ma Gezabele non è dello stesso parere e, anche in questo caso, re Acab, succube alla moglie, non pensa a proteggere l'uomo di Dio.
La traduzione con "impaurito" è fuori luogo, perché il testo usa il verbo "vedere" e il problema non riguarda la paura, perché giace a tutt'altro livello.
Come al solito il nostro redattore, sempre criptico, ci costringe ad interrogare il testo, meglio, la Bibbia perché riferisce quasi di sfuggita che Elia è andato a Bersabea.
Ora, la vita di Elia era già stata in pericolo quando aveva annunciato la siccità; e Dio l'aveva protetto nascondendolo presso il torrente Cherit e poi a Zarepta di Sidone. Ci dovremmo aspettare che anche in questo caso Dio gli dicesse dove nascondersi. Ma qui non c'è alcuna "Parola" da parte Sua.
Se Elia volesse salvarsi dalla paura prenderebbe la via più breve, il deserto di Damasco, una regione straniera e invece attraversa tutto il Regno del Nord poi tutto il Regno di Giuda per recarsi a Bersabea all'estremo limite Sud delle zona abitata, in prossimità del deserto. È un posto così remoto che in diversi passaggi della Bibbia per indicare tutto Israele si usa la frase "da Dan a Bersabea".
Allora dobbiamo individuare l'orizzonte simbolico legato a questa remota località per capire la vera intenzione di Elia.
►1- Un primo testo riguarda l'eziologia del nome di Bersabea e coinvolge il grande patriarca Abramo.
Gn 21,22 «In quel tempo Abimèlech con Picol, capo del suo esercito, disse ad Abramo: «Dio è con te in quanto fai. 23 Ebbene, giurami qui per Dio che tu non ingannerai né me né i miei figli né i miei discendenti: come io ho agito amichevolmente con te, così tu agirai con me e con il paese nel quale sei forestiero». 24Rispose Abramo: «Io lo giuro». 25 Ma Abramo rimproverò Abimèlech a causa di un pozzo d'acqua, che i servi di Abimèlech avevano usurpato. 26 Abimèlech disse: «Io non so chi abbia fatto questa cosa: né tu me ne hai informato, né io ne ho sentito parlare se non oggi». 27 Allora Abramo prese alcuni capi del gregge e dell'armento, li diede ad Abimèlech: tra loro due conclusero un'alleanza. 28 Poi Abramo mise in disparte sette agnelle del gregge. 29 Abimèlech disse ad Abramo: «Che significano quelle sette agnelle che hai messe in disparte?». 30 Rispose: «Tu accetterai queste sette agnelle dalla mia mano, perché ciò mi valga di testimonianza che io ho scavato questo pozzo».
31 Per questo quel luogo si chiamò Bersabea, (Ber-shevah = giuramento + due) perché là fecero giuramento tutti e due. 32 E dopo che ebbero concluso l'alleanza a Bersabea, Abimèlech si alzò con Picol, capo del suo esercito, e ritornarono nel paese dei Filistei. 33 Abramo piantò un tamerice in Bersabea, e lì invocò il nome di JHWH, Dio dell'eternità. 34 E fu forestiero nel paese dei Filistei per molto tempo».
Allora Bersabea è il luogo dove si pone fine a dei litigi, si stabilisce un'alleanza e, soprattutto, viene invocato il nome di JHWH e resta come segno il tamerice. Il primo passo verso la nascita di un santuario: un semplice albero. Comunque la località diventa un luogo sacro.
► 2- Un secondo brano riguarda l'intero capitolo 22 di Genesi che racconta il sacrificio di Isacco (che raccomandiamo di leggere) in cui ad Abramo è chiesto di sacrificare a Dio il figlio lungamente atteso. Sappiamo come il racconto finisce, e ci preme evidenziare la conclusione:
Gn22,19 «Poi Abramo tornò dai suoi servi; insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea».
Allora Bersabea è il nome di un luogo connesso ad una prova o alla fine di una prova che ha riguardato la fedeltà di Abramo verso Dio.
►3- Anche con Isacco, figlio di Abramo, si ripetono i litigi per l'acqua.
Gn 26,19 «I servi di Isacco scavarono poi nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. 20 Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: «L'acqua è nostra!». Allora egli chiamò Esech il pozzo, perché quelli avevano litigato con lui. 21 Scavarono un altro pozzo, ma quelli litigarono anche per questo ed egli lo chiamò Sitna. 22 Allora si mosse di là e scavò un altro pozzo, per il quale non litigarono; allora egli lo chiamò Recobòt e disse: «Ora JHWH ci ha dato spazio libero perché noi prosperiamo nel paese».
23 Di là andò a Bersabea. 24 E in quella notte gli apparve JHWH che gli disse: «Io sono il Dio di Abramo, tuo padre; / non temere perché io sono con te. / Ti benedirò / e moltiplicherò la tua discendenza / per amore di Abramo, mio servo».
25 Allora egli costruì in quel luogo un altare e invocò il nome Di JHWH; lì piantò la tenda. E i servi di Isacco scavarono un pozzo. [...] 26 Intanto Abimèlech di Gerar era andato da lui, insieme con Acuzzat, suo amico, e Picol, capo del suo esercito... e dissero: «Abbiamo visto che il Signore è con te e abbiamo detto: vi sia un giuramento tra di noi, tra noi e te, e concludiamo un'alleanza con te: 29 tu non ci farai alcun male, come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto se non il bene e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora un uomo benedetto dal Signore». 30 Allora imbandì loro un convito e mangiarono e bevvero. 31 Alzatisi di buon mattino, si prestarono giuramento l'un l'altro, poi Isacco li congedò e partirono da lui in pace. 32 Proprio in quel giorno arrivarono i servi di Isacco e lo informarono a proposito del pozzo che avevano scavato e gli dissero: «Abbiamo trovato l'acqua».
33 Allora egli lo chiamò Sibea: per questo la città si chiama Bersabea fino ad oggi».
Anche in questo caso abbiamo la spiegazione del nome "giuramento+due" o "alleanza tra due", ma abbiamo anche un fatto molto più rilevante: a Bersabea Dio ha parlato ad Isacco rinnovando a lui la promessa fatta ad Abramo suo padre in Gn 12. E Isacco a memoria di questo intervento di Dio costruisce un altare. Viene ribadita la sacralità del luogo e abbiamo l'inizio della costruzione di un santuario.
►4- I capitoli 37-49 di Genesi raccontano la storia di Giuseppe, il figlio di Giacobbe venduto come schiavo, finito in Egitto che dopo molte vicende diventato viceré.
All'arrivo di una carestia tutta la gente di Giacobbe / Israele, invitata da Giuseppe, si trasferisce in Egitto dove c'era cibo in abbondanza; un viaggio pericoloso pieno di incognite e la partenza avviene da Bersabea.
Gn 46:1 «Israele dunque levò le tende con quanto possedeva e arrivò a Bersabea, dove offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco. 2 Dio disse a Israele in una visione notturna: «Giacobbe, Giacobbe!». Rispose: «Eccomi!». 3 Riprese: «Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché laggiù io farò di te un grande popolo. 4 Io scenderò con te in Egitto e io certo ti farò tornare. Giuseppe ti chiuderà gli occhi».
5 Giacobbe si alzò da Bersabea e i figli di Israele fecero salire il loro padre Giacobbe, i loro bambini e le loro donne sui carri che il faraone aveva mandati per trasportarlo. 6 Essi presero il loro bestiame e tutti i beni che avevano acquistati nel paese di Canaan e vennero in Egitto; Giacobbe cioè e con lui tutti i suoi discendenti; 7i suoi figli e i nipoti, le sue figlie e le nipoti, tutti i suoi discendenti egli condusse con sé in Egitto».
Anche in questo caso, a Bersabea, Dio ha parlato a Giacobbe assicurandogli la sua protezione prima di intraprendere quel viaggio difficile e pericoloso insieme tutta la sua gente.
Allora di Bersabea, oltre ad altri significati, l'aspetto più importante è che Dio ha parlato. E questo è il motivo per cui Elia vi si reca. Dopo tutte le vicende narrate, il nostro profeta si trova di fronte al silenzio di Dio.
Il "suo" Dio gli va bene quando punisce i re, castiga i popoli infedeli, trattiene le piogge, produce siccità, fa fuori i nemici, sgozza i sacerdoti idolatri, ecc. ma un Dio che tace è per lui insopportabile.
Elia ha vinto le sue battaglie (sue di Elia), ma ha perso il rapporto con il suo Dio. Allora va a cercarlo là dove ha parlato ai Padri.
Proprio per questo il viaggio dall'estremo Nord all'estremo sud del paese non è una fuga, ma un pellegrinaggio alle sorgenti delle fede in JHWH.
Perdere Dio è un dramma per ogni uomo, ma è la fine per un profeta perché resta una voce che grida senza un perché...
Ma questo agiografo sta parlando di Elia o del suo lettore implicito?
Lettura 10 1 Re 19,3b-8 Bersabea
Il pellegrinaggio a Bersabea è stato un fallimento. Elia non ha ricevuto alcuna "Parola". Nessuna "benedizione"! Dio è rimasto del tutto in "silenzio". Ma il racconto prosegue sempre in modo sibillino e cerchiamo di comprendere la seconda scena.
1Re 19,3a «Giunse a Bersabea di Giuda. Là fece sostare il suo ragazzo.
4 Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra [ginepro]. Desideroso di morire, disse: «Troppo grande JHWH! [Cei: Ora basta, Signore!] Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri».
Il gesto di inoltrarsi per una giornata di cammino nel deserto a chi vive dalle nostre parti non dice nulla, ma per chi conosce la vita del deserto sa bene che camminare per un giorno in quel luogo senz'acqua, perché questo è il senso di "lasciò il suo ragazzo", vuol dire non riuscire più a tornare indietro. È un modo per suicidarsi.
Allora dobbiamo indagare quali possono essere le motivazioni per cui Elia tenta questo gesto estremo.
Possiamo pensare che sia disperato; ha giocato tutta la sua vita nel rapporto con Dio e adesso viene piantato in asso.
Oppure con questo gesto intende costringere Dio ad intervenire e se è così la sua teologia non è tanto diversa da quella dei profeti di Baal che si ferivano, come abbiamo visto nella lettura 7.
In realtà non potremo mai sapere cosa pensasse Elia, ma abbiamo un parallelo biblico che ci permette di cogliere meglio il senso di questa scena.
Abbiamo già avuto modo di dire che la Bibbia contiene poche figure che di tanto in tanto riprende e approfondisce.
Il racconto cui ci riferiamo riguarda il fanciullo Ismaele.
L'antefatto: Dio aveva promesso ad Abramo una discendenza numerosa, ma, già avanti negli anni, l'erede non arrivava. Allora la moglie Sara concede ad Abramo di unirsi alla di lei schiava, Agar (una specie di utero in affitto di quei tempi) e così nasce Ismaele che dovrebbe diventare l'erede futuro. Poiché il figlio della schiava appartiene alla padrona, Ismaele risulta legalmente figlio di Abramo e di Sara. Tutto questo è raccontato in Gn 16, che è opportuno leggere.
Poi a distanza di tempo in modo miracoloso nasce Isacco e la presenza di Ismaele diventa problematica.
Gn 21,8 «Il bambino (Isacco) crebbe e fu svezzato e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato. 9 Ma Sara vide che il figlio di Agar l'Egiziana, quello che essa aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. 10 Disse allora ad Abramo: «Scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco». 11 La cosa dispiacque molto ad Abramo per riguardo a suo figlio. 12 Ma Dio disse ad Abramo: «Non ti dispiaccia questo, per il fanciullo e la tua schiava: ascolta la parola di Sara in quanto ti dice, ascolta la sua voce, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe. 13 Ma io farò diventare una grande nazione anche il figlio della schiava, perché è tua prole». 14 Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un otre di acqua e li diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle; le consegnò il fanciullo e la mandò via. Essa se ne andò e si smarrì per il deserto di Bersabea. 15 Tutta l'acqua dell'otre era venuta a mancare. Allora essa depose il fanciullo sotto un cespuglio 16 e andò a sedersi di fronte, alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: «Non voglio veder morire il fanciullo!». Quando gli si fu seduta di fronte, egli alzò la voce e pianse. 17 Ma Dio udì la voce del fanciullo e un messaggero di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. 18 Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione». 19 Dio le aprì gli occhi ed essa vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'otre e fece bere il fanciullo. 20 E Dio fu con il fanciullo, che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. 21 Egli abitò nel deserto di Paran e sua madre gli prese una moglie del paese d'Egitto».
Osserviamo le similitudini:
Il luogo di partenza sia per Elia che per Ismaele è Bersabea.
Elia è cacciato da Israele per il volere di una regina, esattamente Gezabele. Ismaele è allontanato da Abramo e la sua gente per il volere di Sara, nome che significa: principessa / regina.
La scena per entrambi avviene nel deserto di Bersabea sotto un cespuglio.
Ismaele si lamenta: «...il fanciullo alzò la voce e pianse, ma Dio udì la sua voce...».
Notiamo che Ismaele vuol dire: shemah-El : "El ascolta" come viene spiegato in Gn 16,11. "El" è uno degli antichi nomi di JHWH, quindi: "Dio ascolta" .
Anche Elia esprime una lamentazione: «... prendi la mia vita perché non sono migliore di...».
L'eroe di JHWH che ha fatto tutto quello abbiamo visto adesso si è arreso e addirittura preferisce morire.
Anche per Elia entra in scena un messaggero di JHWH. Tra [] riportiamo la traduzione Cei.
1Re19,5 «Si coricò e si addormentò sotto la ginestra [ginepro]. Allora, ecco un messaggero [angelo] lo toccò e gli disse: «Alzati e mangia!». 6 Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi tornò a coricarsi.
7 Venne di nuovo il messaggero di JHWH [l'angelo del Signore], lo toccò e gli disse: «Su mangia, perché è troppo grande [lungo] per te il cammino».
8 Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l'Oreb».
Era stato un "messaggero" l'inviato della Regina Gezabele v2.
È un messaggero quello che sveglia Elia la prima volta e può essere un messaggero generico, uno che passava di lì ed ha avuto pietà e infatti non viene riconosciuto.
È un "messaggero di JHWH" quello che lo sveglia la seconda volta; adesso Elia riconosce in quel messaggero un inviato di Dio.
Tradurre con "angelo" è sbagliato perché sin dall'inizio ci orienta in modo predefinito, perché per noi "angelo" non è semplice "messaggero", ma un'altra cosa. In ebraico il termine è sempre "malàk", in greco è sempre "angelon" che vuol dire "messaggero" e noi abbiamo importato il termine "angelo" esclusivamente con il significato di "creatura mandata da Dio".
v6 - Abbiamo «una focaccia cotta su pietre roventi» esattamente come la "focaccia" della vedova di Zarepta.
A Zarepta era stata voluta da Elia con prepotenza, qui Elia non chiede nulla, ma è Dio che gliela fa trovare gratuitamente.
v7- La seconda volta è il "messaggero di JHWH" che dice «troppo grande».
Ma cosa è troppo grande?
La strada da percorrere fino all'Oreb?
La strada spirituale che deve far giungere ad una nuova conoscenza del suo Dio?
Questo brano si trova come prima lettura in alcune messe con chiaro riferimento all'Eucaristia, ma se si accentuano eccessivamente le parole "...con la forza datagli da quel cibo..." si rischia di ridurlo ad un gesto magico se non si evidenzia che il dono del pane è accompagnato dalle "parole" dette dal "messaggero di JHWH". Esattamente come accade per l'Eucaristia che viene significata da quello che Gesù compie nei giorni successive: passione, morte e risurrezione.
Qui c'è anche il richiamo dalla manna del deserto di Esodo, anche perché poi seguono i quaranta giorni e le quaranta notti che rimandano, a loro volta, al cammino di Israele nel deserto durato quarant'anni.
Quaranta è il numero simbolico che indica il tempo necessario perché avvenga un cambiamento. Allora anche Elia dovrà cambiare?
v8- Intanto presso quella ginestra riceve un messaggio che lo stravolge: egli è importante agli occhi di Dio quanto Ismaele, quanto Mosè e il popolo nel pellegrinaggio dall'Egitto alla Terra, dalla schiavitù alla libertà.
Allora è forza data da quella focaccia cibo o dalla scoperta che la relazione con Dio sussiste ancora?
Però Elia deve fare un altro passo: deve capire che JHWH non è solo un Dio vincente che si occupa dei suoi nelle situazioni estreme, ma è anche un Dio trascendente, un Dio totalmente altro.
Ma prima deve arrivare all'Oreb.
Lettura 11 1 Re 19,9 - 12 All'Oreb / Sinai Prima parte
Se abbiamo inteso bene l'ultimo versetto della lettura precedente, Elia si è messo in viaggio per un altro pellegrinaggio.
In quaranta giorni di cammino( o di prova?) nel deserto egli giunge al monte Oreb, il nome che le tribù del nord di Israele davano al Sinai, considerato il luogo d'origine della fede jahwista che aveva assunto la funzione di santuario.
Abbiamo già fatto cenno a questi pellegrinaggi, riferendoci a G. F. Ravasi, Esodo, Queriniana, nella lettura 35 del libro di Esodo.
L'Oreb - Sinai è un luogo sacro per eccellenza. È il luogo in cui Mosè ha incontrato Dio che gli ha rivelato il nome dal roveto ardente come narra Es 3. Più tardi ha ricevuto la Legge, le Dieci Parole (Es 19 ss).
È lo stesso luogo in cui, ancora Mosè, ha visto Dio, anche se solo di spalle mentre stava lui "nella caverna".
In prima battuta riportiamo il testo secondo la traduzione Cei.
1 Re 19,9 «Ivi entrò in una caverna per passarvi la notte, quand'ecco il Signore gli disse: «Che fai qui, Elia?». 10 Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita». 11 Gli fu detto: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. 12 Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu: qol demamah daqqah / il mormorio di un vento leggero».
Che il problema di questo brano e sicuramente di tutto il libretto di Elia sia la seconda parte del v 12, in grassetto, lo comprendiamo rapidamente osservando alcune sue traduzioni antiche e moderne.
LXX: voce di una brezza leggera;
Vulgata: sibilus aurae tenuis; sibilo di una aura tenue;
Interconfessionale: come un lieve sussurro;
Troviamo anche: una piccola goccia di voce; una brisa tenue; voce di coloro che lodano in segreto...
Noi seguiamo la proposta di Masson e Borgonovo cercando di rimanere strettamente fedeli alla letteralità del testo ebraico, spiegando i tre vocaboli problematici: qol, demamah, daqqah
- qol, significa: voce, suono
- demamah è un sostantivo derivato dal verbo: divenire o essere silenzioso, divenire o essere immobile, quindi: calmo, silente, silenzioso, tranquillo, ecc., come in:
Sl 107, 29 «Ridusse la tempesta alla calma, / tacquero i flutti del mare».
Se è così dobbiamo tradurre: "voce di silenzio", un ossimoro, cioè l'accostamento nella stessa espressione di due termini aventi significati opposti, come: silenzio assordante; ghiaccio bollente, ecc.
E già questo ci fa dire che siamo di fronte a qualcosa di paradossale perché nella realtà quotidiana i due termini non si presentano mai insieme: o silenzio o suono, così come il ghiaccio non può essere bollente!
Il paradosso poi diventa esplosivo se vi aggiungiamo il terzo termine daqqah come aggettivo del secondo.
- daqqah significa: stritolare, macinare, ridurre in polvere e lo spieghiamo con alcuni esempi tratti dalla Bibbia.
Il ritrovamento della manna nel deserto viene descritta usando due volte il nostro vocabolo:
Es 16,14 «Poi lo strato di rugiada svanì ed ecco sulla superficie del deserto vi era una cosa minuta e granulosa, minuta come è la brina sulla terra».
Più illuminati sono i sogni delle vacche grasse / magre e delle spighe piene / svuotate che Faraone chiede a Giuseppe di interpretare:
Gn 41, 19 «Ed ecco sette altre vacche salirono dopo quelle, deboli, brutte di forma e magre / daqqah: non ne vidi mai di così brutte in tutto il paese d'Egitto. 20 Le vacche magre daqqah e brutte divorarono le prime sette vacche, quelle grasse. [...]
23 Ma ecco sette spighe secche, vuote/ daqqah e arse dal vento d'oriente, spuntavano dopo quelle. 24 Le spighe vuote daqqah inghiottirono le sette spighe belle».
Allora possiamo dire che siamo in presenza di un silenzio non tanto sottile o tenue, ma polverizzato, stritolato, svuotato; possiamo pensarlo come esito di una ricerca, di una preghiera lungamente ripetuta, masticata, biascicata...
Ora, se tutto questo riguarda la teofania a Elia, dobbiamo mantenere i termini il più possibile vicini alla forma originaria perché abbiamo a che fare con un'espressione mistica; e di fronte alla mistica il linguaggio non possiede vocaboli adeguati a comunicarla.
Tentiamo di fare la nostra riflessione seguendo una traduzione il più vicino al testo ebraico
1Re 19,9 «Ivi entrò nella caverna per passarvi la notte, ed ecco una parola di JHWH per lui: «Cosa tu qui, Elia?».
10 Egli rispose: «Sono pieno di zelo per JHWH Dio Zevaot, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di rapirmi la vita».
11 Gli fu detto: «Esci e stai sul monte davanti a JHWH». Ecco, JHWH passò. Ci fu un vento [ruah] impetuoso e gagliarda da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma JHWH vento no.
Dopo il vento ci fu un terremoto, ma JHWH terremoto no.
12 Dopo il terremoto ci fu un fuoco, JHWH fuoco no.
Dopo il fuoco ci fu qol demamah daqqah - voce di silenzio svuotato».
1- Elia entra "nella" caverna, non in "una" caverna; si tratta della caverna che tutti conoscono. È la stessa caverna della teofania sperimentata da Mosè diventata poi un santuario (Vedi letture di Esodo 57, 58, 59).
2- Nel racconto troviamo due elementi essenziali e primordiali: la caverna e la notte.
La caverna è un luogo primordiale inserito dentro la Madre Terra, una sorta di utero originario, all'interno del quale l'uomo ritorna piccolo e si sente protetto anche dalla luce violenta del giorno.
È la prima casa dell'uomo quando ha abbandonato gli spazi ampi e pericolosi della foresta, della savana e del deserto.
Pensiamo a quanti nostri luoghi sacri sono ospitati dentro una grotta a partire da Lourdes, Cornabusa, Pietra di Bismantova, ecc... e forse erano considerati sacri già prima che fossero adottati dal culto cristiano.
Questa esperienza di Elia avviene di notte quando i sensi sono azzerati e il buio favorisce o costringe alla concentrazione su di sé, la riflessione sul proprio essere, sul proprio destino e il mondo diventa qualcosa lontano che incute timore, ma la grotta offre una sorta di guscio protettivo. Non possiamo escludere neanche la sensazione di protezione del bambino all'interno dell'utero materno.
La domanda di Dio ad Elia: «Cosa tu qui, Elia?» implica due aspetti importanti.
1- Il riconoscimento da parte di Dio della sacralità di quel luogo
2- La smentita dei vari giuramenti di Elia fatti nei capitoli precedenti: "per la vita di JHWH alla cui presenza io sto" perché sembra che Dio se lo trovi davanti per la prima volta.
D'altra parte per accedere ad un luogo sacro sono necessarie pratiche di purificazione delle quali il testo non fa cenno. È un tema che abbiamo trattato nella Lettura 46 del libro di Esodo.
La risposta di Elia è una breve sintesi di tutto quello che lui ha fatto per JHWH fino alla crisi di Bersabea:
"Sono rimasto solo io".
1- Qui il lettore implicito dovrebbe ricordarsi di Abdia, il primo ministro del Regno, che nascondeva i profeti di JHWH sotto il naso del re e continuava a fornire loro il cibo.
2- Nella parte finale di questa risposta possiamo cogliere un velato rimprovero, un lamento di Elia verso Dio o meglio, alla sua immagine di Dio. Lamento del tipo: "io ho combattuto per Te facendo fuori i tuoi nemici, ma poi, perseguitato, Tu, "Dio degli eserciti", non ha combattuto per me... e allora non capisco più che Dio sei".
Ma la domanda di Elia non è anche quella del lettore implicito?, cioè la nostra?
Lettura 12 1 Re 19,9 - 12 All'Oreb / Sinai Seconda parte
Alla risposta, lamentazione di Elia, Dio non dà spiegazioni, ma cambia discorso. Ci sono realtà che non possono essere spiegate con parole, possono soltanto essere sperimentate.
1Re 19,11 «Gli disse: «Esci e stai sul monte davanti a JHWH». Ecco, JHWH passò. Ci fu un vento [ruah] impetuoso e gagliarda da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore,
ma JHWH vento no.
Dopo il vento ci fu un terremoto, ma JHWH terremoto no.
12 Dopo il terremoto ci fu un fuoco, JHWH fuoco no.
Dopo il fuoco ci fu qol demamah daqqah - voce di silenzio svuotato».
Non possiamo fare a meno di rilevare l'estrema sinteticità del testo che si esprime in modo icasticamente stringato.
Pensiamo a quello che scriverebbe un giornalista di oggi dopo avere visto passare un presidente qualsiasi.
Qui, in poche parole viene espresso tutto il contenuto della fede dei Padri e condannata categoricamente ogni forma di idolatria.
Notiamo che sono portati in scena tre elementi cosmici: vento, terra e fuoco. Essi erano considerati dai popoli antichi manifestazioni delle divinità o dèi essi stessi.
Ad esempio nella religione greca, da cui deriva parte del nostro orizzonte simbolico, Giove il dio supremo, lanciava il suo fuoco in forma di fulmini che distruggevano tutto quello che incontravano nel loro cammino.
Il dio Vulcano abitava le profondità della terra e di tanto in tanto provocava terremoti che radevano al suolo, case, palazzi seppellendo uomini, animali e cose.
Eolo era il dio dei venti in perenne conflitto con Nettuno, Dio del mare, che scatenavano tempeste capaci di sballottare le navi come palline da pingpong.
Tutto questo dal nostro testo viene lapidariamente azzerato:
«JHWH FUOCO NO JHWH TERREMOTO NO»
Anche il vento è trattato nello stesso modo, ma richiede qualche specificazione perché esso può essere benevolo quando spinge le navi sul mare o porta le nubi cariche di pioggia che dissetano la terra, ma può anche essere distruttivo come nel nostro brano che letteralmente recita:
«Vento (ruah) grande (gadolah) e impetuoso da scuotere le montagne e spaccare le pietre...»
L'aggettivo "grande" nel testo è femminile "gadolah" mentre sarebbe maschile se fosse "gadol", ma in italiano questa differenza viene perduta perché "grande" è immutabile; per conservare qualcosa dell'originale dobbiamo usare un aggettivo maschile e uno femminile che rendiamo con: "Vento impetuoso e gagliarda..."
È ovvio che l'occhiuto esegeta della modernità segna immediatamente come errore di un copista l'applicazione di un aggettivo maschile e un altro femminile allo stesso sostantivo.
In realtà "ruah" è usato tanto al maschile che al femminile, ma in questo caso i due aggettivi di genere diverso, in tensione tra di loro, vogliono suggerire al lettore implicito che qui si trova di fronte ad un esperienza mistica.
Anche perché un vento che sradica alberi, scoperchia tetti, ecc. fa parte dell'esperienza corrente pur se, fortunatamente, poco frequente, ma un vento che fa tremare le montagne e spacca le rocce è del tutto estraneo alla nostra esperienza.
Ora, benché il vento di cui Elia è spettatore sia così fuori del comune, egli non riconosce in esso niente di divino per cui anche per il vento vale:
«JHWH VENTO NO»
Dio non si presenta in alcuna di queste manifestazioni cosmiche
Dio si manifesta ad Elia solo come:
«QOL DEMAMAH DAQQAH VOCE DI SILENZIO SVUOTATO»
Infatti solo a questo punto Elia riconosce la presenza di JHWH.
v13 «Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello v19, uscì e si fermò all'ingresso della caverna.»
Notiamo bene: Elia non vede niente, Elia "udì" dice il testo... Ode una "voce di silenzio...".
Ma che tipo di conoscenza è questa, se Elia si copre il volto con il mantello? perché in questo modo non c'è niente da vedere.
Quella di Elia è un esperienza interiore profonda che non ha più bisogno degli occhi, del tatto, ecc.
Per comprenderne qualcosa bisognerebbe entrare nel mondo di coloro che avendo fatto queste esperienze ne hanno anche scritto: S. Giovanni della Croce, S. Teresa d'Avila e tanti altri. Per uno studio su questo argomento applicato al libretto di Elia, vedi: M. Masson, Elia, l'appello del silenzio, EDB Bologna, 1993.
Per fare un passo in quella direzione si potrebbe, forse, pensare all'amore che una mamma prova per il suo piccolino o quello che provi quando pensi al tuo moroso o alla tua morosa...
Lo senti, ti basta e hai capito tutto!
Lettura 13 1 Re 19,13 ss All'Oreb / Sinai Terza parte 13 -14.18 Il dialogo con Dio
v13- Dopo avere ripreso la capacità sensoriale, in particolare l'udito, Elia esegue l'ordine di Dio ed esce dalla
caverna. Qui sente una voce - qol, che non è più: qol demamah, voce di silenzio, cioè quella dell'estasi perché questa voce gli si rivolge in parole che sono esattamente quelle pronunciate prima:
« Cosa tu qui Elia? Cosa cerchi qui Elia»?
che però è ironica e rompe il silenzio della scena. Adesso Elia può comprender.
E siccome Elia "capisce l'antifona" risponde con lo stesso tono ironico
19,14 «Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di rapirmi [togliermi] la vita».
Elia ripete esattamente le parole del v10 alla quale dovremmo aggiungere qualcosa come "che imbranato; non avevo capito un tubo"! Che è come dire:
«Ora che ti conosco come Dio che è "qol demamah daqqah", voce di silenzio svuotato non ho più bisogno di cercarti nel vento, nel fuoco, nell'aria, nell'ammazzamento degli infedeli... ho capito che Tu sei sempre presente e agisci anche quando sembri assente e io non ti sento... e adesso la mia vita dovrà cambiare».
L'ironia di Elia, o la sua autoironia esprime un giudizio sulla sua vita precedente e soprattutto alla sua attività come "uomo di Dio".
Ma è un'ironia che coinvolge anche il lettore implicito perché se si era identificato con "l'eroe di JHWH" adesso deve prenderne le distanze. Con uno svantaggio rispetto ad Elia. Questi ha fatto esperienza di Dio mentre il lettore implicito dispone soltanto del racconto di quell'esperienza.
Tuttavia anch'egli non è abbandonato a se stesso perché il testo prosegue raccontando la seconda parte della vita del nostro profeta, osservando la quale dovrebbe essere in grado di rilevare quali cambiamenti hanno prodotto nel suo comportamento la nuova conoscenza di Dio.
Però il lettore implicito è costretto a ripercorrere tutto il precedente cammino di Elia confrontandolo con un suo nuovo stile.
Dobbiamo anche segnalare la parola "rapirmi" riferito alla vita, che grammaticalmente non è tanto corretto; indice che c'è in gioco un rapimento.
Il lettore è avvisato!
Saltiamo i vv 15-17 che saranno oggetto della prossima lettura.
19,18 «Io poi mi sono risparmiato in Israele settemila persone, quanti non hanno piegato le ginocchia a Baal e quanti non l'hanno baciato con la bocca».
Il v 18 è un altro colpo basso tirato al nostro profeta che aveva detto «Sono rimasto solo ed essi tentano di rapirmi [togliermi] la vita».
Il numero 7000 è il prodotto di due numeri simbolici: 7 x 1000, vale a dire una pienezza rappresentata dal numero 7 moltiplicata per 1000 che per quella cultura poteva equivalere a: troppo grande per essere misurabile.
Questo significa che le persone rimaste fedeli a JHWH erano una quantità tale che Elia non era stato capace di scoprire; e del resto, non sarebbe stato in grado di farlo. Una per tutti: pensiamo alla vedova di Zarepta, che non era neanche ebrea.
Forse perché il nostro Dio non ha bisogno di appiccicare etichette?
Lettura 14 1 Re 19,15 - 17 All'Oreb / Sinai 13 -18 IV parte La missione di Elia
La teofanie non sono mai fine a se stesse. Una conoscenza di Dio che non tenga conto delle sue opere risulta sterile. Il nostro Dio appare sulla scena biblica anzitutto come "creatore", anzi: "il Creatore". La Bibbia si apre con le parole «In principio Dio creò...». E da subito, sino ad oggi, Egli è impegnato a "curare" la sua creazione in tutte le sue forme, delle quali quella umana è la più fragile e anche la più pericolosa.
In Es 3, quando JHWH chiama Mosè dal roveto ardente è per "mandarlo" in Egitto a liberare il popolo reso schiavo da Faraone. Nelle letture 10 e 11del libro di Esodo abbiamo trattato delle obiezioni di Mosè, appunto, e di altri profeti nell'eseguire il compito loro affidato.
In tutta la Bibbia, forse, c'è solo Maria che risponde con un "sì" incondizionato... E aveva di fronte solo un angelo, non Dio stesso!
Anche ad Elia Dio ha riservato un compito
1Re 19,15 «Il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco; giunto là, ungerai Cazaèl come re di Aram. 16 Poi ungerai Ieu, figlio di Nimsi, come re di Israele e ungerai Eliseo figlio di Safàt, di Abel-Mecola, come profeta al tuo posto. 17 Se uno scamperà dalla spada di Cazaèl, lo ucciderà Ieu; se uno scamperà dalla spada di Ieu, lo ucciderà Eliseo».
In questo modo Dio ha esposto al nostro profeta il Suo progetto di nuova vita e noi dobbiamo verificare se Elia ascolterà o andrà ancora per conto suo.
Anzitutto Dio lo invia nel nord d'Israele nel deserto di Damasco, quindi una vita eremitica di preghiera e riceve anche l'incarico di:
- ungere Cazaèl come re di Aram
- ungere Ieu come re di Israele
- ungere Eliseo come profeta al suo posto
Ma cosa c'entra Cazaèl che regna a Damasco, fuori di Israele e nemico di Israele?
Abbiamo visto (v10, lettura 11) che la risposta alla domanda di Dio "Cosa tu qui Elia"?, conteneva l'accusa a JHWH di non interessarsi di quanto avviene in Israele, ma qui Dio gli annuncia un programma di rivoluzione politica che coinvolge addirittura altri regni. Per il semplice fatto che Dio è il Signore di tutta la terra e della stessa storia, tutta la storia.
Però... C'è un però molto importante che rileviamo direttamente dai testi.
2Re8,7 «Eliseo andò a Damasco. A Ben-Hadàd, re di Aram, che era ammalato, fu riferito: «L'uomo di Dio è venuto fin qui». 8 Il re disse a Cazaèl: «Prendi un dono e va' incontro all'uomo di Dio e per suo mezzo interroga il Signore, per sapere se guarirò o no da questa malattia». 9 Cazaèl gli andò incontro prendendo con sé, in regalo, tutte le cose più squisite di Damasco, con cui caricò quaranta cammelli. Arrivato, si fermò davanti a lui e gli disse: «Tuo figlio, Ben-Hadàd, re di Aram, mi ha mandato da te con la domanda: Guarirò o no da questa malattia?». 10 Eliseo gli disse: «Va' a dirgli: Tu guarirai; ma JHWH mi ha mostrato che egli certamente morirà». 11 Poi, con sguardo fisso, si irrigidì a lungo; alla fine l'uomo di Dio si mise a piangere. 12 Cazaèl disse: «Signor mio, perché piangi?». Quegli rispose: «Perché so quanto male farai agli Israeliti: brucerai le loro fortezze, ucciderai di spada i loro giovani, sfracellerai i loro bambini, sventrerai le loro donne incinte». 13 Cazaèl disse: «Ma che sono io tuo servo? Un cane potrebbe attuare questa grande predizione?». Eliseo rispose: «Il Signore mi ha mostrato che tu diventerai re di Aram». 14 Quegli si separò da Eliseo e ritornò dal suo padrone, che gli domandò: «Che ti ha detto Eliseo?». Rispose: «Mi ha detto: Certo guarirai». 15 Il giorno dopo costui prese una coperta, l'immerse nell'acqua e poi la stese sulla faccia del re che morì. Al suo posto divenne re Cazaèl».
Allora Elia non ha unto Cazaèl; al più Eliseo e comunque in un forma che non vede uso di olio.
Anche nel secondo caso Elia non pratica nessuna unzione, essa viene eseguita da un discepolo del discepolo.
2Re 9:1 «Il profeta Eliseo chiamò uno dei figli dei profeti e gli disse: «Cingiti i fianchi, prendi in mano questo vasetto d'olio e va' in Ramot di Gàlaad. 2 Appena giunto, cerca Ieu figlio di Giòsafat, figlio di Nimsi. Entrato in casa, lo farai alzare dal gruppo dei suoi compagni e lo condurrai in una camera interna. 3 Prenderai il vasetto dell'olio e lo verserai sulla sua testa, dicendo: Dice JHWH: Ti ungo re su Israele. Poi aprirai la porta e fuggirai senza indugio». 4 Il giovane andò a Ramot di Gàlaad. 5 Appena giunto, trovò i capi dell'esercito seduti insieme. Egli disse: «Ho un messaggio per te, o capo». Ieu disse: «Per chi fra tutti noi?». Ed egli rispose: «Per te, o capo». 6 Ieu si alzò ed entrò in una camera; quegli gli versò l'olio sulla testa dicendogli: «Dice il Signore, Dio di Israele: Ti ungo re sul popolo di JHWH, su Israele».
Quindi Elia non ha unto né Cazaèl né Ieu.
Ancora una volta Elia è andato per conto suo?
Il proseguimento del racconto mostrerà che Elia non avrebbe mai potuto ungere quei due re, ma lo ha fatto il suo discepolo: Eliseo. Quindi Elia ha agito attraverso la mediazione del discepolo
Allora in questi due gesti Elia non è più lo spaccone che domina la scena, ma sta in posizione defilata; adesso sa che è Dio a muovere le fila della Storia perché Lui ne è il Signore.
E il suo ruolo sarà quello di vivere nel deserto, in solitudine, in preghiera e nel silenzio perché l'azione dei discepoli si efficace.
Lettura 15 Un confronto fra teofanie.
A questo punto dobbiamo sospendere la nostra riflessione dal punto di vista del lettore implicito e confrontare la teofania di Elia con altre teofanie per cercare di coglierne il senso attraverso le similitudini e le differenze.
Riteniamo che questo argomento sia particolarmente importante perché i testi presentano parallelismi e similitudini
che fanno discutere gli studiosi a proposito del ruolo di Mosè ed Elia nella complesso della rivelazione divina.
Se si sottolineano le somiglianza si può vedere nell'opera di Elia un tentativo di riportare la fede alla sue sorgenti: al Sinai / Oreb e alla Legge. Chi enfatizza le differenze sostiene che Elia sia una sorta di anti-Mosè.
Lasciamo agli studiosi le loro diatribe e cerchiamo piuttosto di vedere come Dio alla fine dei conti si rivela ai suoi fedeli.
Per comodità riportiamo i testi biblici coinvolti per facilitarne il confronto.
1Re 19,9 «Ivi entrò nella caverna per passarvi la notte, ed ecco una parola di JHWH per lui: «Cosa tu qui, Elia?». 10 Egli rispose: «Sono pieno di zelo per JHWH Dio Zevaot, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di rapirmi la vita». 11 Gli fu detto: «Esci e stai sul monte davanti a JHWH». Ecco, JHWH passò. Ci fu un vento [ruah] impetuoso e gagliarda da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma JHWH vento no.
Dopo il vento ci fu un terremoto, ma JHWH terremoto no.
12 Dopo il terremoto ci fu un fuoco, JHWH fuoco no.
Dopo il fuoco ci fu qol demamah daqqah - voce di silenzio svuotato».
13 «Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello 19, uscì e si fermò all'ingresso della caverna.»
A questo segue un dialogo con Dio che comprende la comunicazione della missione e del nuovo stile di vita come abbiamo visto nella lettura precedente.
Per quanto riguarda il libro di Esodo le teofanie sono più complesse perché di esse abbiamo tre racconti.
La prima teofania del Sinai: il roveto ardente
Es 3:1 «Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. 2 Il messaggero di JHWH gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. 3 Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». 4 JHWH vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». 5 Riprese: «Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa!». 6 E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si velò il viso, perché aveva paura di guardare verso Dio. [...]
13 Mosè disse a Dio: «Ecco io arrivo dagli Israeliti e dico loro: Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Ma mi diranno: Come si chiama? E io che cosa risponderò loro?». 14 Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». Poi disse: «Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a voi».
In questo caso la teofania è "rivelata e nascosta" dal roveto che arde senza consumarsi.
Alla visione si aggiunge la voce "qol" di Dio che manda Mosè a liberare il popolo dalla schiavitù di Faraone.
Teniamo presenti: il fuoco, la voce "qol", il velamento del viso, il popolo che però è distante centinaia di chilometri.
La seconda teofania del Sinai
Es 19:1 «Al terzo mese dall'uscita degli Israeliti dal paese di Egitto, proprio in quel giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai. 2 Levato l'accampamento da Refidim, arrivarono al deserto del Sinai, dove si accamparono; Israele si accampò davanti al monte. 3 Mosè salì verso Dio e JHWH lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti [...]
9 Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano sempre anche a te». Mosè riferì al Signore le parole del popolo. [...]
13c Quando suonerà il corno, allora soltanto essi potranno salire sul monte». [...]
16 Appunto al terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni, lampi, una nube densa sul monte e un suono / qol fortissimo di tromba: tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore.
17 Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte.
18 Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso JHWH nel fuoco e il suo fumo saliva come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava molto. 19 Il suono / qol della tromba diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce / qol di tuono. [...]
Es 24,15 Mosè salì dunque sul monte e la nube coprì il monte.16 La Gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per sei giorni. Al settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube.
17 La Gloria del Signore appariva agli occhi degli Israeliti come fuoco divorante sulla cima della montagna. 18 Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte quaranta giorni e quaranta notti».
È importante tenere presente che l'ebraico non distingue "voce" da "suono" perché dispone solo di "qol", che abbiamo affiancato all'equivalente italiano. Quindi rispetto ad Elia abbiamo lo stesso sostantivo "qol", ma cambiano radicalmente i suoi aggettivi che là erano "demamah daqqah / silenzio svuotato", ben differenti da quelli del testo di cui sopra.
Tentiamo una sintesi dicendo che questa teofania è narrata dal punto di vista del popolo che sta ai piedi del monte.
La discesa di Dio è "rivelata e nascosta" dalla Nube accompagnata dal consueto corredo di segni cosmici del divino: fuoco, fumo, terremoto, tempesta, ecc. L'armamentario molto amato dal mondo del cinema.
Tutto questo nella teofania di Elia è indice certo dell'assenza di Dio.
Ma allora questa teofania è falsa?
La terza teofania del Sinai / Oreb
Tra la seconda / prima e la terza teofania abbiamo la consegna della Legge e l'episodio del vitello d'oro per cui la terza include anche la richiesta da parte di Mosè di perdonare il peccato d'idolatria commesso dal popolo.
Abbiamo trattato questo argomento nelle letture di Esodo segnalando che probabilmente si tratta della medesima teofania proveniente da tradizioni differenti.
Tuttavia appare chiaramente dal testo che questa seconda e narrata dal punto di vista di Mosè.
Es 33,18 «Mosè gli disse: «Mostrami la tua Gloria!».
19 Rispose: «Farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome: JHWH, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia». 20 Soggiunse: «Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo». 21 Aggiunse il Signore: «Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe: 22 quando passerà la mia Gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. 23 Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere». [...]
Es 34,5 Allora JHWH scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome di JHWH. 6 JHWH passò davanti a lui proclamando: «JHWH, JHWH, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, 7 che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione».
8 Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. 9 Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che JHWH cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa' di noi la tua eredità».
Questa teofania sembra più vicina a quella di Elia; segnaliamo:
=> Mosè nel corso del dialogo chiede a Dio di poterlo vedere Es 33,18.
Elia non ha mai chiesto di vedere Dio, ma per lui è così indispensabile essere in rapporto con Dio e conoscerlo tanto d'avere cercato il suicidio nel deserto (Lettura 10).
=> Mosè non può vedere Dio perché sta nella grotta (v22) e Dio lo copre con la sua mano; tuttavia ne coglie il passaggio.
Elia coglie la Presenza solo nel "qol demamah daqqah / voce di silenzio svuotato", quindi non vede nulla.
=> Entrambi al passaggio di Dio si prostrano fino a terra; in ebraico viene usato lo stesso verbo.
=> Abbiamo già avuto modo di dire che per Mosè ed Elia la teofania avviene presso la medesima caverna
=> Mosè dimora sul Sinai / Oreb quaranta giorni e quaranta notti. Elia cammina quaranta giorni e quaranta notti per arrivare al Sinai / Oreb.
=> Per entrambi la teofania non è fine a se stessa, ma destinata alla missione a favore del popolo. Certo a prima vista Mosè, ex principe egiziano, appare più solidale con il suo popolo, ma anche Elia, pur in forma differente: preghiera, deserto, penitenza, ecc., opera per il suo popolo in silenzio rimanendo fuori scena. Non è più l'Elia del primo periodo.
Però rimane la domanda: le teofanie di Mosè sono meno vere di quella di Elia?
Per rispondere esploriamo il testo biblico e riportiamo altre due teofanie.
La teofania di Isaia nel tempio di Gerusalemme
Is 6:1 «Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto riempivano il tempio. 2 Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali; con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. 3 Proclamavano l'uno all'altro:
«Santo, santo, santo è JHWH Zevaot. / Tutta la terra è piena della sua Kavod / Gloria ».
4 Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. 5 E dissi:
«Ohimé! Io sono perduto, / perché un uomo dalle labbra impure io sono / e in mezzo a un popolo
dalle labbra impure io abito; / eppure i miei occhi hanno visto / il re, il Signore degli eserciti».
6 Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. 7 Egli mi toccò la bocca e mi disse: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, / perciò è scomparsa la tua iniquità / e il tuo peccato è espiato».
8 Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda me!».
Questa come le precedenti avviene in un luogo sacro, là il Sinai, qui il Tempio di Gerusalemme.
Qui non si può assolutamente parlare di silenzio se il canto dei serafini fa tremare gli infissi del tempio. Allora il silenzio non è condizionante.
Anche in questo caso la teofania ha come fine la missione di Isaia nei riguardi del popolo
La teofania di Ezechiele presso il canale Chebar a Babilonia
Ez 1,1 «Il cinque del quarto mese dell'anno trentesimo, mentre mi trovavo fra i deportati sulle rive del canale Chebàr, i cieli si aprirono ed ebbi visioni divine. [...] 4 Io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinìo di fuoco, che splendeva tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come un balenare di elettro incandescente. 5 Al centro apparve la figura di quattro esseri animati, dei quali questo era l'aspetto: avevano sembianza umana 6 e avevano ciascuno quattro facce e quattro ali. [...] 11 Le loro ali erano spiegate verso l'alto; ciascuno aveva due ali che si toccavano e due che coprivano il corpo. 12 Ciascuno si muoveva davanti a sé; andavano là dove lo spirito li dirigeva e, muovendosi, non si voltavano indietro.
13 Tra quegli esseri si vedevano come carboni ardenti simili a torce che si muovevano in mezzo a loro. Il fuoco risplendeva e dal fuoco si sprigionavano bagliori. 14 Gli esseri andavano e venivano come un baleno. [...] 26 Sopra il firmamento che era sulle loro teste apparve come una pietra di zaffiro in forma di trono e su questa specie di trono, in alto, una figura dalle sembianze umane. 27 Da ciò che sembrava essere dai fianchi in su, mi apparve splendido come l'elettro e da ciò che sembrava dai fianchi in giù, mi apparve come di fuoco. Era circondato da uno splendore 28 il cui aspetto era simile a quello dell'arcobaleno nelle nubi in un giorno di pioggia. Tale mi apparve l'aspetto della gloria del Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udii la voce di uno che parlava. [...]
Ez 2:1 Mi disse: «Figlio dell'uomo, alzati, ti voglio parlare». [...] 3 Mi disse: «Figlio dell'uomo, io ti mando agli Israeliti, a un popolo di ribelli, che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri hanno peccato contro di me fino ad oggi. 4 Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: Dice il Signore Dio. 5 Ascoltino o non ascoltino - perché sono una genìa di ribelli - sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro».
Questa teofania è particolarmente importante perché avviene fuori da Israele, in terra d'esilio e in un luogo del tutto profano: il canale Chebàr.
Appaiono simboli cosmici assenti nella teofania elianica: fuoco, vento, manca solo il terremoto.
Anche in questo caso la visione è destinata alla missione di Ezechiele verso il popolo.
Tentativo di conclusione
In conclusione potremmo dire che nessuno può porre limiti o condizioni al modo in cui Dio decide di rivelarsi alle sue creature, altrimenti si corre il rischio di non comprenderlo quando intende comunicare la massima espressione del suo amore: il Figlio inchiodato alla croce.
Lettura 16 1Re 19,19-21 "Unzione" di Eliseo"
1Re 19,19 «Partì di là. Elia incontrò Eliseo figlio di Safàt. Costui arava con dodici paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il decimosecondo. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello (v13). 20 Quegli lasciò i buoi e corse dietro a Elia, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò». Elia disse: «Và e torna, perché sai bene che cosa ho fatto di te».21 Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise; con gli attrezzi per arare ne fece cuocere la carne e la diede alla gente, perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio».
Il lettore implicito ha seguito tutte le vicende di Elia: in Israele, presso il torrente Cherit, a Zarepta, sul Carmelo, a Bersabea, nel deserto e fin sull'Oreb dove ha incontrato Dio.
L'ha visto sempre protagonista, fiero, presuntuoso, antipatico e prevaricatore verso la parola di Dio. Adesso il lettore deve cercare di scoprire se dopo l'esperienza mistica di JHWH in Elia c'è stato un cambiamento nelle sue relazioni verso gli altri e verso Dio.
v19- « partì di là ».
Il brano inizia con una frase telegrafica, ma ricca di interrogativi.
È l'inizio di un nuovo viaggio geografico o di una nuova fase della sua vita?
Se si trattasse di un luogo dovrebbe dire dove ha incontrato Eliseo, ma su questo il testo tace.
D'altra parte Dio in 19,15, l'aveva invitato a tornare nel deserto di Damasco ed Eliseo a suo tempo eserciterà i suoi compiti nel nord d'Israele.
Comunque rimane il dubbio: va bene che ha fatto l'esperienza di Dio, ma Elia è cambiato?
Un'osservazione statistica
Le azioni attuate da Eliseo sono 11; dodici se si contiamo anche il verbo "dire" mentre quelle compiute da Elia sono solo 3.
Già questo ci dice che Elia, pur essendo presente sulla scena, è praticamente immobile e parla una volta sola.
Chi si muove, parla, va e viene è Eliseo.
Questo ci suggerisce che Elia si è defilato?
C'è qualcun altro che agisce... oppure Qualcun Altro?
La presentazione di Eliseo è composta da diversi elementi alcuni dei quali hanno valore simbolico; se non si colgono non si comprende il testo.
L'aratura
Anzitutto, uno che lavora con tutte quelle bestie non è un poveraccio.
Che fossero buoi è improbabile perché gli ebrei non castravano gli animali, forse tori o mucche, con molti dubbi. Però non è velato il riferimento ai due vitelli d'oro di Geroboamo di 1 Re12, con tutto quello comportano (lettura 50 di Esodo).
Arare con molti animali può avere una giustificazione tecnica perché prima dell'adozione del basto, avvenuta nel medioevo, cavalli e buoi erano aggiogati per il collo e poiché il peso del traino si scaricava sulla trachea la spinta era di poco superiore a quella di un uomo che tirasse di spalla. Quindi per esercitare una forza maggiore si moltiplicava il numero degli animali al traino, da cui: bighe, quadrighe, ecc.
Nel nostro caso Eliseo ha a che fare con dodici paia di buoi (24 buoi!?!) e il rimando alle dodici tribù di Israele è più che evidente.
Ora, la relazione di Eliseo con le tribù è espressa dall'aratura.
L'aratro di quei tempi era più o meno un grosso chiodo che, ovviamente, lasciava nel terreno un solco.
In ebraico "aratro" è maschile e "solco" femminile; inoltre gli studiosi ci dicono che nelle lingue orientali, greco compreso, "aratro" e "fallo" hanno le stesse radicali.
Allora possiamo dire che Eliseo viene presentato come uno capace di agire con grande vigore e potenza verso le tribù d'Israele: è un eroe vigoroso che sa il fatto suo.
Se il lettore implicito è attento non può fare a meno di cogliere una sottile allusione all'Elia degli inizi... e anche una sottile ironia.
Il nostro autore come sempre e sibilino perché continua a chiederci di riflettere e non cessare di interrogare il testo.
Mantello
Avevamo già incontrato il mantello al v13 quando Elia se ne servì per coprirsi il volto alla presenza di Dio.
Ora, senza dire una parola, si avvicina ad Eliseo e gli "getta" il suo mantello sulle spalle: una azione simbolica che lo definisce discepolo del maestro.
Già, ma quale maestro, il primo Elia o il secondo? perché il gesto sembra alquanto prepotente. Almeno chiedergli se era d'accordo, no?
D'altra parte Elia aveva ricevuto da Dio il compito di "ungere" Eliseo quale suo discepolo. Ora comprendiamo che quell'unzione era intesa in senso lato perché in realtà si tratta di elezione. Infatti in tutta la Bibbia non si parla mai di ungere un profeta. Un profeta è chiamato da Dio senza approvazione di nessuna autorità,
La reazione di Eliseo.
Eliseo chiede di baciare i genitori. Non si tratta di indecisione o ripensamento, ma di lasciare un tipo di vita e di famiglia che non saranno più suoi.
Egli sa che non potrà più avere una famiglia, una casa, ma dovrà vivere come profeta nel deserto: una vita di castità, vissuta nella fraternità dei cosiddetti "figli dei profeti". Una sorta di monachesimo antico; qualcosa come a Qumran.
Su questo argomento è inevitabile il confronto con Luca perché la una Liturgia Eucaristica richiama entrambi in testi.
Lc 9,59 A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, concedimi di andare a seppellire prima mio padre». 60 Gesù replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu va' e annunzia il regno di Dio».
Estrapolare il detto di Gesù dal contesto in cui è stato pronunciato e porlo in opposizione al congedo di Eliseo quasi considerandolo acqua fresca in confronto a quello suggerito da Gesù, non è corretto.In realtà il gesto di Eliseo è un segno di rottura radicale con la vita precedente e lo stesso Gesù non intende mettere in conflitto la famiglia d'origine con la vocazione alla sequela, ma tende a sottolineare in modo paradossale le esigenze del Regno. Ma appunto "paradossale"!Infatti nei Vangeli troviamo un altro modo di Gesù di considerare i rapporti con i genitori:
Mc 7,5 «Quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani immonde?». 6 Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: Questo popolo mi onora con le labbra,ma il suo cuore è lontano da me.
7 Invano essi mi rendono culto,insegnando dottrine che sono precetti di uomini.8 Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». 9 E aggiungeva: «Siete veramente abili nell'eludere il comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione. 10 Mosè infatti disse: Onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. 11 Voi invece dicendo: Se uno dichiara al padre o alla madre: è Korbàn, cioè offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me, 12 non gli permettete più di fare nulla per il padre e la madre, 13 annullando così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte».
Ancora una volta dobbiamo richiamare che la Bibbia deve essere valutata nella sua unità e senza prendere spezzoni facendo dire loro quello che vogliamo; lettura, questa, di cui Satana è maestro, come insegnano le tentazioni di Gesù nel deserto.
Rito di passaggio
Quello di Eliseo è un rito di passaggio, una forma rituale di congedo dalla famiglia di origine.
I buoi erano dodici paia ed Eliseo prende i suoi due: ormai non servono più per la sua nuova vita. Adesso egli segue il Dio del deserto, non più il Dio della fecondità della terra e degli armenti. E anche gli attrezzi non servono più.
Più radicale di così!
v21 «fece cuocere» è strano parlare di cuocere e non di fuoco. Forse il fuoco è da un'altra parte e dovrà apparire.
v21 «andò dietro» questo andare è l'atteggiamento del discepolo che segue il Maestro. Anche Gesù dirà a Pietro. "Vade retro".
v 21«si mise al suo servizio» indica un atteggiamento di umiltà e obbedienza nelle tre dimensioni: castità, povertà, obbedienza. E siamo intorno al 800 a.C.
Se tutto questo tiene, allora possiamo dire che questi primi cenni relativi alla vita di Elia dopo l'Oreb, hanno già un tono differente rispetto all'inizio del libretto.
Qui Elia dice una sola frase; il resto del racconto riguarda esclusivamente Eliseo e si parla di cambiare vita, di affrontare il futuro senza garanzie economiche, politiche e sociali, completamente nelle mani di Dio.
Ma riguarda esclusivamente Elia o anche il lettore implicito?
Lettura 17 1 Re21 La vigna di Nabòt 1 Re21 prima scena
Anche nel racconto della "vigna di Nabot" dobbiamo osservare il comportamento di Elia per confrontarlo con quello della prima parte del nostro libretto. Tuttavia protagonista del racconto è la vigna, il cui termine appare per ben dieci volte e pertanto siamo costretti a capire quale significato ha la vigna.
1 Re 21,1 «In seguito avvenne il seguente episodio. Nabot di Izreèl possedeva una vigna vicino al palazzo di Acab re di Samaria. 2 Acab disse a Nabòt: «Cedimi la tua vigna; siccome è vicina alla mia casa, ne farei un giardino verdeggiante (Cei:orto). In cambio ti darò una vigna migliore oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale».
3 Nabòt rispose ad Acab: «Mi maledica JHWH dal cederti l'eredità / nahalat dei miei padri».
4 Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Nabot di Izreèl, che aveva affermato: «Non ti cederò l'eredità dei miei padri». Si coricò sul letto, si girò verso la parete e non volle mangiare. 5 Entrò da lui la moglie Gezabele e gli domandò: «Perché mai il tuo spirito è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare?». 6 Le rispose: «Perché ho detto a Nabot di Izreèl: Cedimi la tua vigna per denaro o, se preferisci, te la cambierò con un'altra vigna ed egli mi ha risposto: Non cederò la mia vigna!».
7 Allora sua moglie Gezabele gli disse: «Tu ora eserciterai il governo su Israele! Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la darò io la vigna di Nabot di Izreèl!».
La teologia della terra
Vediamo subito il contrasto tra il palazzo reale, poiché Acab è il re di Samaria e la vigna di Nabòt del quale si conosce solo il luogo di origine.
Da un lato il lusso sfrenato dall'altro il necessario per una vita decorosa. La vite è una pianta piuttosto delicata che non cresce ovunque, ma è strettamente legata alle condizioni climatiche e alle caratteristiche del terreno. Non puoi impiantarla dove ti pare, ma è puro dono di Dio, tenuto anche conto delle tecniche di coltivazione del tempo.
Il giardino invece è il risultato di molto lavoro umano: richiede molta acqua che in Israele è tutt'altro che abbondante e magari il proprietario ha il capriccio di coltivarci anche piante esotiche che esigono molte cure.
Sono due mondi, due mentalità contrapposte: Acab e Nabòt; Gezabele ed Elia; Dio e Baal.
Acab ha una visione economicista della terra: per lui è un bene economico che può essere comprato, venduto, accresciuto, ecc.
Nabòt ne ha una visione religiosa: la terra è l'eredità dei Padri, secondo quanto prescrive ad esempio:
Nm 36,7 Nessuna eredità tra gli Israeliti potrà passare da una tribù all'altra, ma ciascuno degli Israeliti si terrà vincolato all'eredità della tribù dei suoi padri. 8 Ogni fanciulla che possiede una eredità in una tribù degli Israeliti, si mariterà ad uno che appartenga ad una famiglia della tribù di suo padre, perché ognuno degli Israeliti rimanga nel possesso dell'eredità dei suoi padri 9 e nessuna eredità passi da una tribù all'altra; ognuna delle tribù degli Israeliti si terrà vincolata alla propria eredità nahalat».
Ci sta sotto la teologia della terra
La «Terra per la tua discendenza» è uno dei contenuti della Promessa di Dio ad Abramo (Gn 12,7).
La storia della Salvezza narra anche il cammino che quella "discendenza" ha compiuto per giungere a possedere la Terra che Dio ha stabilito di dare loro «scacciando davanti a te l'Amorreo, il Cananeo, lo Hittita, il Perizzita, l'Eveo, e il Gebuseo» Es 34,11; come abbiamo visto lungo tutta la riflessione sul libro di Esodo.
Allora la Terra è dono di Dio al popolo che Egli ha liberato dalla schiavitù d'Egitto. Conquistata la terra al tempo di Giosuè, essa viene divisa tra le tribù e ogni tribù provvede a distribuirla tra le varie famiglie.
Verso la Terra è prescritto un rapporto speciale sintetizzato molto bene nel secondo racconto della creazione, il più antico, secondo il quale prima che ci fosse l'uomo, la terra era un grande disastro perché non era curata da nessuno.
Per questo Dio crea l'uomo e costruisce il giardino di Eden.
Gn 2,15 «Allora JHWH Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo ABAD servisse (Cei: coltivasse) e lo SHAMAR osservare/custodire».
I due verbi "abad" e "shamar" sono gli stessi da praticare nei confronti della Legge che deve essere "servita" e "custodita/osservata".
Allora il comportamento dell'uomo verso la Terra che ha ricevuto dai Padri, dono di Dio, è quello del servizio e della custodia, perché questo è il comando di Dio. Anche oggi si fa un gran parlare di custodia del creato...!?
Proprio per questo la Terra in quanto eredità non è un bene economico che possa essere scambiato, venduto o acquistato: essa è dono di Dio e segno della sua benedizione data ai Padri e da essi tramandata ai figli, che anche tu devi servire e custodire perché poi la possa dare ai tuoi figli di generazione in generazione: è la loro eredità/ nahlat.
Nabòt ha questo rapporto "religioso" con la sua vigna. Sua o di Dio o della famiglia?
Infatti mette in gioco addirittura una "maledizione".
Acab il re che, ha sposato una principessa fenicia e ha importato culti idolatri, considera la terra un bene economico che si può commerciare. Con un rapporto tra le due destinazioni significativo: la vigna produce un frutto da cui si ricava il vino che per gli ebrei e segno di gioia da condividere con gli amici perché rende gustosa la vita. Bisognerebbe riflettere sul primo miracolo fatto da Gesù a Cana di Galilea. Se si è impegnato, certo spinto dalla madre, a trasformare l'acqua in vino alle nozze di due ragazzi, non è sicuramente per mostrare quanto Lui era bravo, ma perché riteneva che il vino è un elemento importante nella vita dei figli di Adamo.
Se è così è chiaro che tra Acab e Nabòt lo scontro sia inevitabile.
Ricevuto da Nabot il rifiuto allo scambio Acab è amareggiato e non vuole più mangiare. La sua delusione riguarda se stesso, è infatti chiuso in se stesso e non pensa a possibili vie d'uscita. Forse la Legge gli impedisce di ricorrere a soluzioni estreme.
Queste sono trovate da Gezabele, la donna di origine straniera che ha sposato ed è diventata regina. Essa rimprovera il re per la sua arrendevolezza e tira in ballo addirittura la ragion di stato. Nota bene: per un giardino!
Cosi si possono confrontare anche due visioni dello Stato.
Per Israele e, forse, anche per Acab il re governa nel nome di Dio essendone semplicemente il luogotenente mentre per Gezabele il re ha un potere assoluto e incondizionato: nessuna legge, civile o religiosa è sopra di lui. È il modello della monarchia assoluta in uso presso le culture del tempo in cui il re era addirittura considerato un dio.
Notiamo che in questa prima parte Elia è del tutto fuori campo.
Lettura 18 1 Re21,8 -16 La vigna di Nabòt 2a e 3a scena
2a Scena: La soluzione di Gezabele
La depressione di re Acab viene risolta rapidamente dalla moglie, la regina Gezabele.
1 Re 21,8 «Gezabele scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo reale, quindi le spedì agli anziani e ai capi, che abitavano nella città di Nabòt. 9 Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e fate sedere Nabòt in prima fila tra il popolo. 10 Di fronte a lui fate sedere due uomini figli di Belial (Cei:iniqui) che testimonino contro di lui: Hai maledetto Dio e il re! Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia». 11 Gli uomini della città di Nabòt, gli anziani e i capi che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Gezabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedite. 12 Bandirono il digiuno e fecero sedere Nabòt in prima fila tra il popolo. 13 Vennero due uomini, figli di Belial (iniqui), che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabòt davanti al popolo affermando: «Nabòt ha maledetto Dio e il re». Lo condussero fuori della città e lo uccisero lapidandolo. 14 Quindi mandarono a dire a Gezabele: «Nabòt è stato lapidato ed è morto». 15 Appena sentì che Nabòt era stato lapidato e che era morto, disse ad Acab: «Su, impadronisciti della vigna di Nabòt di Izreèl, il quale ha rifiutato di vendertela, perché Nabòt non vive più, è morto». 16 Quando sentì che Nabòt era morto, Acab si mosse per scendere nella vigna di Nabòt di Izreèl a prenderla in possesso».
Osserviamo la spregiudicata grande capacità di intrigo di Gezabele che, scavalcando il re, usa il sigillo regale per attuare il suo piano.
Essa fa leva sul sentimento popolare sempre pronto a trovare un colpevole per ogni tipo di avversità: economica, climatica, sanitaria, magari la semplice influenza, ecc.
Inoltre essa non esita a far uso del sacro e delle religioni per i suoi fini. Organizzare un digiuno collettivo, che è un gesto penitenziale rivolto a Dio, per accusare l'innocente di avere bestemmiato. «Tu hai maledetto Dio e il re» v10.
Gli accusatori e testimoni del processo sono da lei stessa chiamati «Figli di Belial» forse una divinità che potrebbe essere Beelzebul, comunque di una religione che non è quella di JHWH. Usiamo il condizionale perché l'accostamento non è tanto sicuro. Ad ogni modo siamo sempre nell'ambito del sacro.
Nabòt viene lapidato ed essendo condannato, i suoi beni sono confiscati, quindi passano allo Stato e perciò al re.
Ma se si rispettasse la Torah non dovrebbero restare all'interno della tribù e del clan di appartenenza come abbiamo mostrato nella lettura precedente? Per di più colui che dovrebbe fare rispettare questa norma è il re, cioè Acab, dato che in quel tempo nella monarchia sono concentrati il potere legislativo, giudiziario ed esecutivo.
Invece possiamo notare come il re, rimasto a letto abbattuto rifiutandosi di prendere cibo, non si interessa di cosa sia successo a Nabòt, ma va subito a prendere possesso della vigna, v16.
Ma non dovrebbe essere proprio lui il garante della giustizia?
3a scena: l'intervento di Elia
17 «Allora la parola di JHWH avvenne a Elia il Tisbita: 18 «Alzati, recati da Acab, re di Israele, che abita in Samaria; ecco è nella vigna di Nabòt, ove è sceso a prenderla in possesso. 19 Gli riferirai: Così dice JHWH: Hai assassinato e ora usurpi! Per questo dice JHWH: Nel punto ove lambirono il sangue di Nabòt, i cani lambiranno anche il tuo sangue».
20 Acab disse a Elia: «Mi hai dunque colto in fallo, o mio nemico!». Quegli soggiunse: «Sì, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. 21 Ecco ti farò piombare addosso una sciagura; ti spazzerò via. Sterminerò, nella casa di Acab, ogni maschio, schiavo o libero in Israele. 22 Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebàt, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. 23 Riguardo poi a Gezabele il Signore dice: I cani divoreranno Gezabele nel campo di Izreèl. 24 Quanti della famiglia di Acab moriranno in città li divoreranno i cani; quanti moriranno in campagna li divoreranno gli uccelli dell'aria». [.....]
27 Quando sentì tali parole, Acab si strappò le vesti, indossò un sacco sulla carne e digiunò; si coricava con il sacco e camminava a testa bassa.
28 Allora la parola di JHWH avvenne a Elia, il Tisbita: 29 «Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò piombare la sciagura durante la sua vita, ma la farò scendere sulla sua casa durante la vita del figlio».
La terza scena si svolge nuovamente nella vigna di Nabòt.
Qui abbiamo la possibilità di cogliere il nuovo modo d'agire di Elia, ma è necessario rilevare i dialoghi di questi primi versetti.
Dio si rivolge ad Elia e gli dice cosa deve annunciare ad Acab:
"Così gli dirai..." ma poi non troviamo un Elia che parla con Acab magari con: "Così dice il Signore...", ma troviamo subito la risposta di Acab, quasi che Elia non abbia neanche aperto la bocca. Cioè: Dio parla ad Elia e risponde Acab. Come mai?
L'autore vuole significare che ormai la voce di Elia e tutt'uno con quella di Dio, cioè la parola di JHWH ora "avviene" ad Elia ed è immediatamente comunicata ad Acab, sine glossa.
Elia adesso è diventato del tutto trasparente alla parola di Dio. La parola di Dio fagocita Elia, mentre invece nei primi capitoli era la parola di Elia era fatta passare per parola di Dio.
Ora, il contenuto di questa Parola riguarda la pena per il sangue innocente versato che grida vendetta al cospetto di Dio. Le punizioni sono tre:
v 19 i cani leccheranno il tuo sangue
v 29 la morte di ogni maschio della casa di Acab e la fine della sua dinastia come era già accaduto per la dinastia di Geroboamo.
Da ultimo Gezabele che sarà divorata dai cani.
Osserviamo che il castigo non colpisce solo i diretti interessati, ma si allarga anche ai discendenti che non c'entrano per niente.
vv. 27-29: reazione di Acab e controreazione di JHWH
La conclusione del racconto va compresa, a nostro parere, nel contesto del libretto di Elia.
La reazione finale di Acab è simile ad un gesto di lutto ed esprime la sua umiliazione davanti a Dio: Acab rinuncia al proprio "desiderio", la vigna ora non la vuole più: è un lusso che è già costato troppo e si rimette al "desiderio" di Dio.
Notiamo che pentimento e umiliazione di Acab sono pubblici, come pubblico è stato il peccato, mentre il riconoscimento e l'accettazione del suo pentimento non avvengono nel chiasso, ma in segreto, tra Dio ed Elia. È un indizio per cogliere la finalità originaria del racconto: se si vuole essere capaci di governare il "desiderio", bisogna umiliarsi davanti a Dio.
Che il modello dell'apologo sia proprio Acab è infatti il dato sconcertante che fa parte del messaggio del libretto di Elia, anzi forse ne è il centro. Il "buono" non è (soltanto) colui che osserva la legge (= Nabòt), ma è anche il "peccatore" che, provocato dalla parola di grazia, si lascia cambiare da essa e si umilia davanti a Dio.
Possiamo vedere anche in questo un anticipo della "buona notizia" della misericordia, annunciata a partire dalla croce di Gesù?
Se è così il libretto di Elia reca un nuovo messaggio che l'attento lettore implicito dovrebbe essere ormai in grado di cogliere: Dio, mediante la sua azione e la sua paziente attesa è stato capace di cambiare non solo il comportamento di Elia, ma anche quello del re malvagio.
L'autore antico è interessato a mettere in luce il cammino spirituale di un peccatore che si converte e vince il suo "desiderio" umiliandosi davanti a Dio.
Si tratta di una realtà così "sconvolgente" nell'agire di Dio: perdonare un peccatore così rilevante, che il redattore più recente, il deuteronomista del quinto secolo, non è stato in grado di elaborare, infatti gli studiosi ci segnalano che i vv 25-26 sono una glossa tardiva, che abbiamo espunto dal racconto perché ci porterebbero fuori strada.
25 «In realtà nessuno si è mai venduto a fare il male agli occhi del Signore come Acab, istigato dalla propria moglie Gezabele. 26 Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli Amorrei, che il Signore aveva distrutto davanti ai figli d'Israele».
vv 25-26 Questi versetti spezzano la trama del racconto e sono il tentativo di un redattore deuteronomista più tardo che ha cercato di mitigare lo scandalo del "pentimento" di Acab, e del perdono di Dio, di cui si parla nella conclusione, che invece noi possiamo ritenere perfettamente in linea con il personaggio di Elia e con la tradizione più antica.
Il redattore deuteronomista invece, guarda all'episodio della vigna di Nabòt come conferma del principio di "retribuzione": chi agisce male dovrà pagare per il male compiuto. Inoltre, per lui, la parola profetica può essere solo dilazionata nel tempo, ma non annullata: è una sentenza irrevocabile.
Infatti la minaccia avrà il suo compimento in 2 Re 9ss. per Acab e in 2 Re 9,30 per Gezabele, che appunto sono di redazione deuteronomistica.
Per superare la teologia della retribuzione bisognerà attendere Giobbe, il giusto sofferente; ma non è che ai tempi di Gesù quella teologia fosse superata, vedi ad esempio il racconto del cieco nato in Gv 9.
Siamo soddisfatti dell'esito della vicenda?
Acab, che non ha agito direttamente, subisce lo stesso castigo di Gezabele che ha organizzato tutta la macchinazione.
Però il racconto non vuole dare un insegnamento a riguardo della giustizia, ma piuttosto un' istruzione sul desiderio in sé. Il desiderio di Acab, a ben guardare, non è in sé né buono né cattivo, ma una volta liberato, le sue conseguenze sono disastrose. Esso sfugge a chi l'ha partorito e scatena forze non controllabili, che colpiscono anche altri, nel caso i discendenti di Acab oltre a Nabòt.
Ultima considerazione: tre personaggi in gioco: Nabòt, Acab, Gezabele. Nabòt innocente, virtuoso, osservante della Legge, vien condannato ingiustamente e nessuno si occupa più di lui. Proprio come Abele; mentre invece ci si preoccupa di Caino per il quale anche Dio provvede a metterli un segno di protezione sulla fronte (Gn 4,15).
Ma per tutti i Nabòt, gli Abeli e tanti altri innocenti vissuti sulla faccia del pianeta, uccisi anche oggi, in nome di un dio e più in generale "vittime del sacro", Dio cosa fa?
Noi di sicuro sappiamo cosa si è lasciato fare il Figlio... anche lui crocifisso nel nome di Dio! Anche Lui vittima del sacro!
Lettura 19 2 Re 1,2-17 A chi obbedire
Possiamo sintetizzare la qualità del comportamento di Elia visto nella lettura precedente con il termine "obbedienza". Certo, una parola fuori moda nelle comprensione di oggi, ma della quale non dovremmo perdere la ricchezza del significato etimologico che proviene dal latino "ob-audire", cioè ascoltare-per... E l'ascolto, lo shemah, sta alla radice della nostra fede il cui fondamento è: "Dio ha parlato".
Se il problema dell'obbedienza sempre nella lettura precedente è presente in obliquo e riguarda solo Elia, nella lettura presente è messo proprio a tema, come espresso dal titolo: "A chi obbedire".
I vv 1 e 17-18 che sono di redazione deuteronomistica e servono a collegare il nostro racconto al libro di 2 Re e pertanto non li consideriamo.
Osserviamo come l'agiografo ha intrecciato la narrazione con i termini: "scendere" e "salire" insieme a: "messaggero"," messaggeri", "mandare" e "ritornare" che strutturano il racconto.
Tutti elementi che la traduzione italiana, ossessionata dalle "ripetizioni", fa regolarmente perdere.
Il re manda dei messaggeri v2.
Interviene il messaggero di JHWH (Cei: angelo) v3.
Il re manda per tre volte un alto dignitario con cinquanta soldati.
La conclusione è affidata ancora al messaggero di JHWH v15.
Elia sale in v6 e scende in v15.
Prima scena vv 1-8
2Re1,1 «Dopo la morte di Acab Moab si ribellò a Israele.2 Acazia cadde dalla finestra del piano di sopra in Samaria e rimase ferito. Allora mandò messaggeri con quest'ordine: «Andate e interrogate Baal-Zebub, dio di Ekròn, per sapere se guarirò da questa infermità».3 Ora il messaggero di JHWH disse a Elia il Tisbita: «Alzati, và incontro ai messaggeri del re di Samaria. Dì loro: Non c'è forse un Dio in Israele, perché andiate a interrogare Baal-Zebub, dio di Ekròn? 4 Pertanto così dice JHWH: Dal letto, in cui sei salito, non scenderai, ma di certo morirai». Ed Elia se ne andò.
5 I messaggeri ritornarono dal re, che domandò loro: «Perché siete ritornati?».
6 Gli dissero: «Un uomo è salito a incontrarci e ci ha detto: Andate, tornate dal re che vi ha inviati e ditegli: Così dice JHWH: Non c'è forse un Dio in Israele, perché tu mandi a interrogare Baal-Zebub, dio di Ekròn? Pertanto, dal letto, in cui sei salito, non scenderai, ma di certo morirai».
7 Domandò loro: «Com'era l'uomo che è salito a incontrarvi e vi ha detto simili parole?».
8 Risposero: «Era un uomo peloso; una cintura di cuoio gli cingeva i fianchi». Egli disse: «Quello è Elia il Tisbita!».
La caduta da una terrazza di re Acazia, figlio di Acab, segna l'inizio del racconto. L'archeologia ha mostrato che cadute di questo tipo erano frequenti perché usavano costruire torri con terrazze prive di parapetti. Il re "di Israele", ferito, manda a consultare un dio straniero e per di più in una città filistea, Ekròn, ma i messaggeri reali sono intercettati da Elia. Essi non lo riconoscono come uomo di Dio e ancor meno come profeta, tanto che, tornati dal re, parlano semplicemente di "un uomo" vestito in modo strano.
Osserviamo i dialoghi che evidenziano ancora il nuovo stile di Elia il quale riceve il messaggio dal messaggero di JHWH, ma poi non lo troviamo mentre lo riporta ai messaggeri del re, mentre troviamo questi stessi messaggeri che dialogano con il re medesimo. Elia è ormai diventato del tutto trasparente alla Parola di Dio che sembra averlo fagocitato. Infatti non ha più bisogno di fare chiasso perché Dio è "qol demamah daqqah. La sua è ormai perfetta obbedienza.
Notiamo che il comando di Elia: "su tornate dal re che vi ha mandati" è in netto contrasto con il comando regale: essi non sono andati a Ekròn, ma sono tornati a Samaria. Hanno disubbidito al re.
È importante la descrizione che essi fanno di Elia perché è l'unica presente dopo la teofania del Sinai, letteralmente: "un uomo che porta peli", che gli studiosi traducono con "vestito di pelli", "e una cintura di cuoio ai fianchi", cioè un perizoma.
Questi messaggeri descrivono il vestito, ma non ne conoscono il significato: è l'abbigliamento austero e severo di coloro che hanno dedicato tutta la loro vita a Dio, vivendo da eremiti in luoghi deserti, nella preghiera e nella penitenza. Se avessero conosciuto l'aspetto denotativo di quel "vestito di peli" avrebbero riconosciuto il "mantello" che identifica i profeti.
Così, per la seconda volta nel nostro racconto, appare il mantello che avevamo già incontrato nella narrazione dell'unzione di Eliseo. Il lettore è avvisato. Il numero due è simbolo di una mancanza che attende di essere completata; dovrà attendersi la ricomparsa di questo mantello.
Comunque il testo, quasi di sfuggita ci vuole avvertire che chi vuole seguire la via di Elia sa quale stile di vita lo attende.
Seconda scena: tre spedizioni di messaggeri regali
Prima spedizione- 9 «Allora gli mandò il capo di una cinquantina con i suoi cinquanta uomini che salì da lui. Questi andò da lui, che era seduto sulla cima del monte, e gli disse: «Uomo di Dio, il re ti ordina di scendere!». 10 Elia rispose al capo della cinquantina: «Se sono uomo di Dio, scenda il fuoco dal cielo e divori te e i tuoi cinquanta». Scese un fuoco dal cielo e divorò quello con i suoi cinquanta».
Seconda spedizione- 11 «Il re mandò da lui ancora un altro capo di una cinquantina con i suoi cinquanta uomini che salì da lui. Questi andò da lui e gli disse: «Uomo di Dio, il re ti ordina di scendere subito».12 Elia rispose: «Se sono uomo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e divori te e i tuoi cinquanta». Scese un fuoco di Dio dal cielo e divorò quello con i suoi cinquanta».
Terza spedizione- 13 «Il re mandò ancora un terzo capo con i suoi cinquanta uomini che salì da lui. Questo terzo capo di una cinquantina andò, si inginocchiò davanti ad Elia e supplicò: «Uomo di Dio, valgano qualche cosa ai tuoi occhi la mia vita e la vita di questi tuoi cinquanta servi. 14 Ecco è sceso il fuoco dal cielo e ha divorato i due altri capi di cinquantina con i loro uomini. Ora la mia vita valga qualche cosa ai tuoi occhi».
La seconda scena ci sconcerta perché sembra di ritornare al primo Elia che affermava il suo Dio nel compiere ammazzamenti.
Il capo di cinquanta uomini è un personaggio di alto rango nella gerarchia del regno e per di più, qui è seguito da cinquanta uomini, il che significa che il re ritiene importate il profeta, ma lo vuole anche impressionare o impaurire.
L'italiano perde l'imperatività del comando che i primi due messaggeri reali impongono a Elia: «Uomo di Dio il re dice: scendi».
Altrettanto categorica la risposta di Elia: «Se uomo di Dio io, scenda fuoco dal cielo...»
La scena si ripete in modo quasi identico per due volte; notiamo solo che nel primo caso è "fuoco del cielo" e nel secondo "fuoco di Dio".
Non possiamo non rilevare la sottile ironia costituita dall'invio di cinquanta uomini per dire a uno solo, miseramente vestito, di recarsi dal re.
Allo stesso modo rimaniamo colpiti e imbarazzati da tutti qui morti per avere portato l'ambasciata; hanno semplicemente obbedito al re.
Terza scena
15 «Il messaggero di JHWH disse a Elia: «Scendi con lui e non aver paura di lui». Si alzò e scese con lui dal re 16 e gli disse: «Così dice il Signore: Poiché hai mandato messaggeri a consultare Baal-Zebub, dio di Ekròn, come se in Israele ci fosse, fuori di me, un Dio da interrogare, per questo, dal letto, su cui sei salito, non scenderai, ma certamente morirai».
17 Difatti morì, secondo la predizione fatta dal Signore per mezzo di Elia e al suo posto divenne re suo fratello Ioram, nell'anno secondo di Ioram figlio di Giòsafat, re di Giuda, perché egli non aveva figli.
18 Le altre gesta di Acazia, le sue azioni, sono descritte nel libro delle Cronache dei re di Israele».
Non sappiamo quanto nel racconto vi sia di storico e di didattico e lasciamo il giudizio in sospeso. Cerchiamo invece di cogliere l'insegnamento che vi è contenuto il quale emerge con l'invio della terza spedizione che si presenta con un atteggiamento di sottomissione all'uomo di Dio, della quale l'intervento del messaggero di JHWH ne modifica l'esito.
Elia, finalmente può scendere e non può che comunicare quanto già annuncia al v4.
Allora l'intento del racconto è chiaro: l'autorità di Dio deve prevalere su quella del re; l'obbedienza a Dio precede l'obbedienza al re.
Appendice
Diamo alcune coordinate per riflettere sui morti delle prime due spedizioni. Vedi anche in Glosse: nota esegetica 4 e 5.
1- Quei soldati ubbidivano ad un comando del re e non avrebbero potuto contestarlo e trasgredirlo perché la cultura e la teologia del tempo non avevano ancora guadagnato la prospettiva della responsabilità individuale. Il primo che, timidamente, inizia a trattare l'argomento è il profeta Ezechiele che arriverà tre o quattro secoli dopo.
2- Il fuoco che discende dal cielo e distrugge tutto quello che trova fa parte dell'armamentario religioso delle culture antiche e potrebbe essere solo un elemento narrativo introdotto per inculcare un insegnamento; e allora apparterrebbe al genere letterario didattico.
3- La nostra lettura della Bibbia è di tipo cristiano, cioè rispetta la compatibilità cristologica. Vale a dire per questo caso: il Dio rivelato da Gesù Cristo non manda meteore incandescenti sulla testa della gente, ma "dà il suo sole ai buoni ed ai cattivi e la sua pioggia ai giusti e agli ingiusti".
4- Ci sia consentito un però... Però non dobbiamo dimenticare il tema del giudizio. La parabola di Mt 25 ci ricorda che il cristianesimo è anche questione di vita o di morte.
Lettura 20 2 Re 2,1-7 Verso l'estasi: il maestro e i discepoli.
Anche in questo caso il testo è strutturato nella forma 3+1 di cui la quarta parte è la più importante; esaminiamo le prime tre e lasciamo la quarta alla prossima lettura.
2, 1 «Poi, volendo Dio rapire in cielo in un turbine Elia, questi partì da Gàlgala con Eliseo.
DA GALGALA A BETEL => 2 Elia disse a Eliseo: «Rimani qui, perché JHWH mi manda fino a Betel». Eliseo rispose: «Per la vita di JHWH e per la tua stessa vita, non ti lascerò». Scesero fino a Betel.
3 I figli dei profeti che erano a Betel andarono incontro a Eliseo e gli dissero: «Non sai tu che oggi JHWH ti toglierà il tuo padrone?». Ed egli rispose: «Lo so anch'io. Silenzio!
DA BETEL A GERICO => 4 Elia gli disse: «Eliseo, rimani qui, perché JHWH mi manda a Gerico». Quegli rispose: «Per la vita di JHWH e per la tua stessa vita, non ti lascerò». Andarono a Gerico.
5 I figli dei profeti che erano in Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero: «Non sai tu che oggi JHWH ti toglierà il tuo padrone?». Rispose: «Lo so anch'io. Silenzio!
DA GERICO AL GIORDANO =>6 Elia gli disse: «Rimani qui, perché JHWH mi manda al Giordano». Quegli rispose: «Per la vita di JHWH e per la tua stessa vita, non ti lascerò». E tutti e due si incamminarono.
7 Cinquanta uomini, tra i figli dei profeti, li seguirono e si fermarono a distanza dalla parte opposta; loro due si fermarono sul Giordano».
La Bibbia Cei intitola questo capitolo e i successivi "Il ciclo di Eliseo" e in effetti il ciclo di Elia si interseca con quello di Eliseo, ma il lettore implicito, come sempre, è invitato a scoprire se il discepolo è stato capace di comprendere la via spirituale del maestro.
Le scene sono tutte raccontate come se il protagonista fosse Eliseo, al quale poi si aggiungono i "figli dei profeti" che fanno da "gruppo di confronto". Anche per essi il lettore deve verificare se comprendono la via elianica oppure se sono solo spettatori curiosi.
Elia, come negli altri racconti successivi all'esperienza dell'Oreb / Sinai è sempre passivo, meglio: obbediente e in disparte.
"Figli dei profeti" era il nome che si dava a comunità di persone che avevano fatto la scelta di Dio e vivevano in confraternite come monaci itineranti.
Elia invece segue un'altra strada, un altro stile, perché, come abbiamo visto nella lettura precedente, viveva da solo sulla cima di una montagna e, in altri passaggi, nel deserto. Questa differenza è importante perché la vita di gruppo è nemica del silenzio.
v1 «Volendo Dio sollevare / rapire»... Siamo avvertiti che si tratta di un'esperienza mistica non ottenuta con esercizi più o meno strampalati, ma donata da Dio.
Eliseo è testimone prossimo a quello che accade ed è anche discepolo, cioè uno che deve imparare e segue passo passo il maestro. Avrà imparato?
Dobbiamo già rilevare che ad ogni annuncio ad Eliseo fatto dai figli dei profeti: "Non sai tu che oggi JHWH ti toglierà il tuo padrone?», egli impone il silenzio perché non vuole separarsi dal su maestro.
Il lettore implicito dovrà valutare se questo attaccamento è positivo o pietra d'inciampo.
Le tre tappe
Il percorso fino al Giordano avviene in tre tappe.
Elia, il maestro segue un itinerario che adempie alla volontà di Dio: tre volte viene ripetuto: «JHWH mi manda...».
Sono tre tappe che mettono alla prova anche il discepolo circa la sua decisione di seguire... il maestro o il suo itinerario? Tre tappe di formazione per il discepolo. Supererà l'esame finale?
Tre volte il discepolo ripete il giuramento: «Per la vita di JHWH...». Allora è proprio deciso!
Ma non è lo stesso tipo di giuramento che faceva quello spaccone di Elia, pieno di sé, nei primi capitoli?
Occhio! Il redattore ci vuole invitare a stare attenti al comportamento del discepolo.
Qui appare il ruolo dei gruppi di profeti che per confronto ci permettono di valutare il comportamento di Eliseo.
Questi gruppi di profeti sono attratti dall'aspetto miracolistico di quanto sta per accadere, che invece per Elia sta del tutto su di un secondo piano.
I passaggi Galgala => Betel => Gerico => Giordano rappresentano un cammino progressivo verso est e quindi verso la regione in cui Elia era nato: Galaad. Il Giordano, lì presso il Mar Morto è anche in assoluto il punto più basso della terra: più di 400 m sotto il livello del mare. Non sappiamo se allora erano in grado di sapere che fosse sotto il livello del mare ma comunque sapevano che era il punto più basso della regione.
È anche la direzione opposta a quella di Giosuè e Mosè che avevano guidato il popolo da est verso ovest per raggiungere la Terra Promessa, quindi una antientrata.
È un cammino verso il luogo da cui "nasce" il sole. Allora c'è una nuova nascita?
Galgala, Betel, Gerico, erano i luoghi di importanti santuari, dove erano avvenuti fatti rilevanti per la storia della salvezza, allora si deve tener conto del richiamo spirituale di quei luoghi... allora non un semplice itinerario geografico, ma un cammino spirituale.
Infatti ad ogni spostamento Elia dice: «... JHWH mi manda a...»
Però non è nello spazio sacro di quei luoghi in cui Elia raggiunge l'estasi, ma nel Giordano. E il Giordano non è un luogo sacro, non è un santuario, anche se importante per la storia d'Israele, ma uno spazio profano come era stato il deserto.
Qualcosa di simile era accaduto a Bersabea quando Elia deluso cercava il suo Dio... e non l'aveva trovato nello spazio del sacro... ma dopo il tentativo di suicidio, nel deserto.
Questo cammino non solo si muove verso Est, là dove nasce il sole, ma è una continua discesa verso il Giordano; interessante rilevare che la radicale di Giordano "jrd" in ebraico è comune quella di "scendere".
La cosa ci dovrebbe sorprendere perché in genere, tutti i luoghi sacri sono costruiti su luoghi elevati, ma qui si va verso il punto più basso di tutta la terra: la depressione del Mar Morto.
Poiché ogni tappa presenta il medesimo schema, ciò che conta è il significato religioso di ogni luogo.
Gàlgala era un santuario costruito a Nord Est di Betel a circa 1000 m sul livello del mare, nel quale si intendeva ricordare l'altro Gàlgala il luogo prossimo al punto in cui gli ebrei provenienti dal deserto, dopo quarant'anni di cammino, avevano attraversato il Giordano. Lì Giosuè aveva posto dodici stele, era stata celebrata la prima pasqua nella Terra promessa ed era stata eseguita una circoncisione di massa perché questo rito nel deserto era stato abbandonato (Gs 3-5). Possiamo dire che l'ubicazione geografica ci interessa relativamente; dobbiamo invece stare al senso religioso che il termine richiama.
Ma non è a Gàlgala che avviene il rapimento.
Betel, letteralmente: "casa di Dio", 500 metri sul livello del mare, è il luogo in cui Giacobbe, in marcia verso Carran per trovare una moglie all'interno del clan di appartenenza, si ferma durante la notte a dormire su di una pietra e riceve la visione di una scala che giunge sino al cielo usata dagli angeli per salire e scendere. Egli erige quella pietra come stele che diventerà l'origine di un santuario famoso (Gn 28,10 ss). Betel è una sorta di ombelico che congiunge la terra al cielo.
Ma non è a Betel che avviene il rapimento
Gerico, si trova nella valle del Giordano ad una decina di km dal fiume e si trova a ca. 300 m sotto il livello del mare. È la prima città in terra di Canaan che gli ebrei conquistarono in modo prodigioso. Le sue possenti mura la rendevano imprendile, ma per intervento divino si frantumarono al suolo al suono della tromba di Israele (Gs 6).
Ma non è a Gerico che avviene il rapimento.
In tutti questi luoghi sacri non avviene nulla di quanto annunciato al primo versetto!
Lettura 21 2 Re 2, 7-17 Il maestro e i discepoli.
L'ultima tappa riguarda una sorta di attraversamento del Giordano, ma non possiamo tralasciare gli echi provenienti da quattro o cinque secoli precedenti. Riportiamo sinteticamente i testi ma è consigliabile leggere anche gli antefatti.
Anzitutto l'attraversamento del Giordano da parte di Giosuè, il condottiero che ha sostituito Mosè:
Gs 3, 14 «Quando il popolo si mosse dalle sue tende per attraversare il Giordano, i sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza camminavano davanti al popolo. 15 Appena i portatori dell'arca furono arrivati al Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca si immersero al limite delle acque [...]16 si fermarono le acque che fluivano dall'alto e stettero come un solo argine a grande distanza [...] mentre quelle che scorrevano verso il Mar Morto, se ne staccarono completamente e il popolo passò di fronte a Gerico. 17 I sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore si fermarono immobili all'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto, finché tutta la gente non ebbe finito di attraversare il Giordano».
Quarant'anni prima un episodio analogo era avvenuto sulla riva del Mar Rosso che tagliava la via di fuga ai figli d'Israele in uscita dall'Egitto:
Es 14,15 «Il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. 16 Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all'asciutto. [...] 21 Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto; le acque si divisero. 22 Gli Israeliti entrarono nel mare asciutto, mentre le acque erano per loro una muraglia a destra e a sinistra».
In entrambi i casi c'è un oggetto usato come mezzo per dividere le acque, ma in realtà ciò accade perché si tratta di azioni compiute su comando di Dio.
Riprendiamo ora il nostro testo lasciato in sospeso nella lettura precedente.
La struttura è sempre quella del 3+1che in questo caso corrisponde ad un primo passaggio incompiuto del Giordano, il momento dell'estasi, un secondo passaggio e l'epilogo.
2 Re 2,7 «Cinquanta uomini, tra i figli dei profeti, li seguirono e si fermarono a distanza dalla parte opposta; loro due si fermarono sul Giordano.
PASSAGGIO => 8 Elia prese il mantello, l'avvolse e percosse con esso le acque, che si divisero di qua e di là; i due passarono sull'asciutto.
9 Mentre passavano, Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te prima che sia rapito lontano da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito diventino miei».
10 Quegli soggiunse: «Sei stato esigente nel domandare. Tuttavia, se mi vedrai quando sarò rapito lontano da te, ciò ti sarà concesso; in caso contrario non ti sarà concesso».
ESTASI => 11 Mentre camminavano conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nella tempesta / saharah (Cei: turbine) verso il cielo.
12 Eliseo mentre stava vedendo gridò: «Padre mio, padre mio, cocchio d'Israele e suo cocchiere».
PASSAGGIO => E non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi.
13 Quindi raccolse il mantello, che era caduto a Elia, e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano.14 Prese il mantello, che era caduto a Elia, e colpì con esso le acque, dicendo: «Dove è JHWH, Dio di Elia?». Quando ebbe percosso le acque, queste si separarono di qua e di là; così Eliseo passò dall'altra parte.
EPILOGO => 15 Visto (Eliseo) da lontano, i figli dei profeti di Gerico dissero: «Lo spirito di Elia si è posato su Eliseo». Gli andarono incontro e si prostrarono a terra davanti a lui.16 Gli dissero: «Ecco, fra i tuoi servi ci sono cinquanta uomini di valore; vadano a cercare il tuo padrone nel caso che lo spirito del Signore l'avesse preso e gettato su qualche monte o in qualche valle». Egli disse: «Non mandateli!».
17 Ma essi insistettero tanto che egli confuso disse: «Mandateli!». Mandarono cinquanta uomini che cercarono per tre giorni, ma non lo trovarono.
18 Tornarono da Eliseo, che stava in Gerico. Egli disse loro: «Non vi avevo forse detto: Non andate?».
vv 8-4 Il Giordano
Osserviamo le azioni di Elia. Avvolge il mantello e colpisce l'acqua. sembra di poter stabilire un parallelo con i testi precedenti di Mosè e Giosuè, ma in questo caso non c'è alcun comando divino che ordini quell'azione e tuttavia attraversano o, più esattamente, entrano nel Giordano a piedi asciutti.
Ma il "mantello avvolto" acquista un altro significato. Abbiamo già visto che il "mantello avvolto su Eliseo" mentre arava lo ha trasformato in discepolo di Elia (1 Re 19,19 Lettura 16).
Qui "mantello avvolto" è inteso come arrotolato, cioè "chiuso in sé", quindi allude ad una via che ha un inizio e una fine. Forse vuole annunciare che la via di Elia è giunta al suo compimento.
I due entrano nel letto del fiume le cui acque si sono divise, ma Elia non lo attraversa perché viene rapito nel bel mezzo del Giordano.
Invece Eliseo al v13 si dice che tornò indietro e solo al v 14 attraversa il Giordano ripetendo il gesto del mantello di Elia ancora avvolto.
Mentre attraversano i due parlano.
Eliseo chiede i due terzi o il doppio dello spirito di Elia che, secondo le usanze ereditarie del tempo, è l'eredità lasciata al primogenito. Cioè, Eliseo chiede di diventare il discepolo primogenito o prediletto del maestro. Però non abbiamo mai incontrato altri discepoli di Elia perché egli dopo l'Oreb, viveva come eremita o monaco in luoghi appartati: nel deserto o sulla cima della montagna, comunque lontano dai luoghi abitati e dalla confusione delle città. Dopo farà così anche Eliseo?
Inoltre se Eliseo è discepolo prediletto allora ci devono essere altri discepoli dei quali il testo non parla.
Il nostro redattore ci costringe ancora a riflettere.
Elia risponde alla richiesta di Eliseo con una profezia v10 «Sarà così se mi vedrai mentre vengo preso da te, altrimenti non sarà». Come dire: "Sei stato esigente nel chiedermi di diventare mio successore, tuttavia se mi vedrai quando sarò rapito lontano da te, cioè, se prenderai parte alla mia visione, ciò ti sarà concesso, in caso contrario non ti sarà concesso".
Questa non è una limitazione, ma il fatto che quanto viene dato ad Elia è disponibile a tutti purché vi sia partecipazione o adesione alla sua via e, in questo caso, nella sperimentazione della stessa visione.
Così mentre camminano nel letto asciutto del fiume Elia viene preso da un carro e cavalli di fuoco.
Ma Eliseo, mentre sta guardando, si mette a gridare perché non vuole separarsi dal maestro... e la visione svanisce ai suoi occhi.
Possiamo dire che la visione viene interrotta dal grido di Eliseo perché ha spezzato il qol demamah daqqah: voce di silenzio sottile.
Gli elementi della visione
Nella visione dell'Oreb avevamo la presenza di tre dei quattro elementi cosmici: aria / vento, terra /terremoto e fuoco, ma Dio era presente solo nel qol demamah daqqah: voce di silenzio sottile. Qui al Giordano è presente anche il quarto elemento: l'acqua. Questo suggerisce che Elia ha guadagnato l'unità del suo io con il tutto e con Dio.
I quattro elementi cosmici simboleggiano l'unità raggiunta
L'acqua è un elemento che tende al basso, il Giordano in questo punto, come abbiamo detto, è il luogo più basso della terra e ricordiamo che la radice della parola "Giordano" è la stessa del verbo "scendere" (jrd).
Gli altri due elementi: fuoco e aria tendono verso l'alto.
Allora l'esperienza mistica di Elia ha guadagnato l'unione degli opposti: egli ha raggiunto l'unità del reale entrando in una dimensione divina che gli ha fatto superare la morte. Come Enoch uno dei patriarchi antidiluviani.
Gn 5,21 «Enoch aveva sessantacinque anni quando generò Matusalemme. 22 Enoch camminò con Dio; dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per trecento anni e generò figli e figlie. 23 L'intera vita di Enoch fu di trecentosessantacinque anni. 24 Poi Enoch camminò con Dio e non fu più perché Dio l'aveva preso».
Ancora Elia viene rapito nel carro di fuoco e nella tempesta "saharah" diversa da quella dell'Oreb che era "ruah". Non è tempesta "castigo" come descritto in altre parti per esempio: Is 29,6; 40,24, ecc. ma si tratta di uno scenario adatto ad una teofania come per Mosè sul Sinai / Oreb o in Gb 38; 40,6.
Ricordiamo che nella teofania dell'Oreb c'era stato il vento ruah, poi terremoto e infine il fuoco, ma Dio non era presente in quei fenomeni. La Sua presenza è nel silenzio: qol demamah daqqah. Comunque mancava l'acqua.
Il simbolismo religioso delle tre tappe
Ora possiamo cercare cogliere il simbolismo religioso contenuto nelle tappe di avvicinamento al Giordano.
Non le pietre rizzate a Galgala Gs 4,19, non la scala di Giacobbe a Betel né l'attraversamento del Giordano tramite l'arca di Gs 3 (per cui la Gloria di Dio sarebbe nell'arca), non l'abbattimento di tutte le mura come a Gerico (Gs 6), ma il coraggio di abbassarsi nell'umiliazione più profonda, cioè il Giordano = scendere, fino al punto di raggiungere l'illuminazione rappresentata dal carro fiammeggiante.
Questa sarebbe l'interpretazione della parziale visione di Eliseo; "parziale" perché il suo grido l'ha interrotta.
"Di Eliseo" in quanto solo lui l'ha vista, almeno in parte, perché i "figli dei profeti si fermarono a distanza dalla parte opposta" v7; e possiamo sempre chiederci se si trattasse di una distanza spaziale o spirituale.
Eliseo poi "lacera in due parti il suo vestito" ed è un segno di lutto. Ma Elia non è mica morto!
I due pezzi di vestito vogliono rimarcare la frattura dell'unità della scena della visione prodotta dal suo grido.
La domanda del lettore implicito e nostra è: Eliseo è l'erede di Elia?
Sì e no. Nella visione non è rimasto fedele alla via di Elia, ma subito dopo, grazie al mantello del maestro e ripetendo la sua azione può attraversare il Giordano all'asciutto.
Ora, se resterà fedele a quella via, Eliseo sarà grande come il maestro, ma quando se ne allontana cade nell'ambiguità.
Ogni volta dovrà decidere se stare con il Dio combattente, il Dio vittorioso che polverizza i nemici, oppure con il Dio dell'Oreb, il Dio del silenzio che è sempre Dio anche di fronte all'apparente sconfitta.
Se è così, la figura di Eliseo da un lato rappresenta il "discepolo" che segue la via di Elia e dall'altro il discepolo che non ha seguito quella via... E noi restiamo nel dubbio!
vv 15-18 Epilogo
Ora sono rimasti i figli dei profeti ed Eliseo con tutta la sua ambiguità.
I figli dei profeti dicono che lo spirito di Elia si è posto su Eliseo perché hanno visto l'acqua del Giordano separarsi quando l'ha percossa con il mantello.
Però del rapimento di Elia non hanno visto nulla perché "stavano lontano sul lato opposto". E siccome non hanno capito niente «si prostrano in terra davanti a Eliseo» (no comment!) e vogliono andare a cercare Elia perché hanno una strana ideo di Dio: prende uno di qua e lo sbatte di là, ne prende un altro e lo scaraventa chissà dove...
v16 Eliseo prima dice no, poi al v17 cambia idea e dice : sì.
v18 quando tornano a mani vuote dice: ve l'avevo detto.
Ambiguo!
Conclusione
Tentiamo di capire se Eliseo ha seguito la via di Elia o è andato per altre strade.
La scena finale lo rappresenta circondato da cinquanta figli dei profeti (o discepoli?) nel chiasso, un quadro radicalmente contrastante con la scena dell'Oreb.
Ma Eliseo è il successore di Elia? Tentiamo una risposta osservando alcuni avvenimenti della sua missione:
Noi possiamo immaginare Eliseo che mogio, mogio si avvia verso Gerico
2Re 2,19 «Gli abitanti della città dissero a Eliseo: «Ecco è bello soggiornare in questa città, come tu stesso puoi constatare, signore, ma l'acqua è cattiva e la terra è sterile».
20 Ed egli disse: «Prendetemi una pentola nuova e mettetevi del sale». Gliela portarono.
21 Eliseo si recò alla sorgente dell'acqua e vi versò il sale, pronunziando queste parole: «Dice JHWH: Rendo sane queste acque; da esse non si diffonderanno più morte e sterilità».
22 Le acque rimasero sane fino ad oggi, secondo la parola pronunziata da Eliseo».
Beh uno che può fare questi miracoli non può non essere da Dio! Però...
2 Re 2,23 «Di lì Eliseo andò a Betel. Mentre egli camminava per strada, uscirono dalla città alcuni ragazzetti che si burlarono di lui dicendo: «Vieni su, pelato; vieni su, calvo!».
24 Egli si voltò, li guardò e li maledisse nel nome di JHWH. Allora uscirono dalla foresta due orse, che sbranarono quarantadue di quei fanciulli.
25 Di là egli andò al monte Carmelo e quindi tornò a Samaria».
Chiaramente un Dio che fa fuori quarantadue ragazzi perché hanno detto "crapa pelada" ad un profeta non ha molto da spartire con il Dio di Gesù Cristo! ( Vedi in Glosse, nota esegetica 5)
In definitiva sembra di poter dire che Eliseo non ha compreso la via di Elia e quindi non è il suo discepolo.
Allora Elia non ha lasciato neanche un discepolo fedele alla sua esperienza?
Certamente sì.
È quello che ha scritto il nostro libretto, ma che non ha tramandato il suo nome perché è stato integralmente fedele al "qol demamah daqqah / voce di silenzio sottile..."
È il discepolo che ha voluto rendere disponibile ad altri, al lettore implicito, a noi, la via elianica. Quella via capace di riconoscere la Parola di Dio nella forma del Silenzio e la Sua Presenza nella forma dell'Assenza (Jüngel).
Due forme che si integrano perfettamente con il Mistero dell'Incarnazione.
