2- Marco
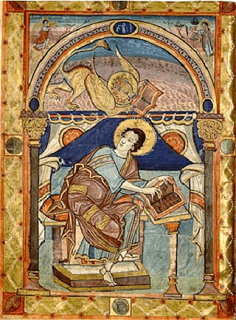
INDICE
1a Parte RICERCA DELLA IDENTITA' DI GESU'
Lettura 1 Il genere letterario "vangelo"
Lettura 2 La questione sinottica
Lettura 3 Il ricupero della memoria di Gesù
Lettura 4 Prologo di Marco: significato di Evangelo
Lettura 5 Prologo di Marco: significato di archè
Lettura 6 La struttura del vangelo di Marco
Lettura 7 Mc 1,2-3 Il proemio di Giovanni - prima parte
Lettura 9 Mc 1,9- 11 Il battesimo di Gesù
Lettura 10 Mc 1,12- 13 La prova nel deserto
Lettura 11 Mc 1,14-15 L'inizio della proclamazione della lieta novella prima parte
Lettura 12 Mc 1,14-15 L'inizio della proclamazione della lieta novella seconda parte
Sezione 1.1 UN INSEGNAMENTO NUOVO Mc 1,14-3,6
Lettura 13 Mc 1,16-20 La chiamata dei discepoli
Lettura 14 Mc 1,21-28 La exousia: un insegnamento nuovo e autorevole
Lettura 15 Mc 1,29-31 La suocera di Simone
Lettura 16 Mc 1,32-34 La fine della "giornata di Cafarnao"
Lettura 17 Mc 1,35-39 Il tema dei miracoli
Lettura 18 Mc 1,40-45 Guarigione di un lebbroso
Lettura 19 Mc 2,1-36 Le controversie galilaiche
Lettura 20 Mc 2,1 -12 La prima controversia galilaica: il paralitico.
Lettura 21 Mc 2,13-17 Le seconda controversia galilaica: la chiamata di Levi
Lettura 22 Mc 2,18-22 La terza controversia galilaica: discussione sul digiuno Prima parte
Lettura 23 Mc 2,18-22 La terza controversia galilaica: discussione sul digiuno Seconda parte
Lettura 24 Mc 2,23-28 Le quarta controversia galilaica: le spighe strappate di sabato
Lettura 25 Mc 3,1-6 La quinta controversia galilaica: guarigione della mano inaridita
Lettura 26 Mc 2,1 - 3,6 Lettura d'insieme delle controversie galilaiche
Lettura 27 Formazione dei vangeli
Sezione 1.2 ISTRUZIONE DEI DISCEPOLI Mc 3,13-8,30
Lettura 28 Sommario
Lettura 29 Mc 3,13-19 L'istituzione dei dodici
Lettura 30 Mc 3,20-21 L'incomprensione dei suoi. Primo gruppo.
Lettura 31 Mc 3,22-30 L'incomprensione degli scribi. Secondo gruppo.
Lettura 32 Mc 3,31- 35 La madre e i fratelli. Terzo gruppo.
Lettura 33 Mc 4,1- 9; 21-23; 26-32 Il discorso in parabole. Prima parte
Lettura 34 Mc 4,10- 13 Il discorso in parabole. Seconda parte
Lettura 35 Mc 4,13- 25 Il discorso in parabole. Terza parte
Lettura 36 Mc 4,35- 41 Dalla predicazione alle opere. La prima traversata del mare
Lettura 37 Mc 5,1- 20 Dalla predicazione alle opere. L'indemoniato di Gerasa.
Lettura 38 Mc 5,21-34 Dalla predicazione alle opere. L'emorroissa. La fede che salva.
Lettura 39 Mc 5,21-24; 35-43 Dalla predicazione alle opere. La figlia di Giairo
Lettura 40 Mc 4,35 - 5,43 Riflessione complessiva sulle quattro opere
Lettura 41 Mc 6,1 - 6a Gesù respinto da Nazaret: la non fede dei nazaretani.
Lettura 42 Mc 6,6b - 8,30 Sintetica escursione della terza sezione della prima parte
Lettura 43 Mc 6,6b - 12 La missione dei discepoli
Lettura 44 Mc 6,14 - 29 Il martirio di Giovanni il Battista
Lettura 45 Mc 6,30- 34 Il deserto: nuova sinagoga.
Lettura 46 Mc 6,34- 44 La prima moltiplicazione dei pani.
Lettura 47 Mc 6,45-56 Non avevano compreso il fatto dei pani
Lettura 48 Mc 6,45-56 Coraggio. Egò eimì / Io sono
Lettura 49 Mc 7,1-13 Impurità legale - Il loro cuore è lontano da me
Lettura 50 Mc 7,14-23 Problemi dietetici
Lettura 51 Mc 7,24-30 La donna siro-fenicia converte Gesù
Lettura 52 Mc 7,31- 37 Guarigione di un sordomuto o l'ascolto della Parola
Lettura 53 Mc 8,1 - 9 Seconda moltiplicazione dei pani
Lettura 54 Mc 8,11 - 13 Un segno dal cielo
Lettura 55 Mc 8,14 - 21 Guardarsi dal lievito dei farisei.
Lettura 56 Mc 8,22 - 26 Il cieco di Betsaida.
Lettura 57 Mc 8,27 - 30 La confessione di Pietro.
Lettura 58 Mc 1,14 - 8,30 Ripresa sintetica della prima parte.
2a Parte SCOPERTA DI GESU' COME FIGLIO DI DIO CROCIFISSO
Sezione 2.1 INSEGNAMENTO SUL MESSIA SOFFERENTE Mc 8,31-10,52
Lettura 59 Mc 8,31- 8,33 Prima predizione della passione e opposizione di Pietro
Lettura 60 Mc 8,34- 9,1 Condizioni della sequela di Gesù
Lettura 61 Mc 9,2- 9,13 La Trasfigurazione
Lettura 62 Mc 9,14- 9,29 Guarigione del fanciullo indemoniato e la fede. Tutto è possibile a chi crede.
Lettura 63 Mc 9,30- 32 Seconda predizione della Passione
Lettura 64 Mc 9,33- 37 Il più grande dei discepoli
Lettura 65 Mc 9,38- 41 I confini del Regno
Lettura 66 Mc 9,41-50 La cura della fede
Lettura 67 Mc 10,1-12 E i due saranno una carne sola
Lettura 68 Mc 10,13-16 Diventare come i bambini
Lettura 69 Mc 10,17-22 Se ne andò afflitto perché aveva molti beni
Lettura 70 Mc 10,23-31 Chi si salva?
Lettura 71 Mc 10,32-34 terzo annuncio della passione
Lettura 72 Mc 10,35-45 La richiesta di Giacomo e Giovanni
Lettura 73 Mc 10,46-52 Il cieco di Gerico
Sezione 2.2 SCONTRO FINALE Mc 11,1-13,37
Lettura 74 Mc 11,1-13,37 Uno sguardo d'insieme
Lettura 75 Mc 11,1-11 Ingresso messianico a Gerusalemme
Lettura 76 Mc 11,12-14 Maledizione del fico
Lettura 77 Mc 11,15-19 Cacciata dei profanatori dal tempio
Lettura 78 Mc 11,20 - 26 Forza della fede della preghiera e del perdono
Lettura 79 Mc 11,27 - 33 Controversia sull'autorità exousia di Gesù
Lettura 80 Mc 12, 1- 12 Seconda controversia: i vignaioli omicidi
Lettura 81 Mc 12, 13- 17 Terza controversia: l'immagine di Cesare
Lettura 82 Mc 12, 18- 27 Quarta controversia: la risurrezione dei morti
Lettura 83 Mc 12, 28- 34 Quinta controversia: il più grande comandamento
Lettura 84 Mc 12, 35- 37 Il Messia più grande di David
Lettura 85 Mc 12, 38- 40 Ipocrisia degli scribi
Lettura 86 Mc 12, 41- 44 L'obolo della vedova povera
Lettura 87 Mc 12, 41- 44 Gesù e il tempio
Lettura 88 Mc 13 Introduzione al discorso escatologico
Lettura 89 Mc 13 Discorso escatologico. Prima parte 13,5-23
Lettura 90 Mc 13, 24-27 Discorso escatologico. La venuta del Figlio dell'Uomo.
Lettura 91 Mc 13,28-36 Discorso escatologico: parte finale
Sezione 2,3 PASSIONE MORTE E RISURREZIONE DEL FIGLIO DI DIO Mc 14,1-16,8
Lettura 92 Mc 14,1-11 L'unzione di Betania
Lettura 93 Mc 14,12-16 Preparazione dell'Ultima Cena
Lettura 94 Mc 14,17-21 Ultima cena - La presenza di traditore
Lettura 95 Mc 14,22 - 26a Ultima cena - Istituzione dell'Eucaristia
Lettura 96 Mc 14,26 - 31 Predizione del rinnegamento di Pietro.
Lettura 97 Mc 14,32 - 42 La solitudine del Getzemani.
Lettura 98 Mc 14,43 - 52 L'arresto di Gesù.
Lettura 99 Mc 14,53 - 65 Il processo religioso.
Lettura 100 Mc 14,54; 66 -72 Il rinnegamento di Pietro.
Lettura 101 Mc 15,1-20 Il processo davanti a Pilato
Lettura 102 Mc 15,20-24 Verso la crocifissione: Simone di Cirene
Lettura 103 Mc 15, 24-32 La crocifissione e le derisioni
Lettura 104 Mc 15,33-41 La crocifissione. Le tenebre.
Lettura 105 Mc 15,33-39 La crocifissione: le morte e la confessione del centurione.
Lettura 106 Mc 15,42-47 La sepoltura di Gesù.
Lettura 107 Mc 16,1-8 Le donne al sepolcro
Lettura 108 IL TEMA DEI DISCEPOLI prima fase
Lettura 109 IL TEMA DEI DISCEPOLI seconda fase
Lettura 110 IL TEMA DEI DISCEPOLI terza fase
Lettura 111 IL TEMA DEGLI OPPOSITORI
Lettura 112 L'OPPOSITORE RADICALE
Lettura 113 RAGIONE DELLE OPPOSIZIONI
Lettura 1 Il genere letterario "vangelo"
Quando uno prende in mano il Vangelo pensa di poter leggere la storia di Gesù.
Però si accorge subito che le storie sono quattro.
Una incomincia da Abramo, un'altra da uno strano profeta che vive nel deserto e il protagonista, Gesù, è già adulto. Un terzo si rivolge ad un certo Teofilo che nessuno conosce e poi parla dell'annuncio della nascita di un bambino che non è Gesù. Il quarto poi fa tutto un discorso tra il filosofico e il teologico che ti lascia smarrito.
E al nostro lettore viene da dire: "Ma almeno potevano mettersi d'accordo".
Lo sconcerto del lettore è certamente giustificato, tanto che già nell'antichità un discepolo del martire S. Giustino di nome Taziano il Siro, 120 - 180 d. C., avverte la necessità di scrivere un'opera chiamata "Diatessaron", che potremmo tradurre: "Composizione" e voleva essere la stesura ordinata dei quattro vangeli o anche una biografia di Gesù. L'opera di Taziano è importante se non altro perché rivela che già attorno alla metà del secondo secolo esisteva il canone dei quattro vangeli.
Però il grande successo delle biografie di Gesù si ebbe nel 1800 soprattutto in area protestante, quando anche i più grandi scrittori credenti o non credenti e anche dei teologi, si impegnarono ciascuno per conto proprio a scrivere la loro "vita di Gesù" o addirittura "la vera vita di Gesù". Ma appunto era solo la "loro", vita di Gesù...
Queste iniziative erano in parte propiziate dalla teologia di quel tempo che ragionava più o meno così: sì, certo gli evangelisti ce l'hanno messa tutta, ma non avevano la preparazione, erano molto rozzi, ex pescatori, non avevano cultura... però adesso ci siamo noi che mettiamo le cose per bene in ordine.
Il filone letterario delle vite di Gesù si è definitivamente esaurito attorno agli anni cinquanta del secolo scorso.
Contemporaneamente però, in forme meno chiassose, magari ristretti in scuole e conventi, proseguivano gli studi esegetici supportati dalla riscoperta e dall'approfondimento delle lingue antiche, aiutati dai ritrovamenti archeologici e dalla messa a punto di metodi "scientifici" per comprendere a fondo la lettura e la formazione degli antichi codici.
In base a questi studi possiamo dire una prima cosa: il disagio provato dal nostro lettore è giustificato perché il genere letterario dei vangeli non è quello biografico.
Oggi sappiamo che ogni opera appartiene ad un determinato genere letterario. Non stiamo a dare la definizione di genere letterario (Wikipedia dedica molte pagine all'argomento), per semplicità elenchiamo alcuni generi: prosa, poesia, lirica, commedia, romanzo, fantascienza, cronaca, ecc. Allora ad esempio: se voglio sapere cosa ha fatto Carlo Magno non andò a sfogliare un romanzo, ma consulterò un libro di storia.
Allora la nostra domanda è: qual è il genere letterario dei vangeli?
La domanda non è oziosa perché nei vangeli sono presenti diversi generi: racconti, detti, proverbi, parabole, esortazioni, ecc., così gli specialisti ci dicono che i vangeli costituiscono un genere letterario proprio, sui generis, cioè appartengono al genere letterario "vangelo".
Se è così lì non ci trovo la biografia di Gesù, anche se parlano di Gesù, nella forma di storie.
Lettura 2 La questione sinottica
Se il nostro lettore insiste nel leggere i vangeli scopre subito, anche dopo una veloce lettura, che molte parti dei primi tre sono uguali.
Sono i vangeli di Matteo, Marco e Luca, chiamati "sinottici" perché se vengono messi appunto in sinossi, cioè uno accanto all'altro, si trova che in gran parte sono corrispondenti.
Gli studi moderni mediante il metodo della critica letteraria, il metodo di storia delle forme, il metodo di storia della redazione e oggi, i metodi strutturalisti e quelli narrativi, sono riusciti, in parte, a capire molte cose tanto delle corrispondenze che delle contraddizioni. Diciamo subito che le contraddizioni, che in epoca illuministica furono viste come prove dell'inaffidabilità dei testi, oggi si spiegano chiaramente confermandone invece la validità degli stessi.
Ora, per dare un'idea dei legami esistenti tra i sinottici, possiamo dire che i versetti comuni sono 330 su 1068 per Matteo, 330 su 661 per Marco e 330 su 1150 per Luca.
Questo porta a dire che i tre evangelisti avessero a disposizione una fonte comune oppure, cosa più verosimile, che Matteo e Luca, redatti più tardi, conoscessero già il vangelo di Marco.
Aggiungiamo che Matteo e Luca hanno molte parti comuni tra loro, ma sconosciute a Marco, il che suggerisce che avessero una fonte comune che non ci è pervenuta, la quale nei commenti è chiamata fonte Q dal tedesco "Quelle" (fonte).
Inoltre ciascuno dei tre vangeli ha delle parti proprie, cioè parti esclusive di Matteo, parti esclusive di Marco e parti proprie di Luca.
Tutto questo lo si comprende in un batter d'occhio se si consulta una sinossi dei vangeli come, ad esempio, quella di A. Poppi, Sinossi dei quattro evangeli, Messaggero, di cui esiste anche l'edizione con testo greco a fronte.
Quanto detto, in modo molto semplificato, ci consente di dire che i vangeli non nascono di botto: un discepolo che si mette a tavolino incominciando a scrivere, magari mentre Gesù parla, ma sono piuttosto il punto d'approdo di diverse tradizioni orali o in parte scritte durante più decenni che poi gli evangelisti hanno messo su carta tenendo conto della situazione ecclesiale vissuta dalle rispettive comunità.
Più esattamente, i vangeli non nascono all'inizio o durante, ma alla fine: all'indomani di quel fatto inaudito e sconvolgente che è stato la risurrezione, la lieta novella, in greco: "euangelion" appunto, a partire dalla domanda: ma chi era, o chi è Gesù? Cosa ha detto? Cosa ha fatto?
Quindi i vangeli iniziano attraverso un lavoro comune di ricupero di fatti, detti, parole, prodigi, controversie, racconti, etc.
La lunghezza dei racconti della passione e la minuzia dei particolari, decisamente sproporzionata rispetto al resto della narrazione, ci dice che questo è stato un argomento che più di ogni altro ha sollecitato l'attenzione dei discepoli.
È abbastanza evidente che è stato un argomento che li ha punti sul vivo nel tentativo di spiegarsi come mai "il profeta potente in parole e opere" fosse morto in quel modo.
Per di più una passione e morte che non li vedeva neutrali dato che uno l'aveva tradito, un altro l'aveva rinnegato tre volte e tutti gli altri avevano tagliato gloriosamente la corda.
Tanto che sotto la croce c'era rimasto solo la madre, un ragazzino e una ex prostituta: personaggi abbastanza tollerati dai soldati per cui non rischiavano granché.
Un senso di colpa che affliggeva i discepoli ulteriormente acuito quando appare loro il Risorto e non dice loro: "Adesso facciamo i conti", ma «pace a voi» Gv 20,19.
Proprio da questi eventi parte appunto il ricupero della memoria.
Lettura 3 Il ricupero della memoria di Gesù
Dobbiamo anzitutto chiarire che a differenza del nostro tempo e fino agli anni '50 la memoria era un organo che funzionava molto bene perché non c'erano ancora "le" memorie: chiavette, cd, dvd, registratori, etc. La gente, fino ad allora, non passava le serate isolata a "dormire" la televisione, ma si trovava in spazi comuni: l'aia d'estate, la stalla d'inverno, la ringhiera, il cortile, il portico, l'osteria e in quei luoghi si parlava, ma soprattutto si raccontava riandando a fatti attuali e passati. Esisteva cioè, l'arte del racconto e del tramandare.
Non è esagerato sostenere che a maggior ragione questo accadeva duemila anni fa quando la lettura e la scrittura erano poco diffuse.
Gli antichi poi avevano messo a punto dei criteri che consentiva loro di memorizzare facilmente i discorsi attraverso parole "gancio", i cosiddetti criteri mnemotecnici. Ad esempio il discorso della montagna di Mt 5, dopo avere enunciato le beatitudini, elenca una lunga serie di ammonizioni o prescrizioni che non hanno alcun legame tra di loro, tanto che un lettore attento può tranquillamente commentare: "ma qui continua a saltare di palo in frasca"!.
L'impressione è giustificata, ma la ragione, suggeriscono gli specialisti, risiede probabilmente nel pre-testo aramaico, perché Gesù parlava in aramaico, e certamente il discorso originario e la sua tradizione aveva le opportune parole gancio, che la successiva traduzione in greco non ha potuto conservare.
La scuola
Non possiamo neanche tralasciare il metodo di insegnamento delle scuole rabbiniche nelle quali gli allievi imparavano a memoria gli insegnamenti del maestro ed è logico pensare che anche il discepolato di Gesù seguisse gli stessi metodi. Ricordiamo che gli discepoli hanno fatto un "corso" durato tre anni e possediamo anche la testimonianza evangelica dell'invio dei settantadue in missione: una specie di esame intermedio (Lc 10,1) con esito positivo, ma solo fino ad un certo punto (Lc 10,17-20).
I kerygma
Altri elementi che favorivano la memorizzazione erano i kerygma, cioè: proclamazioni, prediche molto sintetiche che condensavano in specie di slogan un contenuto cristologico molto elaborato.
Per esempio: «Gesù è il Signore / Kyrios».
Beh, non è cosa da ridere, perché Kyrios è il nome usato per non pronunciare il nome di Dio: JHWH per cui uno che affermava quel kerygma rischiava la pelle.
«Gesù è il Messia» altro kerygma, che a noi non dice granché, ma per un ebreo di quel tempo il Messia, l'Unto, Cristo in greco, era il super-eroe che avrebbe dovuto sistemare tutte le cose: ristabilire il Regno di Davide, far fuori i romani, allargare i confini, instaurare un potere politico indistruttibile che avrebbe dominato il mondo per sempre, insomma realizzare tutte le attese che gli ebrei nutrivano da diversi secoli. Invece arriva questo messia che alla fine si lascia mettere in croce, beh allora era un signor Nessuno. Allora, andare contro corrente e affermare davanti a tutti: «Cristo Signore / Kyrios è risorto», altro kerygma, beh, ci vuole un bel coraggio!
Le lettere di Paolo sono più vicine alla predicazione dei primi anni del cristianesimo. Il brano seguente da l'idea di come Paolo si rapportasse alla sua chiesa di Corinto, in cui la parte in grassetto è un kerygma:
1Cor 2:1 «Anch'io, o fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. 2 Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi "se non Gesù Cristo, e questi crocifisso"»
Conosciamo anche kerygma più ampli che ci danno l'idea di come si svolgesse la predicazione. In questo caso abbiamo Pietro che viene invitato dallo Spirito, durante una visione, ad andare da un centurione romano, cosa interdetta a pii giudei. Raccomandiamo di leggere l'intero capitolo10 di Atti che non possiamo riportare.
At 10,37 «Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; 38 cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. 39 E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, 40 ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che apparisse, 41 non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. 42 E ci ha ordinato di annunziare al popolo e di attestare che egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. 43 Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza: chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome».
Un altro kerygma, forse più noto per via del suo uso liturgico è il cosiddetto inno della lettera ai Filippesi:
Fil 2,5 «Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, / 6 il quale, pur essendo di natura divina, / non considerò un tesoro geloso / la sua uguaglianza con Dio; /7 ma spogliò se stesso, / assumendo la condizione di servo / e divenendo simile agli uomini; / apparso in forma umana, / 8 umiliò se stesso / facendosi obbediente fino alla morte / e alla morte di croce. / 9 Per questo Dio l'ha esaltato / e gli ha dato il nome / che è al di sopra di ogni altro nome; / 10 perché nel nome di Gesù / ogni ginocchio si pieghi / nei cieli, sulla terra e sotto terra; /11 e ogni lingua proclami / che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre».
Il ruolo della comunità e dell'evangelista
Dopo avere brevemente accennato alle premesse possiamo tentare di chiarire come sono nati i vangeli nelle forme che conosciamo.
Nelle chiese circolavano in modo orale e in parte scritta tutti gli elementi di cui abbiamo parlato. Però ogni chiesa incontrava le sue difficoltà, i suoi problemi posti dal contesto sociale e culturale in cui vivevano. Le lettere di Paolo mostrano molto bene la vivacità di queste comunità. Quindi quelle memorie solcavano un ambiente vitale, tecnicamente sitz im leben, ben definito e in alcuni di essi ci sono dei personaggi che decidono di raccogliere queste tradizioni orali e scritte e metterle su carta.
Ora, questa elaborazione risente dell'ambiente in cui le tradizioni o memorie sono vissute e del punto di vista oltre che della teologia del singolo evangelista.
Allora possiamo dire che nel vangelo di Marco c'è dentro un po' di Marco e un po' delle sue chiese nelle interazioni con il mondo circostante e, ovviamente, la stessa cosa vale per gli altri tre evangelisti.
Lettura 4 Prologo di Marco: significato di Evangelo
Mc 1,1« Inizio del vangelo / euaggelion di Gesù Cristo, Figlio di Dio».
Troviamo la parola evangelo già nel primo versetto di Marco, ma cosa significa evangelo.
Evangelo è una parola greca composta da due termini eu-aggelon. (in greco gg si legge: ng)
eu è un avverbio che significa: bene, buono, lieto, conveniente, opportuno, ecc.
"aggelion" significa: notizia, annuncio, messaggio, ecc.
"aggelos" significa messaggero, spesso tradotto con "angelo", che talvolta ci porta fuori strada, perché in italiano "angelo" non è un generico messaggero, ma messaggero di Dio.
Anticamente, ma non solo allora, evangelo, lieta notizia poteva essere l'annuncio di una visita del re, la nascita dell'erede al trono, ecc. a cui seguivano giorni di festa con amnistia per i prigionieri, offerte di cibo e così via.
A noi però interessa conoscere il significato che gli attribuisce Marco e poiché troviamo questo termine in altri sette versetti della sua opera, cerchiamo di coglierne il senso:
Mc 1,14 «Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: 15 «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo».
In questi due versetti la lieta notizia è il contenuto della predicazione di Gesù che annuncia qualcosa di bello e di nuovo a proposito di Dio o meglio, del rapporto di Dio con gli uomini.
Mc 8,35 «...perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà».
Mc 10,29 «Gesù gli rispose: «In verità vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo...».
In questi altri versetti vangelo tende ad identificarsi o si identifica con "causa mia", quindi si stringe il rapporto tra evangelo e Gesù, tra la proclamazione e il proclamatore.
Mc 13,10 «Ma prima è necessario che il vangelo sia proclamato a tutte le genti».
Mc 14,9 «In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà annunziato il vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto».
Mc 16,15 «Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura».
In questi casi vangelo è costituito dalla predicazione dei discepoli e, cosa molto, molto importante, dalla chiesa, nell'oggi di Marco e nel nostro oggi.
Infatti la chiesa non ha altro da fare che predicare il vangelo. E se non fa quello, fallisce il suo compito.
Però resta problematico il primo versetto: cosa vuol dire "vangelo di Gesù Cristo"?
Se la narrazione di Marco riportasse soltanto le parole di Gesù allora potremmo dire che "Vangelo di Gesù Cristo" indichi esclusivamente la di Lui predicazione.
Invece Marco racconta una storia di Gesù: non solo ciò che lui ha detto, ma soprattutto ciò che ha fatto e ha subito.
Infatti i discorsi di Gesù occupano uno spazio di gran lunga inferiore a quello occupato dalle sue vicende.
Allora "vangelo" riguarda la persona stessa di Gesù. Quindi possiamo dire che quel "vangelo di Gesù" del primo versetto è un genitivo oggettivo; e per uscire dall'ambiguità del genitivo potremmo tradurre:
Mc 1,1«Inizio / archè del vangelo che è Gesù Cristo Figlio di Dio».
Se è così, conoscere il vangelo non vuol dire sapere a memoria il testo, magari anche in greco, ma conoscere ed essere in stretto rapporto con Gesù.
Dobbiamo ancora capire perché questa "notizia" è lieta.
In prima battuta potremmo pensare a quanto già anticipato: quell'evento inaudito di un uomo crocifisso, rimasto tre giorni nel sepolcro e poi risuscitato: una novità tanto sconvolgente da cambiare la vita ai testimoni e a coloro che ne hanno sentito parlare. Il che significa per coloro che credono, l'offerta di una vita nuova dopo la morte.
Ma purtroppo nella cultura di oggi il tema della morte non fa presa. La morte è stata bandita dalle nostre conversazioni, e comunque quelli che muoiono sono sempre gli altri. Una riflessione sulla "mia" morte è rigorosamente rimossa. Della morte non ne parla più neanche durante le omelie e men che meno nei funerali.
Però c'è un altro aspetto dell'essere lieta di questa notizia che forse oggi ci tocca più da vicino.
Per mostrarlo ci affidiamo alle parole di Bruno Maggioni, che diceva testualmente:
«Certe volte per capire una cosa bisogna rovesciarla. Se immaginiamo che il Figlio di Dio invece di presentarsi nella forma di Gesù di Nazareth, si fosse presentato nella forma di un altro personaggio: potente, glorioso, imperatore... avreste ancora il coraggio di chiamarla: "lieta notizia"? Sarebbe tutto diverso!
Dio si sarebbe pure incarnato... vero Dio... vero uomo... però il cristianesimo sarebbe capovolto... e non sarebbe più stato"lieta notizia". E chi non avesse avuto la possibilità di entrare nel giro giusto avrebbe potuto dire: "Anche Dio è da quella parte là... viene al mondo e sta con quelli là!"
E invece è "lieta notizia" perché Dio si è fatto uomo... e quel tipo di uomo.
Ecco allora perché occorre la storia di Gesù: bisogna capire quel tipo di uomo».
Lettura 5 Prologo di Marco: significato di archè
Mc 1,1« Archè (inizio) del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio».
Dobbiamo cercare di comprendere il significato di archè, termine greco che apre il vangelo di Marco; molto probabilmente il primo evangelo ad essere composto. Poco prima del 70 d. C.
Chi ha fatto un po' di filosofia sa che "archè" sono i "fondamenti", i "principi primi", ciò da cui dipende tutto il resto.
Potremmo anche accogliere i significati che suggerisce il dizionario, ma a noi interessa sapere cosa intendeva con quel termine la cultura di quel tempo e soprattutto cosa intendeva Marco quando l'ha usato. Pertanto dobbiamo rivolgerci ai significati indicati dagli specialisti che, anzitutto, ci dicono che si tratta di un termine polisemico.
Se è così diventa doveroso esplorare tutti questi significati verificando quale o quali si accordano di più con il testo che segue, il vangelo. Diciamo subito che è saggio mantenerli tutti.
1- Fondamenti. Dire che il vangelo è il fondamento non è sbagliato, ma la lettura precedente ci ha suggerito che il fondamento è Gesù Cristo. Quindi c'è dell'altro.
2- Sommario. Secondo questa accezione il vangelo sarebbe un sommario, un indice; potremmo pensare alla visualizzazione di un percorso che il lettore o il discepolo è invitato a fare. Ma esso non è il tutto.
3- Brogliaccio, canovaccio. Era lo schema consegnato agli attori a riguardo della rappresentazione. Questo implicava che poi ogni attore ci aggiungesse la sua creatività, le sue invenzioni per arricchire il personaggio da interpretare. In questo caso ci sarebbe una parte svolta da Gesù e una parte che compete al discepolo lettore.
4- Rudimenti. Questo significato sembra più interessante perché dice che lo scritto, la lettera, non è il tutto, ma solo una prima sgrossatura che implica ancora una volta, un lavoro aggiuntivo da compiere.
5- Inizio. Se è un inizio di tipo temporale allora abbiamo a che fare con una storia e come tale essa ha un passato remoto, l'Antico Testamento e uno più recente. Il passato recente è appunto ciò che Marco va a raccontare.
Il passato remoto è accennato con sottili richiami che il lettore attento delle Scritture è in grado di catturare.
Infatti subito dopo Marco inizia a parlare di Giovanni Battista che in sé è figura di transizione con l'Antico Testamento, aggiungendo però due versetti che richiamano il deserto, precisamente "una strada nel deserto".
Si tratta di un evidente rimando a due attraversamenti del deserto.
Il più vicino ha riguardato il ritorno in giudea degli esiliati a Babilonia intorno al 500 a.C.
Il più antico si riferisce la traversata compiuta dal popolo ebraico liberato dalla schiavitù d'Egitto, come narra il libro di Esodo, intorno al 1200 a.C.
Però questo "inizio / archè" ha un rimando ancor più suggestivo, esattamente alla prima parola del libro di Genesi, la prima parola che narra la creazione: «In principio / bereshit Dio creò il cielo e la terra», che nella Bibbia greca dei LXX suona: "En archè epoiesen..."
Se è così allora Marco intende suggerire l'inizio di una nuova creazione e comunque l'inizio della storia di Gesù.
Marco è convinto che per conoscere Gesù devi conoscere la sua storia (non certo la sua biografia).
Certo, anche la dottrina, i suoi insegnamenti, ma Gesù non è venuto a portare una dottrina, come pensava la teologia del 1800, bensì a portare una condivisione di vita.
Di insegnare sono tutti bravi, ma farsi carico della fatica di tutti e dare loro speranza per il futuro è tutta un'altra roba. E questo vuol dire "condividere".
Ecco, secondo Marco, per capire questo, bisogna raccontare la storia di Gesù e descrivere le interazioni con quelli che gli giravano intorno: parenti, discepoli, poveri, peccatori, ricchi, avversari, capi del popolo, farisei, sacerdoti, ecc.
Tutti questi personaggi hanno qualcosa da dire al discepolo che legge il vangelo e da tutti loro c'è qualcosa da imparare.
Ma perché proprio una storia? Beh, con le persone che noi conosciamo o che abbiamo conosciuto, parenti, amici, colleghi, abbiamo in comune una storia. Non abbiamo certo condiviso, cartelle cliniche, carte d'identità, dati biometrici, ma piuttosto pezzi di vita. E quelle storie sono così sedimentate nella memoria che le possiamo ricordare anche a distanza di parecchi decenni, mentre, magari non riusciamo più a ricuperare alcuni nomi sepolto nei meandri della memoria.
Ecco, Marco ri-costruisce la storia di Gesù perché si possa condividere un pezzo di vita con Lui.
Ma questo è proprio quanto hanno sperimentato Mosè, Elia, Giona nei libri della Bibbia sui quali abbiamo già riflettuto (vedi archivi): un coinvolgimento della propria vita, della propria esistenza con Dio.
Certo, possiamo sempre ritenere buona la definizione di fede che Dante esprime Paradiso XXIV, 64 nella risposta alla domanda di San Pietro:
« Fede è sustanza di cose sperate / e argomento de le non parventi, / e questa pare a me sua quiditate ».
Una risposta che fa indubbiamente felici filosofi e teologi, ma che alle nostre orecchie suona quasi incomprensibile.
Se stiamo all'idea di Marco potremmo dire: "la mia fede è consapevolezza di avere in corso una storia con Dio".
E chi vuole la può chiamare "Alleanza".
Lettura 6 La struttura del vangelo di Marco
Il modo in cui gli antichi strutturavano gli scritti non era come il nostro. Noi dividiamo i libri in parti, capitoli, sezioni; usiamo la punteggiatura, mostriamo i paragrafi, ecc.
La Bibbia che conosciamo, i cui libri sono divisi in tanti capitoli, le sezioni ciascuna con il suo titolo e i versetti opportunamente numerati, non è stata pensata così dai suoi redattori, ma è opera dei copisti medievali.
E non ci furono pochi problemi a mettersi d'accordo sulla tipo di suddivisione da seguire.
Inoltre al tempo della composizione di vangeli, pur se già esistevano alcuni segni d'interpunzione, si preferiva strutturare il testo con il testo stesso. C'erano parole chiave intenzionalmente ripetute, la ripetizione di un dato tema che apriva e chiudeva una sezione formando quella che tecnicamente è chiamata "inclusione", oppure con versetti volutamente ripetuti.
Lasciamo per ora questi criteri di strutturazione che metteremo in luce quando li incontreremo e passiamo ad esaminare la grande ripartizione in due parti del vangelo di Marco.
Per semplicità possiamo dire che il vangelo di Marco è diviso in due parti mediate l'uso di tre versetti strategici; potremmo pensare a due archi che poggiano su tre colonne.
La prima colonna:
Mc 1,1 «Inizio del vangelo che è Gesù Cristo Figlio di Dio».
La seconda colonna:
Mc 8, 29 «Ma egli replicò: «E voi chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo/ Messia».
La terza colonna:
Mc 15,39 «Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!».
Abbiamo così diviso il vangelo grosso modo in due parti corrispondenti a tre confessioni di fede.
1- La prima confessione è quella della comunità credente, la comunità di Marco. Che è il versetto esaminato nelle letture precedenti.
2- La seconda confessione di fede è quella di Pietro a Cesarea. Una confessione molto convinta, però la risposta di Pietro arriva fino a riconoscere che Gesù è il Messia, ma non ancora Figlio di Dio. E proprio da qui inizia una parte conosciuta come "crisi galilaica". Prima Gesù era considerato un "profeta potente in parole ed opere", ma da qui in poi incomincia ad accennare alla morte, le guarigioni diventano più rare, le discussioni con gli avversari più accanite e discepoli non comprendono, nutrono dubbi, non capiscono perché Gesù si mostri così dimesso.
3 - La terza confessione è quella del centurione che l'aveva crocifisso il quale arriva a quella affermazione vedendo come Gesù si era comportato durante l'operazione della crocifissione. Per lui Gesù è il Figlio di Dio.
Già da questa struttura grossolana comprendiamo che la storia di Marco non è sconclusionata, ma ha queste due affermazioni che dicono chiaramente chi è Gesù, oltre alla prima, ovviamente.
Allora potremmo intitolare la prima parte:
"Chi è Gesù?" oppure "La ricerca dell'identità di Gesù" oppure espresso in modo affermativo: "Gesù è il Messia".
La seconda parte può essere intitolata: "Gesù il Messia Figlio di Dio Crocifisso".
Se è così comprendiamo subito che la storia raccontata da Marco ha come punto di osservazione oppure di approdo o, come punto di vista narrativo, la croce.
Si può obiettare che mettere in luce il tema della Croce e non quello della Risurrezione sia riduttivo per coloro che credono, ma da questo vangelo emerge che una "teologia della gloria" è argomento temuto da Marco.
Una fede che insegue miracoli, prodigi, segni celesti, visioni spettacolari è per Marco molto sospetta e non solo per lui, come vedremo.
Invece Marco sin dall'inizio mette in pista la croce:
Mc 1,14 «Dopo che Giovanni fu consegnato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio».
Gesù inizia la sua predicazione quando Giovanni Battista viene messo in prigione, dove poco dopo sarà decapitato.
Mc 2,20 Ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno».
È una discussione sul digiuno, ma già Gesù anticipa che lo sposo sarà tolto. "Sarà tolto" dice toglimento contro la volontà dell'interessato.
Mc 3,6 «E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire».
Siamo alla fine di una delle prime dispute con capi del popolo e già appare la decisione di farlo fuori.
Nella seconda parte poi troviamo tre predizione della passione che suscitano le rimostranze dei discepoli perché li scandalizzano.
Mc 8,31 E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare.
Mc 9,31 «Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo sta per esser consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risusciterà».
Mc 10,33 «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi: lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, 34 lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno; ma dopo tre giorni risusciterà».
In definitiva tutto il racconto di Marco ha come "segnavia" la morte di croce a partire fin dall'inizio.
Da questo punto di vista Marco non è un buon narratore di gialli perché già dai primi versetti rivela chi è la vittima e chi sono gli assassini.
Già, ma Marco non vuole raccontare un giallo che crei suspense, vuole piuttosto ricordare al discepolo e rivelare al semplice lettore, che Dio ha iniziato con lui, lettore, una storia che volente o nolente sarà condivisa.
Più esattamente, il lettore è invitato a fare un pezzo di strada con Gesù.
Lettura 7 Il proemio di Giovanni - prima parte Mc 1,2-3
Mc 1,2 Come è scritto nel profeta Isaia:
Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada.
3 Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore, / raddrizzate i suoi sentieri,
Se ci limitassimo ai versetti iniziali così come sono potremmo ritenere che essi alludano a problemi viabilistici o a semplici indicazioni simboliche.
Ma la notazione "come è scritto" è il modo in cui a qui tempi citavano le Scritture; non potevano riportare la numerazione dei versetti perché non era ancora stata inventata. E poiché conoscevano gran parte degli scritti a memoria, bastava la citazione del versetto iniziale per richiamare alla mente tutto il brano corrispondente.
Ora questi brani vengono attribuiti ad Isaia perché era ritenuto il profeta più importante, ma in verità essi dovrebbero essere riportati come segue:
Es 23,20 «Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato».
Ml 3,1 «Ecco io manderò un mio messaggero / a preparare la via davanti a me / e subito entrerà nel suo tempio / il Signore che voi cercate».
Is 40,3 « Una voce grida: nel deserto / preparate [voi] la via al Signore / appianate la steppa / la strada per in nostro Dio».
Cerchiamo di commentarli brevemente.
Nel libro di Esodo viene menzionato due volte l'angelo che guida il cammino di Israele verso la Terra.
Una prima volta al monte Sinai, quando viene consegnata a Mosè la Torah, la Legge. Una seconda volta dopo l'episodio del vitello d'oro e l'intercessione di Mosè che riesce a convincere Dio a non abbandonare il popolo al suo destino. Però la seconda volta l'angelo è collegato alla venuta di Dio e ad un procedimento di separazione e purificazione. C'è in gioco una guida e nello stesso tempo un giudizio.
Es 32,34 «Ora va', conduci il popolo là dove io ti ho detto. Ecco il mio angelo ti precederà; ma nel giorno della mia visita li punirò per il loro peccato».
Il secondo testo, del profeta Malachia, è grosso modo sulla stessa lunghezza d'onda:
Mal 3:1 «Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore, che voi cercate; l'angelo dell'alleanza, che voi sospirate, ecco viene, dice il JHWH degli eserciti. 2 Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. 3 Siederà per fondere e purificare; purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia. 4 Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. 5 Io mi accosterò a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto contro gli incantatori, contro gli adùlteri, contro gli spergiuri, contro chi froda il salario all'operaio, contro gli oppressori della vedova e dell'orfano e contro chi fa torto al forestiero. Costoro non mi temono, dice JHWH degli eserciti».
Anche in questo caso è in gioco un giudizio a riguardo del rispetto dell'Alleanza.
D'altra parte la "teologia del giudizio" di Dio è comune a tutti gli antichi profeti. Essi constatando come il popolo è tende sempre ad allontanarsi da JHWH per inseguire nuovi idoli e nuove dipendenze... e non avevano ancora smartphone, televisione, droghe, ecc... La fedeltà del popolo al suo Dio che lo ha liberato dalla schiavitù d'Egitto è sempre precaria e i richiami dei profeti che Dio invia loro, non producono risultati apprezzabile.
Israele va per strade che non sono quelle di JHWH. Allora l'incontro tra Dio e Israele potrà avvenire solo nel giorno del giudizio quando Dio verrà con potenza e farà giustizia: eliminerà i malvagi e lascerà o un "piccolo resto" fedele all'Alleanza.
La stessa teologia è presente nel testo del Deuteroisaia, un profeta della scuola di Isaia vissuto a cavallo della liberazione dall'esilio babilonese. Potremmo essere intorno al 500 a. C. Questo profeta ha il compito di incoraggiare gli esiliati a stabilirsi in Giudea. Dobbiamo ricordare che i deportati, (intorno al 480 a. C.) sono vissuti per 70 anni nella città più ricca e importante di quel tempo, con grandi palazzi, giardini, templi bellissimi, ecc.
Quando essi ritornano a Gerusalemme trovano la città diventata un cumulo di macerie, le mura di cinta demolite, il tempio, così decantato dai padri, ridotto ad un cumulo di rovine, le proprietà di famiglia in possesso di estranei, tanto che molti ripresero la via del ritorno a Babilonia.
L'incoraggiamento di Isaia qui riportato contiene anche il motivo della distruzione e deportazione.
Is 40:1 «Consolate, consolate il mio popolo, / dice il vostro Dio.
2 Parlate al cuore di Gerusalemme / e gridatele / che è finita la sua schiavitù, / è stata scontata la sua iniquità, / perché ha ricevuto dalla mano del Signore / doppio castigo per tutti i suoi peccati».
3 Una voce grida: / «Nel deserto preparate / la via al Signore, / appianate nella steppa /
la strada per il nostro Dio. / 4 Ogni valle sia colmata, / ogni monte e colle siano abbassati;
il terreno accidentato si trasformi in piano / e quello scosceso in pianura.
5 Allora si rivelerà la gloria del Signore / e ogni uomo la vedrà, / poiché la bocca del Signore ha parlato».
6 Una voce dice: «Grida» / e io rispondo: «Che dovrò gridare?».
Ogni uomo è come l'erba / e tutta la sua gloria è come un fiore del campo.
7 Secca l'erba, il fiore appassisce / quando il soffio del Signore spira su di essi.
8 Secca l'erba, appassisce il fiore, / ma la parola del nostro Dio dura sempre.
Veramente il popolo è come l'erba.
9 Sali su un alto monte, / tu che rechi liete notizie in Sion; / alza la voce con forza,
tu che rechi liete notizie in Gerusalemme. / Alza la voce, non temere; /
annunzia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio!
10 Ecco, il Signore Dio viene con potenza, / con il braccio egli detiene il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio / e i suoi trofei lo precedono.
11 Come un pastore egli fa pascolare il gregge / e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul seno / e conduce pian piano le pecore madri».
Però Dio ha voltato pagina adesso mostra tutta la sua tenerezza attraverso l'immagine del camminare nel deserto in mezzo al suo popolo oltre a quella intrisa di tenerezza, del pastore che porta in braccio gli agnellini non ancora capaci di stare dietro al gregge.
Se è così possiamo dire che Marco riporta questi brani per dire chi è Giovanni il battezzatore. Egli è un grande personaggio di transizione e rottura.
Di transizione perché è ancora legato a vecchi schemi, di rottura perché annuncia il nuovo che intuisce ma ancora non conosce.
Egli appartiene ancora in pieno alla vecchia economia e non conosce la nuova perché sarà un economia religiosa mai apparsa sulla faccia del pianeta.
Lo si potrà notare nella differenza tra la sua predicazione e quella di Gesù.
Potremmo sintetizzarla così: Giovanni ritiene che bisogna convertirsi perché arrivi il Messia.
Ma quando questi arriva non disdegna di frequentare proprio i peccatori... perché adesso sì, possono convertirsi.
Detto sinteticamente con altro linguaggio:
Per Giovanni la conversione precede il Regno, per Gesù il Regno precede la conversione.
Lettura 8 Proemio di Giovanni, seconda parte Mc 1,4-8
Mc 1,4 «Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, kerusso / predicando un battesimo di metànoia/conversione eis /verso il perdono dei peccati. 5 Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 6 Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico 7 e kerusso / predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. 8 Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo».
Questo brano riporta quattro termini strategici perché saranno richiamati più volte lungo tutto il racconto di Marco, tanto che sarebbe illuminante metterli singolarmente a tema esplorando tutto il testo da quello specifico punto di vista. Essi sono:
• deserto
• kerusso : predicare, proclamare, annunciare
• metanoia: cambio di mentalità, conversione
• Spirito
v4 Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, kerusso/predicando un battesimo di mtànoia/conversione eis/verso il perdono dei peccati.
Attorno alla predicazione di Giovanni si forma una comunità che accorre da tutta la Giudea e l'aggiunta di "tutti gli abitanti di Gerusalemme" intende certamente sottolineare le dimensioni del fenomeno.
Ora, Giovanni battezza lungo il Giordano e il punto più vicino a Gerusalemme è all'incirca Gerico; tra i due luoghi c'è un dislivello di circa 1500 metri il che richiede un tempo prossimo alle quattro o cinque ore di cammino su sentieri di montagna. E per di più nel deserto.
Da questo possiamo dedurre il grande richiamo che suscitava questo profeta.
Ma perché Marco specifica "...e tutti gli abitanti di Gerusalemme" che è una precisazione superflua poiché l'idea è già compresa in "tutta la Giudea".
Però se Gerusalemme è il grande centro religioso, con il suo grande tempio al quale vengono i pellegrinaggio ebrei da tutta la diaspora, come mai "tutti gli abitanti di Gerusalemme" si recano faticosamente in questo sperduto luogo del deserto per ascoltare le parole di Giovanni e farsi da lui battezzare?
Riteniamo di poter dire che la risposta religiosa al bisogno di salvezza che ogni uomo avverte nel profondo del cuore, non trovasse nella religione tradizionale risposta adeguata.
Nell'insieme, anche da quanto risulta da fonti storiche, risulta che in quel periodo la gente di Giudea nutriva grandi attese di qualcosa di nuovo. Detto in termini biblici potremmo dire che fosse un "kairòs", un "tempo opportuno" che qualcosa accadesse.
Poco più avanti al v14 ss, troviamo che anche Gesù "kerusso / proclama il Regno", ma non si parla di folle che accorrono; è invece Lui che un po' alla volta chiama i suoi discepoli. Vedremo che già questo comportamento costituisce una rottura con la tradizione.
Giovanni predica un battesimo di metànoia /conversione "verso" il perdono dei peccati.
Ora, il perdono dei peccati è opera di Dio, ma la conversione è opera che devi compiere tu: sei tu che devi cambiare la tua vita. Allora il rito del battesimo, diffuso in tutto l'antico oriente come rito di purificazione, non produce la conversione, ma la propizia.
Per usare il linguaggio del catechismo potremmo dire che il battesimo cristiano è un sacramento; e come tale è "segno efficace della grazia". Non così il battesimo di Giovanni.
È Giovanni stesso che ne spiega la differenza:
v8 «Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo».
Una differenza sostanziale ulteriormente ribadita da:
v7 «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali».
L'abbigliamento di Giovanni propone due suggerimenti.
1- Di Gesù, nessuno dei quattro vangeli dice mai come fosse vestito, se non nel racconto della passione, quando però viene spogliato.
2- Il vestito, se così si può chiamare, di Giovanni è uguale a quello indossato dal profeta Elia, il profeta più famoso del AT.
2 Re,1,8«Era un uomo peloso / vestito di peli; una cintura di cuoio gli cingeva i fianchi».
Ne abbiamo trattato in dettaglio nella Lettura 19 del libretto di Elia.
Allora Giovanni è vestito alla maniera di Elia. D'altra parte è l'abito solitamente indossato dagli eremiti del deserto.
Però di Elia è detto qualcosa di molto importante: è l'unico personaggio insieme ad Enoch, un patriarca prediluviano, che sia stato rapito in cielo. Per saperne di più: Lettura 21 del Libro di Elia.
Quindi Elia non era morto, ma era stato direttamente portato in cielo da un carro di fuoco e si riteneva che nei tempi messianici sarebbe ritornato.
Allora la somiglianza della figura di Giovanni con Elia non è una semplice coincidenza, ma è intenzionale.
Infatti a coloro che erano andati nel deserto a vedere Giovanni Gesù dirà:
Mt 11,8 «Che cosa dunque siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano morbide vesti stanno nei palazzi dei re! 9 E allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anche più di un profeta. 10 Egli è colui, del quale sta scritto:
Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero/ che preparerà la tua via davanti a te.
11 In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. 12 Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. 13 La Legge e tutti i Profeti infatti hanno profetato fino a Giovanni. 14 E se lo volete accettare, egli è quell'Elia che deve venire».
Anche questo ci consente di raffermare che Giovanni Battista è figura di transizione: segno di continuità e insieme di rottura.
Lettura 9 Il battesimo di Gesù Mc 1,9- 11
Mc 1,9 In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 10 E, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere dentro / eis di lui come una colomba. 11 E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».
Il brano è brevissimo ma ci sono diversi punto su cui riflettere.
Nazareth di Galilea
Marco ritiene necessario dire che Gesù viene dalla Galilea. Questa regione è quella che si trova più a Nord di Israele, la più lontana da Gerusalemme, popolata da molti pagani che vivono mescolati con gli ebrei.
Matteo valuta così la Galilea, riprendendo un brano di Isaia 8:
Mt4,15 Il paese di Zàbulon e il paese di Nèftali, / sulla via del mare, al di là del Giordano,/ Galilea delle genti; 16 il popolo immerso nelle tenebre / ha visto una grande luce;
su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte / una luce si è levata.
Intorno al 730 a. C il Regno del nord era stato conquistato dagli assiri che secondo il loro costume disperdevano i popoli vinti in tutte le regioni del loro impero per impedire possibili rivolte. Così gli ebrei residenti anche in Galilea vennero deportati e nella regione si insediarono molti stranieri. Per i Giudei la Galilea era un terra lontana e i suoi abitanti religiosamente poco affidabili perché troppo mescolati con i gentili, i gojm. Interessante notare che due apostoli di Gesù hanno nomi greci: Andrea e Filippo. In molti passi dei vangeli quando si parla di Gesù di Nazareth l'apposizione della provenienza ha un significato dispregiativo.
Allora la sottolineatura di Marco vuole indicare che Gesù viene da una terra marginale, da una periferia. Invece un messia serio avrebbe dovuto essere di Gerusalemme, estratto dalla classe dirigente e cresciuto nelle scuole più rinomate. Al contrario di Gesù non si sa niente, soltanto che viene dalla Galilea. Un biglietto da visita scadente.
Gesù viene a farsi battezzare ma il nostro testo non spiega il significato di questo battesimo, cosa che farà Matteo, tuttavia questo evento mostra l'identità del battezzato.
Per la prima comunità cristiana questo battesimo del Messia è un problema perché pone il Salvatore in fila con tutti i peccatori. Questo vuol dire che l'evento è storicamente sicuro. Anche perché lo riportano i tre sinottici e indirettamente anche Giovanni.
Comunque questo essersi messo in fila con i peccatori sminuisce la figura del Messia agli occhi degli oppositori, ma chi ha compreso il suo stile, si rende conto che Gesù si accoda «non perché sia peccatore, ma perché si sente responsabile dei peccati che ci sono» (B. Maggioni). E anche in questo caso siamo sfiorati dall'ombra della croce.
Il battesimo coinvolge tre elementi fondamentali: 1- apertura dei cieli; 2- discesa dello Spirito; 3 voce dal cielo.
1- apertura dei cieli
Se i cieli si sono aperti è perché prima si erano chiusi. Possiamo identificare questa chiusura nella figura dei cherubini posti a guardia del Giardino dopo il peccato della prima coppia.
Gn 3,24 Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante, per custodire la via all'albero della vita.
È questa chiusura dei cieli che fa sgorgare l'invocazione di molti giusti, salmisti e profeti perché i cieli si aprano.
Non possiamo tralasciare:
Is 45,8 «Stillate, cieli, dall'alto / e le nubi facciano piovere la giustizia; /
si apra la terra / e produca la salvezza / e germogli insieme la giustizia».
Un brano confluito poi nella preghiera cristiana del tempo di Avvento: « Rorate Cœli desúper, / Et nubes plúant justum», nel quale la giustizia è diventato il "Giusto".
In un altro passo ancora Isaia non si accontenta della semplice apertura, ma invoca lo squarciamento dei cieli:
Is 63,19 «Se tu squarciassi i cieli e scendessi! / Davanti a te sussulterebbero i monti.
È pur vero che in diverse visioni ricevute da alcuni personaggi (Is 6; Ez 1) si parla di "apertura dei cieli", ma è sempre per permettere di vedere su, non c'è mai qualcosa che scende.
Ad ogni modo tutte le volte che succede qualcosa del genere abbiamo a che fare con una "rivelazione", in greco "apocalisse". Allora anche nel nostro brano siamo in presenza di una Rivelazione / Apocalisse.
2- discesa dello Spirito
Quello che qui discende è lo Spirito. E scende "come" una colomba e dobbiamo sottolineare: "come".
Il "come" indica una modalità, non una forma. Nessuno lì ha visto una colomba scendere dall'alto.
Ora, la colomba, siamo tutti pronti a sostenerlo, è simbolo della pace: il rimando al racconto di Noè e del diluvio è inevitabile (Gn 6-9) e l'idea è pertinente. Però c'è un altro significato che ci sembra interpretare meglio la figura dello Spirito.
"Colomba", in ebraico "yonah", da cui Giona, il profeta capriccioso, è un termine che diversi profeti hanno usato per indicare l'atteggiamento instabile e capriccioso di Israele. Quindi la colomba, anche per Marco, era segno di instabilità perché essa va improvvisamente di qua e di là senza che tu possa fare previsioni.
A ben vedere anche l'incontro notturno di Nicodemo con Gesù, del vangelo di Giovanni alimenta questa comprensione a proposito dello Spirito. Gesù risponde a Nicodemo dicendo, tra l'altro:
Gv 3,6 «Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. 7 Non ti meravigliare se t'ho detto: dovete rinascere dall'alto. 8 Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito».
Cioè, Giovanni usa il vento per suggerire come si muove chi è stato raggiunto dallo Spirito. È un'idea molto vicina a quella della colomba.
Se è così, allora lo Spirito è una realtà della quale non puoi appropriarti, non dipende dalla tua volontà, non puoi impedirGli di raggiungere l'altro, fosse anche il tuo peggior nemico e se fai un muro, Lui è subito anche dall'altra parte... perché Lui è assolutamente libero. Tu puoi soltanto "invocarLo".
3- La voce dal cielo
L'infusione dello Spirito in tutto l'Antico Testamento avviene per una missione come nel caso del Servo di JHWH:
Is42,1 «Ecco il mio servo che io sostengo, / il mio eletto di cui mi compiaccio.
Ho posto il mio spirito su di lui; / egli porterà il diritto alle nazioni».
Nel nostro caso però non viene affidata alcuna missione. Però viene manifestata l'identità:
«Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».
La voce dal cielo rivela chi è Gesù: Egli è il Figlio amato.
La comunità di Marco sa già cosa questo vuol dire, ma per quelli che erano lì, intorno al Giordano, è una rivelazione sconcertante, perché questo "Figlio di Dio" comunque fosse inteso è riferito a "un signor nessuno" che viene da Nazareth di Galilea! Due aspetti che fanno a pugni tra loro. E questo per gli astanti è scandaloso.
Ma abbiamo già detto che Marco rifugge da una teologia della gloria seguendo piuttosto la teologia della croce.
D'accordo con le cristologie attuali possiamo pensare che questa rivelazione fosse destinata anche a Gesù.
Per dirla con linguaggio scorretto: "Gesù non nasce imparato"! Egli in quanto "vero uomo" deve faticosamente imparare, non solo quello che imparano tutti i bambini, ma in aggiunta deve coltivare la particolare relazione esistente con Dio attraverso ciò che accade in lui e attorno a lui per mezzo suo.
Anche lui, come noi, deve vivere di fede in continuo ascolto del Padre.
E infatti di tanto in tanto pianta lì tutti e si ritira da solo a pregare.
Se è così questa voce dal cielo, oltre a dirgli chi è, segna la sua investitura per una missione il cui senso si dispiega strada facendo.
Lettura 10 La prova nel deserto Mc 1,12- 13
Mc 1,12 Subito lo Spirito lo sospinge nel deserto 13 e nel deserto rimane quaranta giorni, tentato /peirazo da Satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano.
Il testo è lapidario; poche parole che però costringono a pensare; e a differenza di Matteo e Luca non viene esposto il contenuto della tentazione.
Dobbiamo sottolineare che non è Satana che spinge Gesù nel deserto, ma lo Spirito. Però è Satana che lo tenta.
Emerge subito la domanda: come mai il "Figlio amato", sul quale era disceso lo Spirito, viene messo alla prova? Perché in definitiva è lo Spirito che "lo induce alla tentazione". E il riferimento al "Padre nostro" non è casuale.
Le interpretazioni tradizionali, che usavano il metodo allegorico, mettono questo episodio in parallelo con quello di Adamo posto nel giardino di Eden che a fronte della trappola tesa dal diavolo - serpente, aveva gettato il sospetto sulle intenzioni di Dio.
Allo stesso modo esse vedono il battesimo di Gesù, con lo Spirito che scende sulle acqua e poi "entra" in lui, come una nuova creazione e la nascita di un nuovo Adamo.
Ma il vecchio Adamo era in un giardino, questo è nel deserto: non è la stessa cosa!
Che Gesù sia il nuovo Adamo è fuori discussione; quello vecchio aveva disubbidito mangiando il frutto proibito, il nuovo Adamo, invece, è obbediente al Padre fino alla morte di croce. Attenzione: obbedire non di moda ma è parola composta da ob e audire, cioè: "ascoltare per". L'ascolto di Dio è preghiera.
L'esegesi attuale che ha messo da parte l'interpretazione allegorica è più prudente. Tentiamo allora di comprendere che cosa intendesse Marco con queste poche parole.
1- Subito. Questo avverbio stabilisce uno stretto collegamento con il racconto del battesimo di Gesù: due racconti che non possono essere separati.
2- Quaranta non indica un tempo cronologico, ma il tempo simbolico perché si produca un cambiamento, una conversione. Quaranta sono gli anni che gli schiavi fuggiti dall'Egitto impiegano per diventare un popolo. Quaranta sono i giorni impiegati da Elia per raggiungere il Sinai e incontrare Dio ( 1 Re 19,8). Quaranta per dieci sono gli anni in cui gli ebrei hanno soggiornato in Egitto (Es 12,40). Quaranta giorni sono la durata del diluvio (Gn 7,12). Si possono trovare altri esempi; non ultimi la nostra quaresima che dura quaranta giorni, come pure l'avvento ambrosiano.
3- Deserto. Cerchiamo di capire cosa intende Marco quando colloca un evento nel deserto.
Mc 1,35 Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là pregava.
Per Gesù il deserto è il luogo propizio per mettersi in rapporto con il Padre; il luogo della preghiera; più volte nei vangeli troviamo questo sottrarsi di Gesù all'attività per pregare. E nessuno ha mai saputo quali fossero le sue preghiere.
Mc 1,45 Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.
Questo versetto fa parte di un racconto che narra la guarigione di un lebbroso, al quale poi Gesù raccomanda di non dire niente a nessuno. Gesù non ha mai amato le guarigioni teatrali: non era certamente sua l'idea di liberare un uomo dal male per motivi di "propaganda".
Allora potremmo dire che in questo caso Gesù si ritira nel deserto per essere fedele alla sua missione e al suo stile: per essere se stesso e non essere travolto dall'attività.
Mc 6,31 Ed egli disse loro: «Venite in disparte, in un luogo deserto, e riposatevi un po'». Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo per mangiare.
Anche in questo caso il deserto è il luogo in cui ritrovare se stessi, non certo per un fine narcisistico, ma per impostare o riprendere nuove e vere relazioni con gli altri.
Mc 6,35 Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: «Questo luogo è deserto (Cei: solitario) ed è ormai tardi; 36 congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, possano comprarsi da mangiare».
Questo è l'inizio del racconto della moltiplicazione dei pani grazie alla quale si saziarono 5000 uomini... nel deserto! Per capire il senso di questo "luogo deserto" lasciamo al lettore il compito di riflettere cosa sarebbe successo se Gesù avesse fatto la moltiplicazione dei pani a Gerusalemme.
4- Le Fiere. Se si allude a una nuova creazione, cioè ad un mondo non diviso dal peccato, allora anche le bestie feroci stanno tranquillamente a cuccia come cagnolini. Però se si resta nel mondo reale queste "fiere" indicano che Gesù era in una situazione di pericolo.
5- Gli angeli lo servivano. Questo elemento dice che Gesù era sotto la protezione di Dio. Vale a dire che in quella situazione di deserto, di difficoltà e di pericolo, Gesù ha fatto l'esperienza della fedeltà di Dio: ha sperimentato di essere "il Figlio amato".
6- E la tentazione? In realtà lungo tutta la sua vita, in quanto "vero uomo", Gesù è stato oggetto della tentazione. Non passiamo in rassegna tutte le volte che ciò è avvenuto, perché le incontreremo strada facendo, ma riportiamo soltanto l'ultima, quella più tremenda e dolorosa:
Mt 27,40 «Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla croce!».
Ecco le tentazioni nel deserto non sono altro che un'anticipazione di ciò che accadrà lungo tutto il suo percorso messianico.
In altre parole, il battesimo e l'infusione dello Spirito, non hanno preservato Gesù della sua fragile umanità, così ha dovuto vivere nella storia degli uomini con le sue precarietà, difficoltà, incomprensioni, lotte.
Però Egli è sempre stato capace di trovare i momenti opportuni nei quali sperimentare la presenza e la fedeltà di Dio, quindi la capacità e la forza di eseguire fino in fondo la volontà del Padre.
Esattamente come cercano di fare tutti coloro che sono "rinati nell'acqua e nello Spirito".
Sezione 1.1 Un insegnamento nuovo Mc 1,14-3,6
Lettura 11 L'inizio della proclamazione della lieta novella Mc 1,14-15
Mc 1,14 «E dopo che Giovanni fu consegnato venne Gesù nella Galilea proclamando / kerussō il Vangelo di Dio e dicendo: Il «Il tempo è compiuto / kairòs il Regno di Dio è vicino convertitevi / metanoeìte e credete al Vangelo / lieta notizia».
Dal punto di vista letterario questi due versetti costituiscono un sommario. Nella Lettura 6 abbiamo parlato della strutturazione del testo. Ecco, Marco usa, tra i vari criteri, anche i sommari come elementi di strutturazione.
Nei nostri due versetti infatti, il testo non entra nei dettagli, ma si limita ad esporre la predicazione di Gesù a grandi linee... anche se il peso specifico di queste parole, che vedremo nella prossima lettura, è enorme.
Che si tratti di un elemento strutturante lo capiamo perché poi è seguito da un argomento che riguarda i discepoli. Quindi segue la predicazione di Gesù in parole ed opere e infine appare il tema degli oppositori.
Questo schema nella Prima Parte del Vangelo (Mc 1,1 -8,29), si ripete tre volte.
Schematicamente abbiamo:
prima sezione
1,14-15 => sommario
1,16 - 20 => chiamata dei primi discepoli
1,21 - 3,5 => predicazione / kerussō di Gesù in parole ed opere
3,6 => opposizione di farisei ed erodiani con rimando alla croce.
seconda sezione
3,7 - 12 => sommario
3,13 - 19 => elezione dei dodici apostoli
3,20 - 5,43 => predicazione / kerussō di Gesù in parole ed opere
6,1 - 6,6a => opposizione dei concittadini di Nazareth
terza sezione
6,6b => sommario
6,7 - 13 => invio in missione dei dodici
6,14 - 8,13 => predicazione / kerussō di Gesù in parole ed opere
8,14 - 21 => opposizione dei discepoli
Coma si vede, abbiamo la ripetizione dello schema: sommario - discepoli - predicazione - oppositori.
Detta così la struttura risulta piuttosto arida e sembrerebbe roba da pignoli, ma forse riusciamo anche a cogliere al volo la scansione che emerge circa l'opposizione; più esattamente, a riguardo degli oppositori.
All'inizio sono erodiani e farisei, poi ci sono i quelli di Nazareth, e infine i discepoli.
Ma come? i discepoli sono proprio quelli che all'inizio avevano risposto con entusiasmo alla chiamata, tanto che poi sono stati eletti apostoli e poi addirittura inviati in missione e adesso passano dall'altra parte.
Per facilitare la lettura riportiamo i testi:
Opposizione dei farisei
Mc 3,5 «Ma essi tacevano. E guardandoli tutt'intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo: «Stendi la mano!». La stese e la sua mano fu risanata. 6 E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire».
Opposizione dei nazareni
Mc 6:1 «Partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. 2 Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga. E molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: «Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? 3 Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?». E si scandalizzavano di lui. 4 Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». 5 E non vi potè operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì. 6 E si meravigliava della loro incredulità».
Opposizione o incomprensione dei discepoli
8,14 «Ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un pane solo. 15 Allora egli li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!». 16 E quelli dicevano fra loro: «Non abbiamo pane». 17 Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non intendete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? 18 Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E non vi ricordate, 19 quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici». 20 «E quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Sette». 21E disse loro: «Non capite ancora?».
È chiaro che a suo tempo dovremo esaminare questi versetti puntualmente, ma già questo esempio ci dice che la lettura analitica non può tralasciare la struttura del testo.
Ma già qui possiamo chiederci l'ammonizione di Gesù: «Non capite ancora?» è rivolta ai discepoli o al lettore?
Sezione 1.1 Un insegnamento nuovo Mc 1,14-3,6
Lettura 12 L'inizio della proclamazione della lieta novella Mc 1,14-15
Mc 1,14 «E dopo che Giovanni fu consegnato / paradothenai venne Gesù nella Galilea proclamando / kērussō il Vangelo di Dio e dicendo: «È compiuto /peplerotai il tempo / kairòs il Regno di Dio è vicino convertitevi / metanoeìte e credete al Vangelo / lieta notizia».
L'inizio della predicazione di Gesù è posta sotto due segni negativi per la cultura del tempo.
1- Il primo è la "consegna" di Giovanni. Il verbo greco "paradothenai" ha un significato piuttosto ampio: consegnare, dare, trasmettere, tradire. Noi oggi usiamo: arrestare, imprigionare, ma anche "consegnare", che è ancora in uso e riguarda il soldato in punizione, che non può andare in libera uscita e resta "consegnato" in caserma.
Ora, la menzione della consegna di Giovanni, di per sé non essenziale, pone da subito l'attività di Gesù sotto il segno di ciò che accadrà alla fine: il tradimento /paradothenai di Giuda e la consegna /paradothenai alle guardie dei sacerdoti e poi a Pilato.
2- Anche la menzione della Galilea ha un significato negativo perché essa era considerata un territorio semipagano popolato da miscredenti (vedi Lettura 9), tanto che Matteo avverte la necessità di giustificare la cosa ponendola sotto il segno di una profezia di Isaia.
Mt4,15 Il paese di Zàbulon e il paese di Nèftali, / sulla via del mare, al di là del Giordano,/ Galilea delle genti; 16 il popolo immerso nelle tenebre / ha visto una grande luce;
su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte / una luce si è levata.
Esaminiamo alcuni termini.
Il verbo kērussō: gridare, proclamare, bandire come fa un araldo, un banditore, spesso è tradotto con predicare e in certi contesti è appropriato, ma in questo caso è più corretto "proclamare". Quindi possiamo giustamente pensare Gesù che va in giro per i villaggi e per i mercati "proclamando" la lieta notizia di Dio.
Il suo annuncio è riportato dal testo in forma molto sintetica perché, come abbiamo detto nella lettura precedente, si tratta di un sommario.
«È compiuto/ peplerotai il tempo / kairòs, il Regno di Dio è vicino engeniken...» non è un concetto, una definizione, ma una notizia sostenuta da due verbi all'indicativo, esattamente dei perfetti che indicano un evento iniziato che perdura nel tempo.
A questa notizia seguono due imperativi: "convertitevi e credete".
Così siamo di fronte alla struttura del messaggio cristiano valido ancora oggi: la notizia "lieta" e la morale.
Con un netto ribaltamento rispetto alla predicazione di Giovanni, cioè: ti devi convertire, non perché hai scoperto la tua cattiveria, ma perché è arrivato qualcosa che fa cambiare il modo di valutare la tua vita.
Questo porta a cambiare, potremmo dire automaticamente, la tua mentalità. Infatti il verbo usato è metanoeìte: cambiare mentalità, modo di ragionare che non dipende tanto da te, ma da qualcosa che ti ha raggiunto e ti ha colpito.
C'è un altro verbo greco più vicino alla nostra idea di "con-versione": epistrofein: voltarsi, ritornare, ricondurre, tornare indietro, che ci porta sul versante dello sforzo della volontà, che però è alquanto lontano da metanoeìte e non rende il senso del nostro testo.
Ma qui non si tratta di tornare indietro / con-verto, ma cogliere la novità che lì si manifesta.
E cosa è successo perché la mia valutazione della vita e del mondo sia cambiata?
Si è compiuto, si è riempito il kairòs.
Allora comprendiamo meglio perché il "convertitevi / metanoeìte precede il credere; infatti non si tratta di una conversione morale, ma teologica: fare mia l'opera di Dio nella storia, la mia storia.
Kairòs significa: tempo determinato, tempo preciso, circostanza, opportunità, epoca, giusta misura.
Potremmo dire: il tempo vecchio si è riempito, esaurito: è arrivato un tempo nuovo, c'è la giusta misura.
Ricordiamo che "novus" in latino significa non solo nuovo, ma anche definitivo, ultimativo.
Il fatto, poi, che il periodo sia impersonale rimanda l'evento a Dio.
L'impersonale era usato per non nominare Dio e allora potremmo tradurre: "JHWH ha riempito il tempo".
Il compimento consiste nel fatto che il Regno di Dio "si è fatto vicino/ engeniken".
Altra forma impersonale che indica un'azione di Dio.
Pisteute: questo verbo tradotto con credere ci porta sul versante delle verità dottrinali in cui appunto credere, ma nel greco sta più su versante del fidarsi, avere fiducia, ad essere leale, schietto, sicuro.
Se è così la fiducia è accordata al banditore, a colui che proclama più che alla dottrina proclamata.
Infatti il cristianesimo non è basato su un rapporto "personale" con Gesù?
Regno di Dio. I Vangeli non danno mai la definizione di questo Regno.
Il Regno non si può esprimere con concetti, ma può essere illustrato solo con racconti.
Le parabole appunto, ovvero tutto il Vangelo che è un racconto... che racconta di Gesù che racconta.
Sezione 1.1 Un insegnamento nuovo Mc 1,14-3,6
Lettura 13 La chiamata dei discepoli Mc 1,16-20
Se l'imperativo era: "convertitevi e credete al Vangelo", il racconto successivo ne è l'applicazione immediata.
Mc 1,16 «E passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete nel mare; erano infatti pescatori. 17 Gesù disse loro: «venite dietro a me e vi farò diventare pescatori di uomini». 18 E subito, lasciate le reti, lo seguirono.
19 E avanzando un po', vide Giacomo figlio di Zebedèo e Giovanni suo fratello anche loro nella barca mentre riassettavano le reti. 20 Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca con i garzoni, lo seguirono».
Qualche commentatore, osservando Gesù che camminando lungo il mare di Galilea chiama i discepoli, stabilisce un rimando a quello che accadde ai progenitori nel giardino di Eden i quali, dopo avere mangiato il frutto proibito ed essersi nascosti:
Gn 3,8 «Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. 9 Ma JHWH Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?».
Sia in questo che nel caso di Gesù saremmo in presenza del nostro Dio che va alla ricerca dell'uomo e la cosa è in sé suggestiva, tuttavia non dobbiamo neanche perdere di vista il fatto che anche l'uomo, magari indirettamente, è alla ricerca di Dio, perché solo in Lui è possibile trovare una riserva inesauribile di senso.
Questo parallelo è indubbiamente intrigante, ma se ci limitassimo a questo perderemmo la dimensione storica del nostro racconto evangelico. E tra l'altro non dobbiamo dimenticare che la verità cristiana si dà nella storia.
In questo racconto infatti possiamo rilevare una prima rottura, una prima anomalia nei confronti della tradizione religiosa precedente (e successiva).
Anomalia che dobbiamo sottolineare perché essa è la prima di molte altre che questo Messia opererà nel corso della sua esistenza.
Questa prima anomalia riguarda proprio la modalità di chiamata dei discepoli.
In tutte le scuole rabbiniche, farisaiche, sacerdotali, ma altresì per tutti i tipi di scuola esistente a quei tempi, erano sempre i discepoli o la famiglia dei discepoli a cercare il maestro: la famiglia doveva pagare salatissime spese di istruzione e mantenimento. Il neofita veniva sottoposto a selezioni e a prove durissime prima di essere accettato. E appena sgarrava o il rendimento non era quello previsto, veniva subito espulso.
Invece Gesù ribalta il metodo: è lui stesso a reclutare i suoi discepoli.
Non ci sono domande, non ci sono esami, prove, percorsi vocazionali, postulandati, noviziati e altre cose di questo genere. Un semplice: «venite dietro a me...», ma il greco è ancora più stringato: «deute opisō mou», letteralmente: «su, dietro me»; manca persino il verbo!
Quindi anomalia anche a riguardo della Chiesa che lì è nata perché Egli non ha fatto ciò che ogni religione deve necessariamente fare.
D'altra parte Gesù è in linea con gran parte delle vocazioni bibliche.
Mosè stava pascolando il gregge (Es 3).
Eliseo stava arando (1 Re 19,19).
Amos era raccoglitore di sicomori (Am 7,14).
Anche di Maria, al di là di tutte le rappresentazioni pittoriche, che ci porterebbero ad affermare che stesse pregando, era semplicemente in casa: pregava? preparava il minestrone? lavava i panni? faceva la polvere? il vangelo non lo dice, ma riferisce solo:
Lc 1,28 «Entrando da lei, l'angelo Gabriele, le disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te».
Tornando al nostro testo, l'imperativo riguarda il seguire, non il lasciare le reti e il padre, perché il lasciare è solo conseguenza del seguire, venite dietro a me.
Il seguire vede poi questi quattro che camminano insieme, ma anche l'essere insieme è conseguenza del «venite dietro me».
La Chiesa è esattamente questo stare dietro di Lui.
Ancora una volta, un rapporto personale con Gesù.
Sezione 1.1 Un insegnamento nuovo Mc 1,14-3,6
Lettura 14 La exousia: un insegnamento nuovo e autorevole Mc 1,21-28
Mc 1,21«Ed entrano a Cafarnao e Gesù subito entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. 22 E si stupivano per il suo insegnamento; infatti insegnava loro come uno che ha autorità / exousìa e non come gli scribi.
23 E subito c'era nella sinagoga un uomo con uno spirito immondo che gridò: 24 «Che c'è tra noi e te , Gesù di nazareno? Sei venuto per farci perire? So chi sei tu, il Santo di Dio!».
25 E Gesù lo minacciò dicendo: «Ammutolisci ed esci da lui!». 26 E lo spirito immondo contorcendolo e gridando a gran voce uscì da lui. 27 E tutti furono spaventati così che si chiedevano tra loro: «Che è questo? Un insegnamento nuovo fatto con autorità /exousìa! Comanda anche agli spiriti immondi e gli obbediscono!».
28 E la sua fama uscì subito ovunque, in tutta la regione intorno della Galilea».
1- Il lettore attento si sarà accorto che i cinque entrano a Cafarnao, ma è solo di Gesù si dice che entra nella sinagoga. Era sabato e tutti i bravi ebrei frequentavano la sinagoga. E i discepoli hanno dato subito forfeit?
Gli studiosi che usavano il metodo storico critico dicono che Marco avendo a disposizione diversi scritti e racconti li ha messi insieme come meglio ha potuto. Come se il nostro evangelista avesse incollato sul muro tanti post-it e pescava un po' qui e un po' là.
Oggi siamo per un'altra spiegazione. Marco avverte il bisogno di differenziare Gesù dai discepoli. Messi insieme sono il germe della Chiesa che diventerà adulta dopo la Pasqua e la Pentecoste, ma appunto tra Gesù e discepoli c'è differenza. Paolo usa il rapporto Capo e membra per dire l'identità nella differenza; Marco, qui e altrove lavora sulle voci verbali.
A prova di questo il v 29 dice: "usciti dalla sinagoga"; l'ingresso è al singolare, l'uscita al plurale.
Questa apparente pignoleria letteraria ci ricorda che una Chiesa che non è in costante riferimento a Cristo, il Capo, ha perso il suo oggetto e il suo senso... Occhio alla democrazia ecclesiastica!
2- L'exousìa in parole. La prima cosa che colpisce gli ascoltatori di Gesù è che insegnava con autorità / exousia e anche la finale del brano riprende questo argomento perché l'exousìa di Gesù si è manifestata sia nelle parole che nella azione.
Ma cosa significa insegnare con autorità? Intanto il termine italiano in questi tempi si è molto logorato. Ormai quando sentiamo parlare di autorità pensiamo subito a corruzione, disprezzo per la gente, prevaricazione, adattamento delle leggi per fini privati e via dicendo: non c'è più distinzione tra autorità ed autoritarismo.
Autorità invece dovrebbe essere in stretto legame con servizio, cura dell'interesse pubblico, responsabilità, competenza, attenzione ai più deboli, ecc. L'idea originaria di autorità potrebbe essere rappresentata dalla figura del padre di famiglia nei confronti dei figli, quando cioè l'autorità si vela di tenerezza senza tralasciare la responsabilità. Quella responsabilità che ad un certo punto trova la forza di dire al ragazzo anche: "adesso si fa così... perché lo dico io".
Ma oggi un padre che si comportasse così non sarebbe un padre "democratico"!
Per tutte queste ragioni, che in questa sede non possiamo approfondire più di tanto, preferiamo usare il termine greco exousìa che ormai è molto diffuso a livello ecclesiale.
Gesù insegna con exousìa perché non segue il metodo dei maestri d'Israele i quali nel parlare si riferivano sempre a maestri precedenti che a loro volta citavano altri maestri precedenti in una catena di citazioni senza fine.
Gesù non cita mai maestri passati, al più Mosè e, raramente, qualche profeta, ma la cosa "scandalosa" è che in certi casi arriverà a dire: "Vi fu detto... ma invece io vi dico". Quindi la sua è una exousìa che oltre ai comportamenti attuali si rivolge anche alla tradizione. E talvolta egli appare addirittura libero nei confronti della tradizione.
Questa è la seconda anomalia o rottura che incontriamo. La prima, vista nella lettura precedente, riguardava la chiamata dei discepoli.
3- L'exousìa in opere.
Spirito immondo è uno dei modi in cui veniva chiamato Satana, demonio, diavolo.
Facciamo solo alcune annotazioni.
Non è che quando lo spirito immondo lascia l'ossesso, si vede uscire un tizio tutto rosso con le corna e le zampe di capra o come una delle tante raffigurazioni che rappresentano il demonio, infatti egli è uno spirito e come tale non si vede.
Inoltre da questo testo risulta che è un personaggio intelligente che conosce molte cose, tra le quali anche l'identità di Gesù che chiama "Santo di Dio". D'altra parte abbiamo visto, alla lettura 10, che Gesù stesso era stato tentato da Satana nel deserto. Già lì era incominciata la guerra... ma dovremmo ricordare che essa ha avuto un inizio ancora più remoto, là nell'antico giardino di Eden (Gn 3).
Il fatto che Satana sia uno spirito, gli consente di giocare una carta molto preziosa, quella di far credere che non esista.
Quindi non possiamo semplicemente congedarci da questo racconto dicendo che a quei tempi non erano in grado di diagnosticare le malattie mentali e il diavolo era una diagnosi che andava sempre bene.
Gli antichi erano convinti che il male fosse causato da spiriti cattivi e per Israele era Satana, ma noi oggi siamo forse in grado di spiegare tutto il male presente sul pianeta?
In questa sede non possiamo tematizzare questo argomento, né possiamo tralasciarlo, però visto che nel vangelo di Marco ci sono molte cacciate di demoni esso deve essere tenuto presente.
Suggeriamo di consultare quello che dice in proposito il Catechismo della Chiesa Cattolica promulgato da Giovanni Paolo II nel 1992.
(Si può consultare e scaricare sul sito del Vaticano => http://www.vatican.va/archive/ccc_it/ccc-it_index_it.html(link is external)
In "Glosse" abbiamo riportato nella nota esegetica 8 le parti che riguardano questo argomento.
4- L'esorcismo. La pratica dell'esorcismo era molto diffusa in tutte le culture antiche perché si pensava il mondo abitato da spiriti malvagi.
Per quanto riguarda la tradizione giudeo cristiana, la letteratura rabbinica e gli scritti di Qumran, del Mar Morto, riportano i rituali usati per eseguire gli esorcismi, che erano molto complicati densi di formule magiche, che duravano molto tempo e potevano richiedere parecchi giorni.
Quello che colpisce i giudei presenti nella sinagoga è il fatto che l'esorcismo avviene semplicemente attraverso un comando: «Ammutolisci ed esci da lui!».
Vedremo anche in altri episodi di cacciata degli spiriti impuri, che ci si trova in un contesto di lotta tra Gesù e lo spirito malvagio che cerca di opporglisi.
In questo forse Marco vuole sottolineare che la battaglia di Gesù contro il male, ogni male, ha attraversato tutta la sua vita e la vittoria definitiva avviene solo il venerdì santo e il mattino di Pasqua.
Sezione 1.1 Un insegnamento nuovo Mc 1,14-3,6
Lettura 15 La suocera di Simone Mc 1,29-31
Mc 1,29 «E subito, essendo usciti dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone e di Andrea, insieme con Giacomo e Giovanni.
30 Ora la suocera di Simone giaceva a letto febbricitante; e subito gli dicono di lei. 31Ed egli avvicinatosi, prendendola per la mano la fece alzare / ēgeiren. E la febbre la lasciò. Ed ella li serviva / diēconei».
Abbiamo due scene collegate tra loro perché accadono entrambe a Cafarnao in giorno di sabato, parzialmente.
Troviamo due volte l'avverbio "subito" che in Marco sottolinea la prossimità del Regno e la necessità di non tergiversare nel prendere una decisione per esso.
Certo, erano andati alla sinagoga la mattina presto, c'era stata la preghiera, la lettura della Bibbia, la spiegazione da parte di Gesù, la cacciata dello spirito impuro dall'ossesso e chissà quante discussioni erano seguite. Poi quando arrivano a casa non c'è niente di pronto. Così viene guarita la suocera che può mettersi a far da mangiare.
Ecco, una banalità di questo genere è del tutto estranea al vangelo di Marco, che potremmo condividere se fossimo sintonizzati sulla lunghezza d'onda dei "miracoli", del "prodigio". Ma il vangelo non parla di miracolo, ma di guarigione perché esso, come Gesù, è estraneo all'aspetto spettacolare.
Però al lettore attento o al neofita che si è accostato alla chiesa, non possono sfuggire due verbi strategici e al grande contenuto simbolico del racconto.
Il primo verbo: la fece alzare / ēgeiren che rimanda a Mc 16,2:
Mc 16,2 «Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato (le donne), vennero al sepolcro al levar del sole. 3Esse dicevano tra loro: «Chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro?». 4 Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. 5 Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. 6 Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto / ēgeiren, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto».
Allora il primo verbo è legato all'annuncio della risurrezione. Che significa la vita di un uomo nuovo, che non trascorrerà i suoi giorni a girare i pollici, poiché egli è abilitato al "servizio / diēconei".
Se è così abbiamo un richiamo ancor più pregnante, che ci rimanda al secondo racconto della creazione, quello più antico.
Gn 2,4 «Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, 5 nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata - perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo 6 e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo -; 7 allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente.
8 Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. 9 Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. [...] 15 Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo habodah / diēconei / servisse (Cei:coltivasse) e lo shamar / custodisse».
Notiamo i vv 5-7 che descrivono la desolante condizione della terra quando mancava l'uomo.
Ora, i due verbi, servire e custodire, sono usati nell'Antico Testamento, non solo in questo brano di Genesi, ma anche per specificare il rapporto che l'uomo di fede dovrebbe tenere nei confronti dell'Alleanza come abbiamo trattato nella letture 43 e 44 del libro di Esodo.
Comunque, più in generale, il riferimento a Genesi, dice che il servizio e la custodia della creazione è il fine a cui è chiamato l'uomo.
E questo, a maggior ragione, dovrebbe valere anche per coloro che risorgono in Cristo.
Se è così, sin dall'inizio Dio si prende cura della creazione e continua a farlo.
Tornando al nostro brano, allora possiamo dire che la suocera di Pietro, non viene guarita per servire la minestra, ma per un fine ben più alto... che non esclude la minestra.
Lettura 16 La fine della "giornata di Cafarnao" Mc 1,32-34
Mc 1,32 «Ora, venuta la sera, quando fu tramontato il sole, portavano a lui tutti gli ammalati e gli indemoniati; 33 e l'intera città si era radunata presso la porta. 34 Ed egli curò molti malati di varie malattie e cacciò molti demoni. E non lasciava parlare i demoni perché lo conoscevano».
Gli portano gli ammalati alla sera dopo il tramonto, non perché facesse più fresco, ma perché era terminato il giorno di sabato. In Israele il passaggio da un giorno a quello successivo avveniva alla sera. Ma "sera" è un tempo relativamente ampio, come fai a dire che sei già nel nuovo giorno? Il tramonto del sole è una buona indicazione, ma anch'esso non è molto preciso: tramonto iniziato o tramonto completato?
A Gerusalemme usavano indicare il cambio di giornata quando nel cielo si potevano vedere almeno tre stelle.
Anche il nostro testo con la doppia indicazione «venuta la sera, tramontato il sole», dice che anche a Cafarnao questo passaggio era osservato con grande scrupolosità. E siccome di sabato non si potevano portare pesi, solo con l'arrivo del nuovo giorno potevano portare gli ammalati.
«E non lasciava parlare i demoni perché lo conoscevano»
Questi demoni, come lo "spirito immondo" che si era impossessato dell'ossesso nella sinagoga (Lettura 14), conoscono bene chi è Gesù, ma Egli impedisce loro di divulgare la sua identità.
Una persona non è specificata dalla sua carta d'identità, dal suo codice fiscale o dal suo nome, che sono solo segni, ma invece può essere conosciuto solo attraverso la sua storia.
Allora non si può definire la messianicità di Gesù finché non si è assistito alla sua vicenda.
E al demonio, mentitore fin dall'inizio, non è consentito proclamare la verità di del Messia.
Con questo Marco vuole avvertire anche il catecumeno entrato nella sua comunità, che non puoi conoscere Gesù se non conosci la sua vita e non ti identifichi con la sua storia.
Lettura 17 Il tema dei miracoli Mc 1,35-39
Mc 1,35 «E levatosi al mattino, a notte profonda, uscì e andò in un luogo deserto e là pregava. 36 Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce 37 e lo trovarono e gli dicono: «Tutti ti cercano!». 38 E dice loro: «Andiamo altrove per i villaggi vicini, affinché anche là io predichi / kērussō anche là; infatti sono uscito per questo!». 39 E venne predicando nelle loro sinagoghe per tutta la Galilea e scacciando i demòni».
Le prime mosse di Gesù hanno avuto successo, ma Gesù non condivide l'entusiasmo dei discepoli perché lo considera un pericolo.
E qui abbiamo un primo accenno di tensione tra Gesù e i discepoli che, secondo loro, non sarebbe capace di sfruttare la situazione.
Certo i miracoli aprono facilmente e teatralmente la strada del successo, ma non è questa il tipo di sequela che Gesù apprezza, perché la fede non vive di miracoli.
Allora questo breve brano ci costringe a prendere in considerazione il tema dei "miracoli", anche perché dobbiamo prendere le opportune distanze da questa denominazione.
Diciamo subito che nel vangelo di Marco il termine appare una sola volta (Mc 9,38) e non per opera di Gesù.
Marco parla solo di "guarigioni" e "cacciate di demoni". Giovanni poi ne riporta solo sette e li chiama "segni".
Potremmo definire i miracoli: "gesti della potenza di Dio" e la storia delle religioni è piena di gesti della potenza degli dèi. Ad esempio Giove è spesso rappresentato mentre impugna saette da scagliare sulla terra a uomini e cose.
Abbiamo visto nel libro di Esodo che la presenza di Dio sul monte Sinai è accompagnata da fuoco, fiamme, eruzioni, terremoti, tuoni, nubi, ecc. Si tratta del consueto bagaglio di cui si cinge la presenza del sacro.
Tutti segni che atterriscono l'uomo che così si fa piccolo di fronte al divino.
Anche a Gesù viene proposta questa via, come specifica il Vangelo di Matteo:
Mt 4,5 «Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio 6 e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: / Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo,
ed essi ti sorreggeranno con le loro mani,/ perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede».
7 Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: / Non tentare il Signore Dio tuo».
Certo, che se Gesù avesse accettato questa proposta, magari con ripresa diretta in Eurovisione e Mondovisione, il successo avrebbe raggiunto dimensioni universali.
Ma non è questo il senso che Gesù vuole attribuire ai "segni della potenza di Dio", i miracoli, appunto.
I suoi "segni" sono tutti "segni di liberazione dal male" per l'uomo che si trova nella malattia e nel bisogno.
Quando Lui opera, abbiamo esclusivamente sordi che odono, ciechi che vedono, zoppi che camminano, lebbrosi mondati e perfino morti che risorgono.
Durante tutto il suo ministero non accade mai il contrario: uno che resti azzoppato, un altro che divenga cieco, un terzo che resti fulminato, ma solo "segni di liberazione dal male".
È questa la terza anomalia o rottura rispetto la tradizione, che pacificamente annoverava, tra i segni della potenza di Dio, tanto aspetti fausti quanto eventi infausti.
Ed Egli deve fare una gran fatica per fare comprendere ai suoi discepoli che le malattie, le disgrazie, gli eventi infausti non sono opera di Dio, come leggiamo in Luca:
Lc 13:1 «In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli circa quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. 2 Prendendo la parola, Gesù rispose: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? 3 No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 4 O quei diciotto, sopra i quali rovinò la torre di Sìloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? 5 No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».
Quindi Gesù nega il legame tra disgrazia è peccato perché Dio non è uno che si vendica. Certo, il male resta senza spiegazione, ma non è corretto spiegarlo attribuendolo all'opera di Dio.
Più esplicito è un brano di Giovanni di cui raccomandiamo di leggere tutto il capitolo:
Gv 9:1 «Passando vide un uomo cieco dalla nascita 2 e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?». 3 Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. 4 Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può più operare. 5 Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo». 6 Detto questo sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco 7 e gli disse: «Va' a lavarti nella piscina di Sìloe (che significa Inviato)». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva».
Gesù mostra ai suoi discepoli come opera Dio donando la vista al cieco nato, perché appunto quando Dio opera accade questo. Ma i discepoli si saranno convinti?
Sicuramente non hanno cambiato parere i farisei che dopo averlo interrogato decidono:
Gv 9,34 «Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?». E lo cacciarono fuori».
Questo mostra quanto fosse consistente la tradizione che collegava malattie a peccati commessi anche da diverse generazioni precedenti. E Gesù deve rompere con essa perché l'immagine di Dio che lui porta è quella della dedizione verso l'uomo, una dedizione che non accetta alcun condizionamento neanche religioso.
Anche a riguardo dei discepoli si può avanzare qualche dubbio circa la radicalità di questa indefettibile dedizione incondizionata di Dio che opera solo segni di liberazione dal male.
Infatti nel libro di Atti abbiamo il racconto di Anania e Saffira che sembra ridare vita all'antica tradizione:
At 5:1 «Un uomo di nome Anania con la moglie Saffira vendette un suo podere 2 e, tenuta per sé una parte dell'importo d'accordo con la moglie, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. 3 Ma Pietro gli disse: «Anania, perché mai Satana si è così impossessato del tuo cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del terreno? 4 Prima di venderlo, non era forse tua proprietà e, anche venduto, il ricavato non era sempre a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a quest'azione? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio». 5 All'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. E un timore grande prese tutti quelli che ascoltavano. 6 Si alzarono allora i più giovani e, avvoltolo in un lenzuolo, lo portarono fuori e lo seppellirono.
7 Avvenne poi che, circa tre ore più tardi, entrò anche sua moglie, ignara dell'accaduto. 8 Pietro le chiese: «Dimmi: avete venduto il campo a tal prezzo?». Ed essa: «Sì, a tanto». 9 Allora Pietro le disse: «Perché vi siete accordati per tentare lo Spirito del Signore? Ecco qui alla porta i passi di coloro che hanno seppellito tuo marito e porteranno via anche te». 10 D'improvviso cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i giovani entrarono, la trovarono morta e, portatala fuori, la seppellirono accanto a suo marito. 11 E un grande timore si diffuse in tutta la Chiesa e in quanti venivano a sapere queste cose».
Quindi anche nel Nuovo Testamento troviamo eventi che vengono interpretati in modo cristologicamente incompatibile. E quante di queste interpretazioni sono poi rientrate nella storia ecclesiastica!
Allora dobbiamo dire che è soltanto nel breve spazio che ha riguardato la vicenda di Gesù, che i cosiddetti miracoli sono esclusivamente "segni di liberazione dal male".
Eppure a Gesù avrebbe fatto comodo un piccolo miracolino a suo favore quando è entrato nella zona della passione, non tanto grosso, bastava un piccolo terremotino, un soldato che cade e si rompe una gamba, un infartino a Pilato... e invece niente di tutto questo.
Certo perché per fare questo, un uomo avrebbe dovuto subire il male... e Gesù non poteva permettere ciò. L'unico modo per evitare che anche ad un solo uomo fosse inflitto del male era accettare che fosse Lui, il Figlio di Dio stesso, a subirlo.
Gesù ha praticato l'economia del sangue, altrimenti la sua immagine di Dio, quella che lui aveva predicato per tre anni, sarebbe rimasta offuscata, offesa, tradita.
Lettura 18 Guarigione di un lebbroso Mc 1,40 - 45
Mc 1,40 «Allora venne a lui un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi mondarmi!». 41 Ed egli mosso compassione / splagchnistheis, stesa la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii mondato!». 42 E subito andò via da lui la lebbra e fu mondato. 43 E, Egli rimbrottandolo, subito lo cacciò e gli disse: 44 «Guarda di non dir niente a nessuno, ma va', mostrati al sacerdote, e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, a testimonianza per loro». 45 Ma quegli, uscito, cominciò a proclamare / kērussō e a divulgare la notizia, così che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in città, ma stava fuori, in luoghi deserti; eppure venivano a lui da ogni parte».
Questo brano fa parte della triplice tradizione, ma viene posto in contesti diversi. Matteo lo pone dopo il discorso della montagna e Luca parla di "una città", senza riportarne il nome. Quello su cui i tre concordano è che sia avvenuto in Galilea. E comunque manca il dove e il quando. Questo dice che le tradizioni orali hanno tramandato l'evento senza specificarne i particolari meno rilevanti.
Marco lo pone come scansione tra "La giornata di Cafarnao" e le "Cinque dispute" che termineranno con la decisione di far fuori il Messia perché si porrebbe contro la Legge.
E veniamo al nostro lebbroso. È difficile immaginare come fosse realmente penoso il problema della lebbra a quei tempi, quando ancora non esistevano cure. In verità fino agli anni 50 non c'era un cura per questa malattia e l'unico mezzo di difesa era quello di non restare contagiati, cioè i cordoni sanitari. Ciò significa che i colpiti da questo morbo venivano isolati. In Europa, nel Medioevo, per tale scopo vennero costruiti i primi lazzaretti destinati ad ospitare le persone colpite dalla lebbra che più tardi diventarono lebbrosari.
Non dobbiamo perdere di vista lo stigma che le società hanno sempre attribuito a questa malattia e soprattutto l'incapacità di distinguere l'ammalato dalla malattia.
Oltretutto, anche dalle nostre parti, il peccato veniva paragonato alla lebbra e per la proprietà transitiva, la lebbra veniva considerata conseguenza del peccato. Questo idea era particolarmente viva nell'antico Israele dove in linea di massima tutte le malattie erano considerate conseguenza dei peccati, magari commessi da generazioni precedenti.
Il seguente brano del libro del Levitico, forse, può dare una pallida idea di quali fossero le condizioni in cui i lebbrosi fossero costretti a vivere, ma suggeriamo di leggere interamente Lv 13 e 14 per rendersi conto come erano trattati chi aveva semplicemente una malattia della pelle.
Lv 14,45 «Il lebbroso colpito dalla lebbra porterà vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando: Immondo! Immondo! 46 Sarà immondo finché avrà la piaga; è immondo, se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento».
Ora il nostro lebbroso infrange la Legge perché non sta alla larga gridando: "immondo, immondo" come prescrive il Levitico ma "riconosce" in Gesù la potenza di guarirlo.
Gesù è mosso a compassione, ma l'italiano non rende il senso del termine greco splagchnistheis che contiene la radicale di "viscere" corrispondente all'ebraico "raham" (Vedi Lettura 57- ss di Esodo), ad indicare un sentimento che sconvolge nel profondo delle viscere, appunto.
Gesù riconosce la pertinenza del desiderio dell'uomo e a sua volta infrange la Legge perché lo tocca.
Il v43 non è una minaccia, ma è un invito ad applicare ciò prescrive la Legge perché il lebbroso sia rimesso nella società, cioè mostrarsi al sacerdote che constata la scomparsa della lebbra, lo dichiarerà mondo.
Il brano termina con questo uomo risanato che va in giro a proclamare / kērussō le meraviglie di operate da Dio per mezzo di Gesù: allora il lebbroso risanato è diventato il primo apostolo.
Osserviamo che in Israele si riteneva che chi avesse la lebbre fosse come morto e da trattare come tale. Dalla lebbra non si poteva guarire se non per intervento di Dio. Abbiamo un racconto nel secondo libro dei Re che narra le vicende del profeta Eliseo e come questi guarì dalla lebbre un ufficiale del re di Aram.
2Re 5:1 «Nàaman, capo dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore e stimato, perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la vittoria agli Aramei. Ma questo uomo prode era lebbroso».
Quando il re di Aram viene a sapere che in Israele c'è un profeta che fa miracoli, invia una lettera al re di Israele e qui abbiamo il passaggio che ci interessa:
2 Re 5,6 «Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: «Ebbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Nàaman, mio ministro, perché tu lo curi dalla lebbra». 7 Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: «Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi mandi un lebbroso da guarire? Sì, ora potete constatare chiaramente che egli cerca pretesti contro di me».
Come si vede l'esclamazione del re d'Israele coerentemente con le conoscenze del tempo, attribuisce esclusivamente a Dio la possibilità di guarire dalla lebbra.
Se è così allora possiamo dire che, la guarigione del lebbroso fatta da Gesù, è un passaggio rivelativo: dice chi è Gesù: egli è il Figlio di Dio.
Un'ultima osservazione: il brano inizia con un lebbroso che di norma deve vivere in luoghi deserto e alla fine sarà Gesù che a sua volta deve stare in luoghi deserti, mentre l'ex lebbroso è riammesso nella società.
Come dire: fare del bene ha un costo.
Lettura 19 Le controversie galilaiche Mc 2
Non dobbiamo perdere di vista che stiamo esplorando la prima parte del Vangelo di Marco che, come abbiamo detto alla lettura 6, potrebbe essere intitolata: "Chi è Gesù?" oppure "La ricerca dell'identità di Gesù" oppure, espresso in modo affermativo: "Gesù è il Messia"
Nelle letture precedenti abbiamo visto che Gesù propone un insegnamento nuovo con autorità / exousìa, scaccia i demoni con exousìa e guarisce gli ammalati con exousìa.
Ora troviamo cinque controversie che Marco colloca a Cafarnao e sono occasione per fare una prima conoscenza con gli oppositori e definire i contorni della identità di Gesù.
Notiamo che egli non si presenta mai come "Figlio di Dio", ma come "Figlio dell'Uomo". Di questo appellativo non possiamo semplicemente dare una definizione, che lascerebbe semplicemente il tempo che trova, ma dobbiamo cercare di afferrarne il senso per noi che lo leggiamo oggi e soprattutto per l'ascoltatore di Gesù, perciò ne dobbiamo approfondire il significato facendone la storia.
Il sintagma "Figlio dell'uomo" nell'Antico Testamento è usato moltissimo e vuole indicare la natura della persona cui è rivolto: l'uomo come creatura, nel suo limite, nella sua fragilità; in genere pronunciato da un personaggio di alto rango: un ministro, un re, Dio stesso e rivolto al suo interlocutore.
Nei vangeli "Figlio dell'Uomo" è usato con un significato ben diverso, esattamente quello presente nel libro del profeta Daniele.
Il libro di Daniele, posto tra i profeti maggiori, accanto ad Isaia, Geremia ed Ezechiele, è un testo alquanto complesso anche perché scritto parte in ebraico, parte in aramaico e parte in greco. Esso usa il genere apocalittico, che fa largo uso di visioni e sogni, denso di simboli non immediatamente comprensibili se non c'è una certa dimestichezza con tale letteratura. Chi ha provato ad approcciare l'Apocalisse di Giovanni ne sa qualcosa.
Il libro di Daniele non è stato scritto da un profeta di nome Daniele, ma da un autore o più autori sconosciuti.
L'esame delle forme letterarie rivela che esso può essere stato composto all'inizio del secondo secolo avanti Cristo, diciamo per dare dei numeri: 200 - 180 a. C., e poiché l'autore si rivolge agli ebrei del suo tempo, ci è richiesto di conoscere almeno sommariamente la situazione storica di Israele in quel periodo.
Sappiamo che nel 580 a C. Gerusalemme viene distrutta dai babilonesi e la parte più elevata della popolazione, la classe dirigente deportata a Babilonia dove rimase per circa settant'anni fino a quando l'impero babilonese venne conquistato da Ciro il grande, che fondò l'Impero Persiano.
Circa duecento anni dopo anche a l'Impero Persiano cadde, conquistato da Alessandro Magno che morì poco dopo ancora giovane, nel 311 a. C.
La successione di Alessandro venne brutalmente decisa da alcuni suoi generali che divisero il regno in quattro parti; un accordo che li vide subito dopo farsi guerra l'un l'altro.
Israele fu coinvolto, suo malgrado, in tutte queste vicende e si trovò così ad essere dominato dai Selucidi, una dinastia fondata da Seleuco uno dei quattro generali di cui si è detto. Questa dinastia di cultura greca cercò di imporre a tutti i costi gli usi e i costumi ellenici, che però facevano a pugni con le tradizioni giudaiche e soprattutto con la Legge e i riti del tempio.
Il vertice di questa tensione è richiamato perfino da Gesù che dice in Mt 24,15 «Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione, di cui parlò il profeta Daniele, stare nel luogo santo - chi legge comprenda...».
L'"abominio della desolazione" si riferisce al gesto di Antioco Epifane che nel 167 a. C. costruì un altare a Giove nel luogo dell'altare dei sacrifici all'interno del tempio di Gerusalemme e in sovrappiù, vi sacrificò un maiale, animale che la Legge ebraica considera impuro.
Di questo fatto ne parla il libro di Daniele in forma profetico-apocalittica e, per via dell'incertezza della data di composizione del testo, non sappiamo se si tratta di un previsione o di profezia post eventum:
Dn 9,27 «Egli stringerà una forte alleanza con molti / per una settimana e, nello spazio di metà settimana,
farà cessare il sacrificio e l'offerta; / sull'ala del tempio porrà l'abominio della desolazione
e ciò sarà sino alla fine,/ fino al termine segnato sul devastatore».
Ora, noi dovremmo fare uno sforzo d'immaginazione per cercare di comprendere i sentimenti di afflizione degli ebrei che assistevano o raccontavano questo avvenimento. Un evento impensabile, mai accaduto prima e che metteva perfino in discussione la presenza di Dio nel tempio.
Come poteva l'Altissimo tollerare una cosa del genere?
Perché Dio non era intervenuto per impedirla?
E che fine avevano fatto tutte le promesse di Dio assicurate a Davide e ai patriarchi?
E perché Dio non si faceva sentire con "mano potente e braccio teso", come aveva fatto con i Padri?
E dove erano finite tutte le promesse legate all'Elezione?
Ecco, è in questa situazione che emerge un profeta il quale cerca di dare speranza e fiducia al popolo demoralizzato.
Ora, il libro di questo sconosciuto autore, non tratta la situazione attuale, ma parla di un altro profeta di nome Daniele, appunto, deportato a Babilonia da Nabucodònosor e introdotto alla corte reale. In quel contesto Daniele ha sogni e visioni a riguardo del futuro, che in realtà sono eventi già avvenuti perché colui che scrive vive trecento anni dopo.
Quindi il libro di Daniele fa una rilettura della storia tracciando una "teologia della storia".
La storia viene in qualche modo riferita a Dio che al momento opportuno interviene per raddrizzarla.
Così veniamo al testo che ci interessa e al quale si riferisce Gesù quando parla di "Figlio dell'Uomo".
Da 7:1 «Nel primo anno di Baldassàr re di Babilonia, Daniele, mentre era a letto, ebbe un sogno e visioni nella sua mente. Egli scrisse il sogno e ne fece la relazione che dice:
Le quattro bestie
2 Io, Daniele, guardavo nella mia visione notturna ed ecco, i quattro venti del cielo si abbattevano impetuosamente sul Grande Mare ( Mediterraneo) 3 e quattro grandi bestie, differenti l'una dall'altra, salivano dal mare. 4 La prima era simile ad un leone e aveva ali di aquila. Mentre io stavo guardando, le furono tolte le ali e fu sollevata da terra e fatta stare su due piedi come un uomo e le fu dato un cuore d'uomo.
5 Poi ecco una seconda bestia, simile ad un orso, la quale stava alzata da un lato e aveva tre costole in bocca, fra i denti, e le fu detto: «Su, divora molta carne».
6 Mentre stavo guardando, eccone un'altra simile a un leopardo, la quale aveva quattro ali d'uccello sul dorso; quella bestia aveva quattro teste e le fu dato il dominio.
7 Stavo ancora guardando nelle visioni notturne ed ecco una quarta bestia, spaventosa, terribile, d'una forza eccezionale, con denti di ferro; divorava, stritolava e il rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava: era diversa da tutte le altre bestie precedenti e aveva dieci corna.
8 Stavo osservando queste corna, quand'ecco spuntare in mezzo a quelle un altro corno più piccolo, davanti al quale tre delle prime corna furono divelte: vidi che quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che parlava con alterigia.
Il numero quattro è un simbolo cosmico che indica l'intera creazione perché quattro sono i punti cardinali, quattro gli elementi da cui deriva tutto: terra, acqua, fuoco e aria.
Le bestie nella letteratura apocalittica rappresentano i regni, la politica; anche Dante ne farà uso. Rappresentare gli imperi con delle bestie feroci è un modo per indicare come i governanti trattano i popoli.
La quarta bestia è talmente orribile e spaventosa da non poter neanche essere descritta.
Le corna probabilmente rappresentano un segno di potenza e un rimando ai tori che per diverse religioni dell'Antico Oriente erano rappresentazione degli dèi, quando non addirittura questi stessi animali considerati dèi.
Il mondo di Dio
9 Io continuavo a guardare, / quand'ecco furono collocati troni / e un vegliardo si assise.
La sua veste era candida come la neve / e i capelli del suo capo erano candidi come la lana;
il suo trono era come vampe di fuoco / con le ruote come fuoco ardente.
10 Un fiume di fuoco scendeva dinanzi a lui, / mille migliaia lo servivano
e diecimila miriadi lo assistevano. / La corte sedette e i libri furono aperti.
11 Continuai a guardare a causa delle parole superbe che quel corno proferiva, e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare sul fuoco.
12 Alle altre bestie fu tolto il potere e fu loro concesso di prolungare la vita fino a un termine stabilito di tempo.
Le vesti candide sono indice di purezza e santità. Il fuoco è un elemento teofanico che rivela la presenza di Dio.
Lo stesso fuoco distrugge ciò che impuro, malvagio, le quattro bestie, in questo caso.
Il Figlio dell'Uomo
13 Guardando ancora nelle visioni notturne, / ecco apparire, sulle nubi del cielo,
uno, simile ad un figlio di uomo; / giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui,
14 che gli diede potere, gloria e regno; / tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano;
il suo potere è un potere eterno, / che non tramonta mai, e il suo regno è tale / che non sarà mai distrutto.
Spiegazione della visione
15 Io, Daniele, mi sentii venir meno le forze, tanto le visioni della mia mente mi avevano turbato; 16 mi accostai ad uno dei vicini e gli domandai il vero significato di tutte queste cose ed egli me ne diede questa spiegazione: 17 «Le quattro grandi bestie rappresentano quattro re, che sorgeranno dalla terra; 18 ma i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per secoli e secoli».
19 Volli poi sapere la verità intorno alla quarta bestia, che era diversa da tutte le altre e molto terribile, che aveva denti di ferro e artigli di bronzo e che mangiava e stritolava e il rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava; 20 intorno alle dieci corna che aveva sulla testa e intorno a quell'ultimo corno che era spuntato e davanti al quale erano cadute tre corna e del perché quel corno aveva occhi e una bocca che parlava con alterigia e appariva maggiore delle altre corna. 21 Io intanto stavo guardando e quel corno muoveva guerra ai santi e li vinceva, 22 finché venne il vegliardo e fu resa giustizia ai santi dell'Altissimo e giunse il tempo in cui i santi dovevano possedere il regno.
23 Egli dunque mi disse: «La quarta bestia significa che ci sarà sulla terra un quarto regno diverso da tutti gli altri e divorerà tutta la terra, la stritolerà e la calpesterà.
24 Le dieci corna significano che dieci re sorgeranno da quel regno e dopo di loro ne seguirà un altro, diverso dai precedenti: abbatterà tre re 25 e proferirà insulti contro l'Altissimo e distruggerà i santi dell'Altissimo; penserà di mutare i tempi e la legge; i santi gli saranno dati in mano per un tempo, più tempi e la metà di un tempo. 26 Si terrà poi il giudizio e gli sarà tolto il potere, quindi verrà sterminato e distrutto completamente. 27 Allora il regno, il potere e la grandezza di tutti i regni che sono sotto il cielo saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo, il cui regno sarà eterno e tutti gli imperi lo serviranno e obbediranno».
28 Qui finisce la relazione. Io, Daniele, rimasi molto turbato nei pensieri, il colore del mio volto si cambiò e conservai tutto questo nel cuore.
Decifrazione storica
La prima bestia rappresenta l'Impero Babilonese, il suo re Nabucodònosor e relativi successori.
La seconda bestia l'Impero Persiano. Nel 539 a. C. Ciro il Grande conquista Babilonia e nasce così l'Impero Persiano.
La terza bestia si riferisce all'Impero fondato da Alessandro Magno.
La quarta, la più terribile, raffigura l'Impero Ellenistico dei Seleucidi, quello che dominava la Palestina al tempo del nostro ignoto scrittore. Si chiarisce anche il significato delle dieci corna che rappresentano i dieci sovrani di quella dinastia.
Il corno centrale quello più forte degli altri potrebbe essere l'ultimo, l'autore dell'"abominio della desolazione".
Il Regno di Giudea
Una certa attenuazione dell'oppressione si ebbe in Giudea con la rivolta dei Maccabei che riuscirono a fondare nel 140 a. C. un Regno di Giudea con l'aiuto più o meno sincero dei romani che si stavano affacciando su quella regione. Però nel 63 a. C. Pompeo conquistò Gerusalemme che divenne a tutti gli effetti un provincia romana, con procuratore nominato da Roma.
Tutte le speranze e le attese degli ebrei andarono in fumo un'altre volta, rendendosi conto di essere passati da un padrone ad un altro.
Quindi l'attesa di un liberatore che venisse da Dio era più che comprensibile
Perciò possiamo comprendere come il libro di Daniele alimentasse questa speranza perché conteneva la promessa che tutti questi regni sarebbero stati spazzati via dall'avvento del Regno del Figlio dell'Uomo, un personaggio che mandato da Dio, il quale avrebbe instaurato il Regno eterno dei Santi.
Allora quando Gesù parla di se come "Figlio dell'Uomo" non usa semplicemente un titolo onorifico, ma indica un programma che si pone nel fuoco di queste speranze prospettandone il compimento.
Non per niente, come abbiamo visto, il Vangelo di Marco inizia con l'annuncio del Regno.
Lettura 20 La prima controversia galilaica: il paralitico Mc 2,1 -12.
Le controversie galilaiche sono organizzate in una struttura compatta ma anche esaminate singolarmente, hanno ciascuna un significato molto importante, che non può essere trascurato. Pertanto procederemo nell'esame analitico di ognuna di esse per passare poi raccoglierle insieme.
2:1 Ed essendo entrato di nuovo a Cafarnao alcuni giorni dopo, si udì che era in casa. 2 E si riunirono / adunarono / sun-agō molti così che non c'era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la Parola.
3 E vengono portando a lui un paralitico portato da quattro persone. 4 E non potendolo presentare a lui a causa della folla, scoperchiarono la terrazza nel punto dov'egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui giaceva il paralitico. 5 E Gesù, vedendo la loro fede, dice al paralitico: «Figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati».
6 Ora, vi erano seduti là alcuni scribi e ragionavano / dialogizō in cuor loro: 7 «Perché costui dice così? Egli bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non l'unico Dio?».
8 E subito avendo Gesù conosciuto nel suo spirito che ragionavano/ dialogizō così in se stessi, dice loro: «Perché pensate/ dialogizō così su queste cose nei vostri cuori? 9 Che cosa è più facile dire al paralitico: "Sono rimessi i tuoi peccati", o dire: "Alzati / egeirō, prendi la tua barella e cammina?". 10 Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha l'exousia / potere di rimettere peccati sulla terra, 11 - dice al paralitico - alzati / egeirō prendi la tua barella e va' a casa tua». 12 E quegli si alzò / egeirō, e subito prese la sua barella, uscì dinanzi a tutti, così che tutti erano fuori di sé e glorificavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!».
Gesù è ancora circondato dalla folla, segno che la sua proclamazione / kērussō del Regno suscita grandi attese da parte dei galilei.
Il termine greco sun-agō è sibillino; letteralmente significa "insieme-andare" da cui il vocabolo "sinagoga" per indicare le riunioni sacre. Qui però la riunione non è in un luogo sacro, ma in una casa. Forse l'evangelista ci vuole suggerire che il sacro è uscito da luoghi riservati per entrare nelle nostre case?
Questo "assedio" della folla davanti alla casa, giustifica l'azione che i quattro portatori devono compiere per presentare il paralitico a Gesù.
Gli esperti ci dicono che i tetti, per lo più terrazze, erano costituiti da travi di legno su cui venivano poste canne con paglia e ciò spiegherebbe perché i cinque possano salire sul tetto e scoperchiarlo senza cadere di sotto.
La grande fatica e genialità di questi portatori rivela che erano animati da una grande fede, una "fede operosa", che già di per sé è una forma di supplica.
Colpisce che Gesù è mosso ad intervenire, non dalla fede del paralitico, ma da quella dei portatori. Questo ci porta a prendere in considerazione la preghiera di intercessione, la preghiera fatta per altri e il ruolo della comunità cristiana quando prega per tutti. Ricordiamo questo fatto evangelico quando andando alla messa feriale si trovano solo quattro gatti quattro. Essi sono coloro che intercedono per tutti gli altri... un compito prezioso!
Tutto il racconto verte sulla remissione dei peccati e chi li rimette.
Il Primo Testamento professava il perdono dei peccati come azione di Dio. Solo Dio può perdonare i peccati.
Ma c'è di più. Dio agisce in modo che l'uomo si renda conto del male compiuto, se ne penta e chieda perdono.
Prendiamo ad esempio il grande peccato del re Davide, il quale aveva consumato un adulterio con Betsabea, moglie di Uria e quando essa rimase incinta, agì in modo tale da farne uccidere il marito in battaglia. Nessuno se ne accorse. La tresca aveva avuto pieno successo. Ma Dio non dormiva e manda a Davide il profeta Natan perché si assuma le sue responsabilità. Questa parte è raccontata in 2 Sam 11 che non riportiamo, ma consigliamo di leggere; e passiamo alla conclusione.
2 Sam 12,1 JHWH mandò il profeta Natan a Davide e Natan andò da lui e gli disse: «Vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. 2 Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero; 3 ma il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprata e allevata; essa gli era cresciuta in casa insieme con i figli, mangiando il pane di lui, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno; era per lui come una figlia. 4 Un ospite di passaggio arrivò dall'uomo ricco e questi, risparmiando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso, per preparare una vivanda al viaggiatore che era capitato da lui portò via la pecora di quell'uomo povero e ne preparò una vivanda per l'ospite venuto da lui».
5 Allora l'ira di Davide si scatenò contro quell'uomo e disse a Natan: «Per la vita di JHWH, chi ha fatto questo merita la morte. 6 Pagherà quattro volte il valore della pecora, per aver fatto una tal cosa e non aver avuto pietà». 7 Allora Natan disse a Davide: «Tu sei quell'uomo! Così dice JHWH, Dio d'Israele: Io ti ho unto re d'Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, 8 ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la casa di Israele e di Giuda e, se questo fosse troppo poco, io vi avrei aggiunto anche altro. 9 Perché dunque hai disprezzato la parola di JHWH, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'Hittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. 10 Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'Hittita. 11 Così dice il Signore: Ecco io sto per suscitare contro di te la sventura dalla tua stessa casa; prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un tuo parente stretto, che si unirà a loro alla luce di questo sole; 12 poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole».
13 Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro JHWH!». Natan rispose a Davide: «JHWH ha perdonato il tuo peccato; tu non morirai. 14 Tuttavia, poiché in questa cosa tu hai insultato JHWH (l'insulto sia sui nemici suoi), il figlio che ti è nato dovrà morire». Natan tornò a casa.
La tradizione dice che il pentimento di Davide lo porta a comporre il Salmo 51 (50) Miserere (e vale la fatica di leggerlo).
Un altro esempio è offerto dal profeta Isaia che durante una visione viene inviato da Dio ad annunciare la sua Parola, ma egli non si ritiene adatto perché le sue labbra sono impure, ma Dio provvede alla purificazione di Isaia tramite un angelo.
Is 6,6 Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. 7 Egli mi toccò la bocca e mi disse: / «Ecco, questo ha toccato le tue labbra,
perciò è scomparsa la tua iniquità / e il tuo peccato è espiato».
In questo caso oltretutto appare un concetto sconvolgente: non è l'uomo che espia il suo peccato, ma è Dio.
Pur mettendoci tutto il suo impegno, le sue penitenze, i suoi digiuni, l'uomo non sarebbe mai in grado di cancellare l'offesa prodotta con il suo peccato. Solo Dio può fare questo. L'espiazione di Dio ha il nome di "perdono".
Tornando al nostro brano dobbiamo dire che per gli interlocutori di Gesù era chiaro che solo Dio può perdonare i peccati, allora la mormorazione degli scribi, gli esperti delle sacre scritture, non è del tutto impertinente perché per loro Gesù è solo un profeta e come tale non è in grado di perdonare i peccati.
L'obiezione è provvidenziale perché il dibattito e l'azione seguente sono rivelativi, dicono chi è Gesù, che, ricordiamo, è il tema della prima parte del vangelo di Marco.
La rivelazione è: "Il Figlio dell'Uomo ha il potere / exousìa di rimettere i peccati".
Chiariamo: Gesù non dice che rimette i peccati, ma che ha il potere di rimetterli. Un potere che gli è stato dato da Dio. E sappiamo dalla lettura precedente cosa significa "Figlio dell'Uomo".
Però nessuno può verificare se i peccati del paralitico siano stati effettivamente rimessi perché non c'è alcuna esperienza empirica che lo possa dimostrare.
La prova è allora fornita da Gesù stesso attraverso la guarigione del paralitico.
Ciò a maggior ragione dovette essere convincente per gli scribi (convinzione non condivisa da Gesù, come vedremo) in quanto essi credevano che le malattie, nel nostro caso la paralisi, fossero la conseguenza di peccati commessi magari in tempi remoti dai genitori o anche da generazioni precedenti, per cui se il paralitico guarisce vuol dire che i suoi peccati non ci sono più.
In definitiva risulta che il Figlio dell'Uomo ha il potere / exousìa di rimettere i peccati
Viene così ribadito il tema dell'exousìa che avevamo già incontrato nella sinagoga di Cafarnao dove: "insegnava con exousìa e cacciava i demoni con exousìa".
Ritroviamo il verbo egeirō che avevamo già incontrato nella lettura 15 che significa: alzati, svegliati ed è il verbo che annuncia la risurrezione come descritto in Mc 16, 6, per cui l'uso di questo verbo dice qualcosa di più di una semplice guarigione; il paralitico è un uomo nuovo.
Nuovo al punto di andarsene mettendosi lettuccio sulle spalle.
E non si è fatta neanche un'ora di fisioterapia...
Lettura 21 La seconda controversia galilaica: la chiamata di Levi Mc 2,13-17
Mc 2,13 Uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. 14 E passando vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli dice: «Seguimi». Ed egli, alzatosi / egeirō, lo seguì.
15 E avviene che Gesù si trovasse a tavola / katàkeimai nella sua casa e molti pubblicani e peccatori si misero a tavola / katàkeimai con Gesù e i suoi discepoli; perché erano molti infatti quelli che lo seguivano. 16 E gli scribi dei farisei, vedendo che mangiava con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia con i pubblicani e i peccatori?». 17 Avendo udito questo, Gesù disse loro: «Non hanno bisogno del medico i sani, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori».
Premessa
Il termine "pubblicano" deriva dal latino(link is external) publicānus, dalla radice publĭcum che significa: tesoro pubblico, imposte. In particolare nelle province conquistate, come Israele, i pubblicani erano malvisti perché venivano considerati collaboratori del governo d'occupazione romano. Ricordiamo che al tempo delle rivolte dei Maccabei i romani si presentano nello scenario orientale come amici di Israele, combattendo contro i seleucidi, ma qualche decennio prima degli eventi evangelici, Pompeo, mette fine al Regno di Giudea e riduce il paese a provincia romana cambiandole perfino il nome in Palestina.
I pubblicani stipulavano con il governo romano dei contratti pubblici per vari fini, quali la gestione delle forniture militari all'esercito, il finanziamento della costruzione di edifici pubblici, l'esazione di tasse doganali e di redditi dei terreni. Essi anticipavano al governo il valore delle tasse richieste per poi recuperarle addizionate del loro aggio, che secondo gli autori antichi (Lucullo, Gabinio), poteva anche essere molto consistente, fino al 45%. Spesso, inoltre, i pubblicani traevano arbitrariamente vantaggio dall'indeterminatezza con cui venivano stabilite le tasse. Erano organizzati in "collegi" e per l'ammontare delle somme gestite costituivano un ordine molto potente (lobby). Le somme guadagnate erano usate per fare prestiti con interessi da usura, per cui erano spesso erano anche usurai. Essendo poi molto ricchi spesso si abbandonavano a lussi sfrenati, abusi e immoralità.
Levi è un ebreo che fa questo mestiere.
Anche questo brano inizia con Gesù circondato dalle folle e come nel racconto della chiamata dei primi discepoli ci troviamo lungo il mare. Ed è passando da lì che "vide" Levi figlio di Alfeo...
Facciamoci aiutare dall'immaginazione per comprendere la situazione sociologica e psicologica di Levi.
Quest'uomo aveva pensato che fare il pubblicano sarebbe stato un grande affare perché si poteva guadagnare un sacco di soldi e vivere da gran signore: avrebbe potuto soddisfare tutti i suoi capricci, avere tutte le donne che voleva, vivere nel lusso e così via. Ma poi si era reso conto che non era affatto così. Un po' alla volta aveva perso gli amici, nessuno voleva avere a che fare con lui, tutti suoi legami affettivi erano andati a ramengo. Se qualcuno lo cercava era solo per interesse o perché era interessato ai suoi soldi; donne comprese. Quando andava per strada la gente lo evitava, qualcuno lo insultava, altri gli sputavano davanti. Anche quando frequentava i suoi "amici" romani, sempre lo guardavano dall'alto in basso e anche loro lo disprezzavano, anzi era costretto a dare loro anche una parte dei suoi guadagni per tenerseli buoni; oggi diremmo "tangenti".
Certo, aveva guadagnato un sacco di soldi, ma non c'era nessuno con cui condividerli se non qualche prostituta o qualcuno che sperava in uno sconto sulle tasse.
Alla fine dei conti non ne poteva più di questa vita, ma non sapeva come fare a cambiarla.
Bene, in questa situazione, con i soliti pensieri che gli frullavano nella testa, incapace di dare una svolta a questo andazzo, proprio in quel giorno, mentre era seduto dietro il suo banco, gli passa vicino l'Uomo diventato famoso perché insegnava con exousia, cacciava i demoni con exousìa, cioè, con un semplice comando della voce, guariva gli ammalati sempre con exousìa, con una sola parola... e pare, così diceva la gente, che venga da Dio. Lui dice di essere "il Figlio dell'Uomo". E questo uomo gli passa vicino e... «lo vide».
Lì c'è l'incrocio di due sguardi che dice di più di molti lunghi discorsi... e Costui gli dice: «Vieni e seguimi».
Ecco, quello sguardo e queste due parole gli hanno dato il coraggio di dare un calcio al suo banco, mollare tutto e andargli dietro.
Questo il testo lo dice con la parolina che abbiamo già incontrato: «egeirō, alzati, svegliati»; sempre il vocabolo che annuncia la risurrezione.
Così si ripete la stessa storia dell'arruolamento dei primi quattro: quelli rassettavano le reti, questo riscuoteva le tasse, mica stavano pregando, non erano rapiti da estasi mistiche... E si rinnova la stessa "anomalia" di questo "strano" genere di arruolamento: nessuna indagine, nessun colloquio preliminare, nessun percorso vocazionale o periodo di noviziato, nessuna selezione, niente di niente: solo «Vieni e seguimi».
Per usare un linguaggio chiesastico potremmo dire che lo segue perché ha scoperto il "tesoro nel campo", come si dirà nella parabola di Mc 13, ma questo pubblicano non sa ancora di alcun tesoro; sa solo che deve mollare tutta quella fogna che ha coltivato fino ad ora.
Tra i due non c'è un semplice rapporto maestro - discepolo, ma comunione che si esprime nel mangiare a casa sua, di Levi. La condivisione del cibo tra gli umani non è semplice esaudimento di un bisogno fisiologico, perché questo lo fanno gli animali i quali si nutrono, mentre gli umani "pranzano". Il pranzo per tutti gli esseri umani è il momento di una relazione profonda. Ma questi secondo l'uso del tempo mangiano katàkeimai, cioè sdraiati sul triclinio, cioè stravaccati. Allora si tratta di una relazione più che profonda: Levi ha organizzato un banchetto in piena regola secondo l'uso greco-romano.
Però a casa di Levi ci sono anche i suoi colleghi, altri pubblicani e peccatori, come lui. Ma il testo è sibillino, infatti dice:«perché erano molti infatti quelli che lo seguivano» e la terza persona non ci permette di capire se questi "pubblicani e peccatori" facevano parte della compagnia di Levi o di quella di Gesù. Probabilmente di entrambe perché Gesù non selezionava i suoi seguaci: Lui pranzava con tutti. Comunque è tutta gente che viene emarginata dalle "persone per bene".
E qui emerge una seconda anomalia del comportamento di Gesù: la frequentazione di persone di dubbia reputazione: pubblicani, peccatori, prostitute, lebbrosi, emarginati di ogni genere, insomma tutta quella "gentaglia" dalla quale la gente per bene deve stare alla larga.
Però, se gli scribi dei farisei criticano il comportamento di Gesù è perché, tutto sommato, anch'essi riconoscono in lui un profeta, un uomo vicino a Dio, altrimenti non l'avrebbero nemmeno preso in considerazione.
Tuttavia non affrontano Gesù direttamente, ma si rivolgono ai discepoli.
La risposta di Gesù è composta da due sentenze, la prima, forse un proverbio.
La seconda spiega lo scopo della sua venuta. E questa è una affermazione rivelativa. Ricordiamo che siamo nella prima parte del vangelo di Marco che cerca di comprendere "Chi è Gesù".
«Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». Questa affermazione è problematica perché se non è bene intesa saremmo di fronte ad una scelta di campo... e spesso essa viene omileticamente radicalizzata creando grandi problemi a chi ascolta, come quando si sente parlare di scelta dei poveri, scelta degli emarginati, dei diseredati, ecc.
E uno dice: e tutti gli altri?
Nel nostro caso l'alternativa è tra giusti e peccatori.
Usciamo dal dilemma con una domanda: "C'è qualcuno che di fronte a Dio può affermare di non essere peccatore"?
Forse ci sono dei "giusti" che usano la Legge come ricatto verso Dio: "Io ho fatto tutto quello che c'era da fare: ho rispettato il sabato, ho pagato le decime, non frequentato persone di malaffare, ecc., adesso tu, Dio, "devi" ammazzare per me il vitello grasso... perché io ho fatto tutto quello che ti dovevo"
E per chi la pensa così la "conversione" del cuore è molto problematica.
Lettura 22 La terza controversia galilaica: discussione sul digiuno Mc 2,18-22 Prima parte
Il brano della discussione sul digiuno è carica di simboli provenienti dal Primo Testamento, che se non sono ben compresi trasformano la risposta di Gesù nelle solite interpretazioni allegoriche che lasciano il tempo che trovano.
Dobbiamo fare lo sforzo di afferrare a quali tematiche allude Gesù quando parla di sé come "lo sposo".
Nel Primo Testamento, a partire dal Profeta Osea, viene prospettato il rapporto Dio-Israele, sul modello del rapporto coniugale marito-moglie. Da lui in poi il tema viene sviluppato e approfondito da altri profeti.
E non dobbiamo dimenticare il Cantico dei Canti che descrive i sentimenti di due innamorati che si cercano continuamente e gemono quando non sono uno nelle braccia dell'altro; il tutto descritto con un linguaggio e un simbolismo che a noi occidentali non dice molto, ma che nella cultura orientale era ed è indubbiamente erotico. È un libro che più volte ha rischiato di essere espunto dal canone delle Scritture.
Noi ci facciamo illuminare dal profeta Osea che vive nel Regno del Nord in un periodo alquanto burrascoso: guerra con gli aramei, poi con gli assiri, rivolte interne e quattro re assassinati nell'arco di quindici anni.
Gli esperti affermano che Osea non vedrà la Caduta di Samaria e la fine del Regno del Nord avvenuta nel 721 a. C. tuttavia le sue profezie mostrano che anche in frangenti così crudi, Dio non stava zitto e suscitava sempre qualche profeta che tenesse accesa la speranza di una vita buona.
L'inizio del suo libretto descrive una "azione simbolica", che non è semplice racconto, ma reale fatto di vita per mostrare al popolo in quale drammatica situazione esso si era cacciato. Il motivo è l'idolatria intesa come "prostituzione agli idoli".
Osea, come tutti i profeti, non prevede il futuro, ma fa una lettura teologica della storia: quella che gli è stata tramandata, quella di cui è testimone osando perfino a ipotizzare come andrà a finire. Ovviamente Osea è un agiografo, cioè uno scrittore ispirato per cui i suoi scritti sono riconosciuti come "Parola di Dio".
Come premessa, per comprendere il testo proposto, dobbiamo spiegare cosa accadde a Izreèl a cui si riferisce il profeta. Izreèl è una verde vallata alquanto pianeggiante all'interno di tutta la montuosa terra di Israele. Essa è attraversata fina da tempi antichi dalla "via Maris" il percorso che collegava l'Egitto con la Mesopotamia. Via di traffici commerciali e all'occasione, luogo propizio allo scontro tra eserciti, quindi luogo di molte battaglie.
In Izreèl i re d'Israele avevano costruita una splendida residenza dove preferivano soggiornare invece che a Samaria.
In quel luogo intorno al 841 a. C., Ieu generale dell'esercito di Israele, uccide il suo re, Ioram e con lui il re di Giuda, Acazia, che si trovava in visita. Tutto questo è narrato da 2 Re 9-10, con particolari raccapriccianti.
Os 1:1 Parola JHWH rivolta a Osea figlio di Beerì, al tempo di Ozia, di Iotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo (783-743 a. C.) figlio di Ioas, re d'Israele.
2 Quando JHWH cominciò a parlare a Osea, gli disse: / «Va', prenditi in moglie una prostituta
e abbi figli di prostituzione, / poiché il paese non fa che prostituirsi / allontanandosi da JHWH».
3 Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblàim: essa concepì e gli partorì un figlio.
4 E il JHWH disse a Osea: / «Chiamalo Izreèl, perché tra poco
vendicherò il sangue di Izreèl sulla casa di Ieu / e porrò fine al regno della casa d'Israele.
5 In quel giorno / io spezzerò l'arco d'Israele nella valle di Izreèl».
6 La donna concepì di nuovo e partorì una figlia e JHWH disse a Osea:
«Chiamala Non-amata, / perché non amerò più / la casa d'Israele, / non ne avrò più compassione. [...]
8 Dopo aver divezzato Non-amata, / Gomer concepì e partorì un figlio.
9 E il JHWH disse a Osea:
«Chiamalo Non-mio-popolo, / perché voi non siete mio popolo / e io non esisto per voi».
Queste sono parole di condanna verso Israele per tutto il male compiuto: popolo, re, dignitari, sacerdoti, ecc.
Nel secondo capitolo Dio si raffigura come un marito tradito dalla sua sposa /popolo ed elenca una serie di terribili minacce come sua vendetta contro tutte le prostituzioni compiute.
Os 2, 4 Accusate vostra madre, accusatela, / perché essa non è più mia moglie
/ e io non sono più suo marito! [...]
Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni / e i segni del suo adulterio dal suo petto;
5 altrimenti la spoglierò tutta nuda / e la renderò come quando nacque /
e la ridurrò a un deserto, come una terra arida, / e la farò morire di sete.
6 I suoi figli non li amerò, / perché sono figli di prostituzione.
7 La loro madre si è prostituita, / la loro genitrice si è coperta di vergogna.
Essa ha detto: «Seguirò i miei amanti, [idoli] / che mi danno il mio pane e la mia acqua,
la mia lana, il mio lino, / il mio olio e le mie bevande».
8 Perciò ecco, ti sbarrerò la strada di spine / e ne cingerò il recinto di barriere / e non ritroverà i suoi sentieri.
9 Inseguirà i suoi amanti, / ma non li raggiungerà, / li cercherà senza trovarli.
Allora dirà: «Ritornerò al mio marito di prima / perché ero più felice di ora».
10 Non capì che io le davo / grano, vino nuovo e olio
e le prodigavo l'argento e l'oro / che hanno usato per Baal.
11 Perciò anch'io tornerò a riprendere / il mio grano, a suo tempo,
il mio vino nuovo nella sua stagione; / ritirerò la lana e il lino / che dovevan coprire le sue nudità.
12 Scoprirò allora le sue vergogne / agli occhi dei suoi amanti / e nessuno la toglierà dalle mie mani.
13 Farò cessare tutte le sue gioie, / le feste, i noviluni, i sabati, tutte le sue solennità.
14 Devasterò le sue viti e i suoi fichi, / di cui essa diceva: / «Ecco il dono che mi han dato i miei amanti».
La ridurrò a una sterpaglia / e a un pascolo di animali selvatici.
15 Le farò scontare i giorni dei Baal, / quando bruciava loro i profumi,
si adornava di anelli e di collane / e seguiva i suoi amanti / mentre dimenticava me! / - Oracolo del JHWH.
Ora, uno che parla così è un innamorato che si sente tradito e umiliato nel più profondo del suo cuore; un cuore spezzato dai tanti tradimenti e umiliazioni inflitte. La vendetta non potrà essere che terribile. E invece:
16 Perciò, ecco, la attirerò a me, / la condurrò nel deserto / e parlerò al suo cuore.
17 Le renderò le sue vigne / e trasformerò la valle di Acòr / in porta di speranza.
Là canterà / come nei giorni della sua giovinezza, / come quando uscì dal paese d'Egitto.
18 E avverrà in quel giorno / - oracolo del JHWH - / mi chiamerai: Marito mio,
e non mi chiamerai più: Mio padrone.
19 Le toglierò dalla bocca / i nomi dei Baal, / che non saranno più ricordati.
20 In quel tempo farò per loro un'alleanza / con le bestie della terra / e gli uccelli del cielo
e con i rettili del suolo; / arco e spada e guerra / eliminerò dal paese; / e li farò riposare tranquilli.
21 Ti farò mia sposa per sempre, / ti farò mia sposa
nella giustizia e nel diritto, / nella benevolenza e nell'amore,
22 ti fidanzerò con me nella fedeltà / e tu conoscerai JHWH.
23 E avverrà in quel giorno / - oracolo del JHWH - / io risponderò al cielo / ed esso risponderà alla terra;
24 la terra risponderà con il grano, / il vino nuovo e l'olio / e questi risponderanno a Izreèl.
25 Io li seminerò /izreèl di nuovo per me nel paese / e amerò Non-amata;
e a Non-mio-popolo dirò: Popolo mio, / ed egli mi dirà: Mio Dio.
Questa è la vendetta di JHWH: una pace duratura non solo con il suo popolo, ma una pace che coinvolge l'intera creazione: un cielo che risponde alla terra con la pioggia, una terra che risponderà con il grano, il vino e l'olio.
E forse riusciamo a cogliere il senso del luogo citato all'inizio e alla fine: Izreèl, che trascriviamo come è in ebraico: Izre-El, letteralmente: semina di Dio o Dio semina. Quindi un luogo in cui non sono accaduti solo fatti terribili e battaglie sanguinose, ma che diventa una verde valle in cui il seminatore è Dio stesso e il raccolto assicurato.
Ecco, quando Gesù si presenta come "lo sposo alle nozze" fa un discorso rivelativo.
Lui realizza quel disegno che il Padre aveva anticipato sin dalla creazione del mondo.
Attraverso i misteri dell'Incarnazione e della Redenzione Dio diventa, in Gesù, lo sposo fedele della comunità dei suoi fedeli: della Chiesa anzitutto, e attraverso di essa, dell'umanità intera.
Lettura 23 La terza controversia galilaica: discussione sul digiuno Mc 2,18-22 Seconda parte
Mc 2,18 Ora i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono allora da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?». 19 Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo Sposo è con loro? Finché hanno lo Sposo con loro, non possono digiunare. 20 Ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo Sposo e allora digiuneranno.
21 Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio; altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore.
22 E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi».
La domanda dei discepoli di Giovanni non è impertinente perché si rendono conto che i discepoli di Gesù non rispettano le regole della tradizione.
La prassi del digiuno è ben documentata sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento.
I vangeli sinottici si aprono con la prova di Gesù nel deserto, che implica il digiuno:
Mt 4:1 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. 2 E dopo aver digiunatoquaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. 3 Il tentatore allora gli si accostò e gli disse...
Nella nostra riflessione sul libro di Giona alla lettura 16, abbiamo trovato il digiuno penitenziale cui i cittadini di Ninive si sottopongono perché Dio non distrugga la città; un digiuno che coinvolge perfino gli animali.
Gio 3, 5 «I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. 6 Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. 7 Poi fu proclamato in Ninive questo decreto, per ordine del re e dei suoi grandi: «Uomini e animali, grandi e piccoli, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. 8 Uomini e bestie si coprano di sacco e si invochi Dio con tutte le forze; ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. 9 Chi sa che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno sì che noi non moriamo?». 10 Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece».
Il profeta Isaia ispirato da Dio si scaglia contro gli abitanti di Gerusalemme che praticano un digiuno puramente formale e questo ci suggerisce quale debba essere la qualità di un digiuno gradito a Dio:
Is 58:1 «Grida a squarciagola, non aver riguardo; / come una tromba alza la voce;
dichiara al mio popolo i suoi delitti, / alla casa di Giacobbe i suoi peccati.
2 Mi ricercano ogni giorno, / bramano di conoscere le mie vie, / come un popolo che pratichi la giustizia
e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio; / mi chiedono giudizi giusti, / bramano la vicinanza di Dio:
3 «Perché digiunare, se tu non lo vedi, / mortificarci, se tu non lo sai?».
Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, / angariate tutti i vostri operai.
4 Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi / e colpendo con pugni iniqui.
Non digiunate più come fate oggi, / così da fare udire in alto il vostro chiasso.
5 È forse come questo il digiuno che bramo, / il giorno in cui l'uomo si mortifica?
Piegare come un giunco il proprio capo, / usare sacco e cenere per letto,
forse questo vorresti chiamare digiuno / e giorno gradito al Signore?
6 Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: / sciogliere le catene inique, / togliere i legami del giogo,
rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo?
7 Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, / nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto,
nel vestire uno che vedi nudo, / senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne?
8 Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, / la tua ferita si rimarginerà presto.
Davanti a te camminerà la tua giustizia, / la gloria del Signore ti seguirà.
9 Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà; / implorerai aiuto ed egli dirà: «Eccomi!».
Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, / il puntare il dito e il parlare empio,
10 se offrirai il pane all'affamato, / se sazierai chi è digiuno, / allora brillerà fra le tenebre la tua luce,
la tua tenebra sarà come il meriggio.
11 Ti guiderà sempre il Signore, / ti sazierà in terreni aridi, / rinvigorirà le tue ossa;
sarai come un giardino irrigato / e come una sorgente / le cui acque non inaridiscono.
12 La tua gente riedificherà le antiche rovine, / ricostruirai le fondamenta di epoche lontane.
Ti chiameranno riparatore di brecce, / restauratore di case in rovina per abitarvi.
13 Se tratterrai il piede dal violare il sabato, / dallo sbrigare affari nel giorno a me sacro,
se chiamerai il sabato delizia / e venerando il giorno sacro al Signore,
se lo onorerai evitando di metterti in cammino, / di sbrigare affari e di contrattare,
14 allora troverai la delizia nel Signore. / Io ti farò calcare le alture della terra,
ti farò gustare l'eredità di Giacobbe tuo padre, / poiché la bocca del Signore ha parlato».
La chiamata di Paolo e Barnaba a compiere il primo viaggio missionario avviene mentre la comunità dei discepoli di Antiochia sta pregando e digiunando:
At 13:1 «C'erano nella comunità di Antiochia profeti e dottori: Barnaba, Simeone soprannominato Niger, Lucio di Cirène, Manaèn, compagno d'infanzia di Erode tetrarca, e Saulo. 2 Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». 3 Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono».
Ma qual è il significato del digiunare?
Dai testi passati brevemente in rassegna notiamo che il digiuno può avere un significato penitenziale, può essere una forma di preghiera molto intensa, un aiuto per prendere decisioni importanti. Sembra pertanto che esso sia strettamente legato alla vita, qualcosa di molto più serio di come viene vissuto oggi che in ambito ecclesiale è ridotto ai minimi termini, in contrasto a quanto avviene per motivi molto banali quali la prova costume, il fitness et similia, al punto che c'è chi parla di una malattia molto diffusa e contagiosa: "la dietite".
Allora, quale significato potremmo dare al digiuno nella nostra epoca? Sembra molto intrigante quanto suggerisce Silvano Fausti, Ricorda e racconta il vangelo. La catechesi narrativa di Marco.
Secondo Fausti, il digiuno consiste in una volontaria privazione del cibo. E il cibo ha a che fare con la vita. Senza cibo si muore. Allora il digiuno, ovviamente temporaneo, vuole significare che c'è qualcosa di importante quanto il cibo se non più: il nutrimento della vita spirituale e nello stesso tempo il riconoscimento che la nostra vita è dono di Dio e da Lui dipende.
Ecco nel breve segmento corrispondente alla vita pubblica di Gesù, lo Sposo che sta celebrando la festa di nozze con l'umanità, come abbiamo visto nella lettura precedente, tutte queste pratiche di astensione dal cibo sono sospese.
Però il v20 ammonisce: «Ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo Sposo e allora digiuneranno», e questo è un chiaro riferimento ai futuri, ma non lontani, eventi pasquali.
Inoltre, la novità portata da queste nozze è così profonda e sconvolgente che quello che c'era prima non può assolutamente essere adattato.
Gli esempi del vestito rattoppato con della stoffa grezza o del vino nuovo in otri vecchie è più che chiaro.
Le antiche prassi religiose di tipo legalistico che registravano su un ipotetico libro il dare e l'avere verso Dio non possono più essere utilizzate.
Ci sarà una nuova Legge e una nuova Alleanza ed un nuovo e unico Sacrificio.
Lettura 24 Le quarta controversia galilaica: le spighe strappate di sabato Mc 2,23-28
Mc 2,23 «E avvenne che in giorno di sabato Gesù passasse attraverso i campi di grano e i suoi camminando, cominciarono a strappare le spighe. 24 I farisei gli dicevano: «Vedi! Perché fanno di sabato quel che non è lecito?». 25 Ma egli dice loro: «Non avete mai letto che cosa fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame, lui e quelli che erano con lui? 26 Come entrò nella casa di Dio, sotto il sommo sacerdote Abiatàr, e mangiò i pani dell'offerta, che soltanto ai sacerdoti è lecito mangiare, e ne diede anche ai suoi compagni?». 27E diceva loro: «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato! 28 Perciò il Figlio dell'uomo è signore anche del sabato».
Il problema che tratta questa pericope dipende dal fatto che la supposta trasgressione avviene in giorno di sabato.
Ma perché il sabato è così importante?
Il riposo del sabato è prescritto dal terzo comandamento del Decalogo e l'abbiamo già commentato nelle letture 82, 83, 84 del libro di Esodo. Lo riportiamo per comodità nella versione più antica, quella del Deuteronomio.
Dt 5,12 Osserva il giorno di sabato per santificarlo, come JHWH Dio tuo ti ha comandato. 13 Sei giorni faticherai e farai ogni lavoro, 14 ma il settimo giorno è il sabato per JHWH tuo Dio: non fare lavoro alcuno né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero, che sta entro le tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. 15Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che JHWH tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso; perciò JHWH tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato.
Allora il riposo sabbatico non è tanto destinato a passare una giornata davanti alla TV, in un centro commerciale o farci almeno 500 km di autostrada per non essere out, ma a fare memoria degli eventi della liberazione dalla schiavitù d'Egitto e soprattutto dalla schiavitù della morte. Infatti noi cristiani abbiamo fatto confluire la memoria dei due avvenimenti nell'ottavo giorno, la domenica, perché in quel giorno Dio, in Gesù, ha sconfitto la morte.
Ecco, i discepoli insieme a Gesù in un giorno di sabato passando per i campi, strappano alcune spighe di grano, le strusciano fra le mani e ne mangiano i chicchi.
L'antico comandamento vietava di mietere in giorno di sabato, ma sostenere che l'azione dei discepoli fosse una mietitura è una forzatura legalistica. I farisei erano un movimento che cercava di praticare devotamente la legge, ma spesso con puntigliosità interpretative che rendevano difficile la vita.
Alcuni esperti suggeriscono che i discepoli abbiano commesso un ulteriore infrazione, quella di preparare il cibo nel giorno del riposo. Il cibo per il sabato, secondo le interpretazioni rigoriste, doveva essere preparato il giorno prima e di sabato non si doveva neanche accendere il fuoco.
Non sappiamo se astenendosi da queste due azioni la memoria della liberazione dalla schiavitù d'Egitto fosse più brillante, comunque Gesù risponde per le rime alle critiche citando direttamente la Bibbia.
Il fatto ricordato, accadde quando il re Saul improvvisamente, fuori testa, cerca di uccidere Davide. Questi riesce ad evitare il fendente di lancia e scappa così come si trova, inseguito dai soldati che dovrebbero catturarlo. Finché stanco e affamato arriva a Nob, uno dei santuari sparsi in Israele. Prima che fosse edificato il tempio di Gerusalemme, Dio era invocato in molti santuari che la successiva unificazione del culto eliminò.
A Nob accadde il fatto citato da Gesù.
1 Sam 21,2 «Davide si recò a Nob dal sacerdote Achimelech (o Abiatàr). Achimelech, turbato, andò incontro a Davide e gli disse: «Perché sei solo e non c'è nessuno con te?». 3 Rispose Davide al sacerdote Achimelech: «Il re mi ha ordinato e mi ha detto: Nessuno sappia niente di questa cosa per la quale ti mando e di cui ti ho dato incarico. Ai miei uomini ho dato appuntamento al tal posto. 4 Ora però se hai a disposizione cinque pani, dammeli, o altra cosa che si possa trovare». 5 Il sacerdote rispose a Davide: «Non ho sottomano pani comuni, ho solo pani sacri: se i tuoi giovani si sono almeno astenuti dalle donne, potete mangiarne». 6 Rispose Davide al sacerdote: «Ma certo! Dalle donne ci siamo astenuti da tre giorni. Come sempre quando mi metto in viaggio, i giovani sono mondi, sebbene si tratti d'un viaggio profano; tanto più oggi essi sono mondi». 7 Il sacerdote gli diede il pane sacro, perché non c'era là altro pane che quello dell'offerta, ritirato dalla presenza del Signore, per essere sostituito con pane fresco nel giorno in cui si toglie».
I pani sacri o di proposizione erano un'offerta fatta a Dio e come tali non potevano più essere usati come cibo comune, ma erano riservati esclusivamente ai sacerdoti che li consumavano in condizione di assoluta purità.
Nel nostro testo Gesù non giustifica l'azione dei discepoli a fronte dell'antico racconto biblico, ma in virtù di una priorità nuova e radicale: «il Figlio dell'Uomo è signore anche del sabato».
Abbiamo già incontrato l'autoattribuzione del titolo "Figlio dell'Uomo" nella prima controversia galilaica, quando Gesù guarì il paralitico: "Il Figlio dell'uomo ha il potere /exousìa di rimettere i peccati».
In questo racconto Gesù rivendica la sua exousìa a riguardo del sabato riportandone il senso al complesso della Legge che è stata consegnata da Dio al popolo della Sua Alleanza, perché fosse un popolo libero.
E ricordiamo ancora che l'Alleanza viene stipulata prima della Legge (vedi Es 19).
E Gesù aggiunge anche il senso del comandamento sabbatico:
«Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato!».
Ma lo scontro con il legulei è appena iniziato: siamo solo al primo tempo.
Lettura 25 La quinta controversia galilaica: guarigione della mano inaridita Mc 3,1-6
Mc 3:1 «Entrò di nuovo nella sinagoga. C'era un uomo che aveva una mano inaridita, 2 e lo spiavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo. 3 Egli dice all'uomo che aveva la mano inaridita: «Alzati / egeirō nel mezzo!». 4 E dice loro: «È lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla?». 5 Ma essi tacevano. Ed egli guardandoli tutt'intorno con collera, contristato per l'indurimento la durezza dei loro cuori, dice a quell'uomo: «Stendi la mano!». La stese e la sua mano fu risanata.
6 E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire».
La predicazione di Gesù era iniziata con l'annuncio del Regno e fin qui abbiamo potuto rilevare l'instaurarsi del Regno attraverso insegnamenti nuovi, autorevoli, exousìa e soprattutto, concreti gesti di liberazione dal male: cacciate di demoni, guarigioni istantanee, senza strani riti o parole magiche del genere "abracadabra".
Le controversie galilaiche erano iniziate in una sinagoga, quella di Cafarnao e si chiudono in una sinagoga.
Sia nella prima che nell'ultima sono operate due guarigioni prodigiose: là un paralitico, qui un uomo dalla mano inaridita. Questo aggettivo vuole significare qualcosa di diverso da una paralisi; potrebbe essere una malattia dei nervi, della circolazione, comunque una malattia che impedisce a quest'uomo di usare la sua mano.
Ricordiamo che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio e una caratteristica comune ad entrambi è la capacità di usare le mani - passi l'antropomorfismo divino, ma la Bibbia ne è piena. Il nostro Dio potremmo definirlo Dio faber, così come l'uomo, unico tra tutti gli esseri che popolano il pianeta, è altrettanto faber. Una capacità che gli è consentita dalle sue mani, che possono impugnare, costruire, toccare, cullare, accarezzare...
Ricordiamo anche che nella simbologia biblica il numero dieci rimanda appunto al "fare" perché dieci sono le dita delle mani e, appunto, dieci sono i Comandamenti perché essi sono da "fare" cioè da mettere in pratica.
Ecco, l'uomo del nostro racconto non può svolgere pienamente le sue attività perché una mano non può "fare".
Dobbiamo notare che egli non chiede nulla Gesù, ma è il Maestro che interviene in suo favore. Per Lui questa immagine di Dio ha bisogno di essere riportata alla sua piena efficienza: l'uomo integro è gloria di Dio.
Ma è sabato... e i suoi oppositori «lo spiavano». Spiare non è un semplice "guardare", ma un guardare guidato da un intenzione tutt'altro che buona.
Quest'uomo a chiamato ad alzarsi (egeirō, il solito verbo che rimanda alla risurrezione, ad un uomo nuovo) e a mettersi al centro della sinagoga per cui tutti gli sguardi sono puntati su di lui... tranne quelli di coloro che "Lo spiavano".
La provocazione di Gesù è perentoria, una domanda che esige una risposta:
«È lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla?»
Nel brano parallelo di Matteo la stessa domanda va più sul concreto:
Mt 12,11 Ed egli disse loro: «Chi tra voi, avendo una pecora, se questa gli cade di sabato in una fossa, non l'afferra e la tira fuori? 12 Ora, quanto è più prezioso un uomo di una pecora! Perciò è permesso fare del bene anche di sabato».
In realtà non si tratta di dare o togliere una vita, ma se liberare un uomo dal male adesso o il giorno dopo.
Ecco, per Gesù la liberazione dal male è più importante del riposo sabbatico. È questo che per i farisei è scandaloso.
Ma Gesù aveva già affermato nella lettura precedente che: «il Figlio dell'Uomo è signore anche del sabato» e qui lo mette in pratica con un icastico «stendi la tua mano» E la sua mano fu subito risanata.
Capirai che lavoro!
L'esito era prevedibile:
6 «E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire».
Erodiani e farisei si vedevano come il fumo negli occhi, perché Erode non era ebreo, ma idumeo, messo sul trono da Roma, conduceva una vita dissoluta, quindi tutt'altro che rispettosa della Legge. Però egli aveva il potere di promulgare sentenze di morte.
Allora, in questo caso, pur di far fuori Gesù, i farisei sono disposti a fare accordi anche con gli erodiani.
E la domanda di Gesù: «È lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla?» trova qui la risposta chiara e netta: la decisione di togliere una vita... presa in giorno di sabato.
Lettura 26 Lettura d'insieme delle controversie galilaiche Mc 2,1 - 3,6
Dopo avere esaminato nel dettaglio le cinque dispute di Galilea, cerchiamo di collegarle tra di loro cogliendone continuità e cesure.
Lo facciamo esaminando le caratteristiche tipiche dei personaggi coinvolti.
I discepoli
Dei discepoli abbiamo la "carta d'identità": nome, paternità, professione, luogo di residenza. Essi sono:
I fratelli Simone e Andrea, figli di Giona (Mc 1,6; Mt 16,16), pescatori.
I fratelli Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo (Mc 1,19) anch'essi pescatori.
Tutti e quattro vivevano attorno al lago di Galilea, verosimilmente a Cafarnao.
Troviamo poi Levi o Matteo, figlio di Alfeo, esattore delle imposte (Mc 2,14), anche lui viveva presso il lago di Galilea.
Nella prima disputa, "la guarigione del paralitico", i discepoli sono sicuramente testimoni, ma non sono neanche nominati.
Nella seconda, "la chiamata di Levi / Matteo", partecipano al banchetto con Gesù, i pubblicani e gli altri peccatori; a loro sono comunicate le critiche degli oppositori, che evidentemente non avevano il coraggio di farle direttamente al Maestro.
Nella terza controversia, sono accusati di non praticare il digiuno prescritto come invece facevano farisei e discepoli di Giovanni Battista.
Nella quarta controversia hanno commesso l'infrazione di strappare le spighe in giorno di sabato.
Nella quinta, "l'uomo dalla mano inaridita" sono sicuramente presenti, ma non sono coinvolti.
In tutte le controversie i discepoli non pronunciano una parola.
Gli oppositori
A differenza dei discepoli degli oppositori conosciamo solo il gruppo di appartenenza, ma della loro identità personale non è detto nulla: non sappiamo chi sono né da dove vengono e nemmeno quanti siano. Quasi a dire che l'opposizione sicuramente c'è, ma l'oppositore sfugge alle sue responsabilità.
Nella prima disputa, "la guarigione del paralitico", si dice: «6 Ora, vi erano seduti là alcuni scribi e ragionavano / dialogizō in cuor loro: 7 «Perché costui dice così? Egli bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non l'unico Dio?».
Si dice che sono scribi, quindi esperti delle Scritture perciò della Legge, ma chi sono? da dove vengono? quanti sono? Almeno un nome. E invece nulla. Quasi dei pensieri che girano nell'aria senza una benché minima paternità.
Essi "ragionavano in cuor loro"; una contestazione molto discreta; neanche verbale.
Nella seconda disputa, "la chiamata di Levi", si tratta ancora di scribi appartenenti alla setta dei farisei, cioè esperti delle scritture e aderenti al movimento farisaico. Anche di questi nessun nome, nessuna indicazione di provenienza.
Le loro rimostranze sono più rimarcate delle precedenti perché si rivolgono ai discepoli:«Perché [Gesù] mangia con i pubblicani e peccatori»?
La terza disputa "a riguardo del digiuno" è innescata dai farisei che si rivolgono direttamente a Gesù: Mc 2,18 «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?».
Quindi una contestazione più pressante delle precedenti.
Anche la quarta controversia, "le spighe strappate di sabato" è condotta direttamente dai farisei, che però restano sempre sconosciuti, posta in tono molto perentorio fatta direttamente a Gesù: «I farisei gli dicevano: «Vedi! Perché fanno di sabato quel che non è lecito?» Mc 2,24.
Nella quinta controversia, "l'uomo dalla mano inaridita", non è presentato alcun colloquio; "ma lo spiavano", cioè lo guardavano in modo cattivo e non viene detto chi spiava: farisei? erodiani? scribi?
Qui è Gesù che li interpella Mc 3,4 «È lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla?». Una domanda che resta senza risposta. Un'opposizione che resta del tutto silente, nascosta, quasi non esistesse.
Ma poi "nelle segrete stanze" Mc 3,6 «E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire»
Il male riesce ad essere tanto più efficace quanto più è nascosto.
La struttura.
La struttura di questo brano è importante perché ci permette di capire qualcosa di più della figura di Gesù.
Ricordiamo che stiamo percorrendo la prima parte che abbiamo intitolato: "Chi è Gesù" e la prima sezione della prima parte che abbiamo intitolato: "Un insegnamento nuovo".
La struttura di queste dispute è di tipo chiasmatico che sintetizziamo con lo schema: titolo e affermazione di Gesù
a => comunione con i peccatori => «Il Figlio dell'Uomo ha il potere di rimettere i peccati» 2,10
a1 => comunione con i peccatori => «Non hanno bisogno del medico i sani ma i malati» 2,17
b => le nozze con la nuova umanità => «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché lo sposo è con loro non possono digiunare» 2,20
c => il sabato => «Perciò il Figlio dell'Uomo è Signore del sabato». 2,28
c1 => il sabato => «È lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla?» 3,4
Il centro delle controversie è la terza, cioè le Nozze promesse dagli antichi profeti.
Il prezzo da pagare per questo nuovo legame con gli uomini è togliere una vita: «E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire» 3,6.
Queste controversie terminano qui, ma riprenderanno a Gerusalemme (Mc 11,27-12,34), dove l'esito sarà la realizzazione della decisione presa in questa riunione.
Lettura 27 Formazione dei vangeli
La struttura delle controversie galilaiche ci può aiutare a comprendere un aspetto di come è nato il genere "vangelo".
Abbiamo già avuto modo dire, nella parte iniziale, che un vangelo non è la redazione cronachistica di ciò che Gesù ha fatto. Però questo non vuol dire che i fatti raccontati non siano storici.
In particolare le controversie che abbiamo appena esplorato, non sono avvenute tutte insieme così come ce le riporta Marco, piuttosto sono accadute in luoghi e contesti differenti e, certamente, non tutte insieme.
Il loro assiemaggio dipende invece dagli interrogativi che le comunità marciane o addirittura pre-marciane, si erano poste a riguardo di alcuni problemi concreti incontrati nella loro quotidianità.
Nel caso: come trattare i peccatori? Accoglierli o escluderli? Ammetterli alla Santa Cena? Come riammettere i peccatori pentiti nella comunità?
E che fare delle antiche tradizioni? La celebrazione del sabato, il riposo festivo, e via dicendo.
Notiamo che queste comunità hanno avuto il coraggio di spostare il giorno sacro dal sabato alla domenica: il giorno della Risurrezione, l'ottavo giorno.
La risposta a domande di questo tipo è stata ottenuta andando ad esplorare cosa aveva fatto Gesù in occasioni analoghe.
Non dobbiamo dimenticare che la memoria degli eventi riguardanti il Signore Risorto erano ancora molto viva nelle menti delle persone che ne erano state testimoni e che contribuirono a formalizzare le prime tradizioni orali e scritte.
Le risposte così ottenute vengono accorpate e scritte sia per finalità catechetiche sia per aiutare quelli che sarebbero venuti dopo quella prima generazione di testimoni.
In definitiva la struttura letteraria che possediamo è opera dei primi cristiani e in seconda battuta di Marco che ne è stato il redattore finale.
Quindi la storicità è sicura, la struttura dei testi è invece opera letteraria.
Con queste ultime osservazioni abbiamo terminato di leggere la prima sezione della prima parte del vangelo di Marco. Dalla prossima lettura inizieremo a riflettere sulla seconda sezione, sempre della prima parte.
Il criterio di suddivisione tra le due sezioni è la presenza di un sommario e una successione di argomenti che, dal punto di vista tematico, ricalcano la prima sezione.
Riportiamo le due strutture così come abbiamo fatto alla lettura 11.
prima sezione - Un insegnamento nuovo
1,14-15 => sommario
1,16 - 20 => chiamata dei primi discepoli
1,21 - 3,5 => predicazione / kērussō di Gesù in parole ed opere
3,6 => opposizione di farisei ed erodiani con rimando alla croce.
seconda sezione - Istruzione dei discepoli
3,7 - 12 => sommario
3,13 - 19 => elezione dei dodici apostoli
3,20 - 5,43 => predicazione / kerussō di Gesù in parole ed opere
6,1 - 6,6a => opposizione dei concittadini di Nazareth
Segnaliamo che in questa seconda sezione non troveremo più Gesù presente in qualche sinagoga se non alla fine, nella sinagoga di Nazareth dove troverà l'opposizione dei suoi concittadini.
Addirittura veniamo a sapere dal vangelo di Luca:
Lc 4,28 «All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno; 29 si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. 30 Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò».
Quindi anche in questa seconda sezione è rappresentato il successo di Gesù presso le folle, insieme alla presenza dell'ombra della croce.
Lettura 28 Sommario
Entriamo in pieno nella seconda sezione della prima parte che intitoliamo: "Istruzione dei discepoli", quindi la nostra attenzione dovrà essere orientata su due punti principali: l'insegnamento e i discepoli.
Questo non esclude un insegnamento rivolto anche alla gente, ma in questo potremo rilevare due stili differenti: quello generico verso alle folle e quello specifico diretto ai discepoli.
Mc 3,7 «E Gesù con i suoi discepoli si ritirò verso il mare; e una grande moltitudine dalla Galilea lo seguì e dalla Giudea 8 e da Gerusalemme e dalla Idumea e dal paese al di là del Giordano e dai dintorni di Tiro e di Sidone venne a lui una grande moltitudine, avendo essi sentito quanto faceva.
9 E disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una piccola barca a causa della folla affinché la calca non l'opprimesse.
10 Infatti ne curò / therapeuō molti, così che quanti avevano infermità accorrevano a lui per toccarlo.
11 E gli spiriti immondi quando lo scorgevano, cadevano davanti a lui e gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!».
12 Ed egli li minacciava molto affinché non lo facessero manifesto.
Sappiamo già che quando il testo parla di "mare" si tratta in realtà del mare di Galilea o di Tiberiade, che in effetti è un lago. Esso si trova a circa 200 metri sotto il livello del mare; immissario ed emissario è il fiume Giordano.
Il testo è una breve sintesi di quando verrà raccontato in tutta la sezione; e questo è il motivo per cui viene denominato: "sommario".
Le dimensioni della folla che vuole raggiungere Gesù non è semplicemente sostenuta da "grande moltitudine" perché Marco richiama anche i quattro punti cardinali.
Sud: Gerusalemme, la Giudea e ancora più a sud l'Idumea.
A est: il paese al di là del Giordano, che oggi chiamiamo Transgiordania.
A ovest: Tiro.
A nord: Sidone.
Al centro di tutto questo sta la Galilea con il suo mare abbastanza grande: 21 x 13 Km. Nell'insieme si tratta di regioni abitate in prevalenza da ebrei, ma anche da pagani: ellenici e per quanta riguarda Tiro e Sidone, fenici.
Se è così il testo vuole farci intendere che la fama di Gesù aveva fatto molta strada e la gente veniva da tutte le parti.
È tutta gente che si trova nel bisogno e fa di tutto per toccarlo ed ottenere perciò qualche beneficio, al punto che Gesù deve prendere le distanze. Non si tratta semplicemente di non essere travolto, ma piuttosto di non cadere in affanno e preservare la propria riservatezza e concentrazione.
Così appare, per la prima volta, un servizio chiesto ai discepoli che in questo modo sono differenziati dagli altri: la messa a disposizione di una barca per essere distaccato dalla riva e in caso di necessità attraversare il mare /lago.
Per piccola che sia è già una prima forma di chiesa.
Gli antichi Padri vedevano già in questa piccola barca una figura della chiesa.
La proclamazione dell'identità di Gesù da parte degli spiriti immondi è ostacolata da Gesù stesso, non perché non sia effettivamente Figlio di Dio, ma perché la sua verità appaia dai suoi gesti di liberazione dal male e dal suo modo di essere Messia.
E allora bisognerà ancora attendere la sua manifestazione integrale.
Lettura 29 L'istituzione dei dodici Mc 3,13-19
Mc 3,13 «E sale sul monte e chiama a sé quelli che lui voleva ed essi andarono da lui. 14 E ne fece Dodici, che denominò anche apostoli, perché fossero con lui e perché li mandasse a predicare / kerussō 15 e avere il potere di scacciare i demoni. 16 Costituì dunque i Dodici: e impose a Simone il nome di Pietro; 17 poi Giacomo di Zebedèo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè "figli del tuono"; 18 e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananèo 19 e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì /paradìdōmi / consegnò».
1- Il "monte" e il numero "dodici" rimandano agli eventi esodici del Sinai dove gli schiavi fuggiti dall'Egitto accolsero da Dio, con la mediazione di Mosè, l'Alleanza, la Legge, dei giudici e così strutturati divennero un popolo, articolato in dodici tribù.
Il monte, quindi, non ha il significato di un'altura dalla quale ammirare un bel panorama, ma piuttosto quello dell'avvicinamento o dell'ingresso in una zona abitata da Dio. Siamo in presenza di una delle tante manifestazioni del sacro.
Allora l'istituzione di questi dodici inviati o messaggeri, in greco "apostoloi" da cui il nostro apostoli, segna la nascita di un nuovo popolo: il popolo della Nuova Alleanza.
2- Ora, non solo Gesù aveva preso le distanze dalle folle, come abbiamo visto nella lettura precedente guidati dal tema della piccola barca, ma anche i dodici sono chiamati in forma separata, "perché fossero con lui"... che è ben diverso da uno "stare tra di loro". Lo stare tra di loro è subordinato allo "stare con lui". Lui è il perno che unifica il gruppo, non la bella e simpatica compagnia.
Si tratta di una presa di distanza che permane: in quanto inviati, messaggeri, apostoli sono chiamati ad un servizio per il mondo, ma devono sempre mantenere tale distanza dal mondo, quella che precisamente esprime Gesù nell'Ultima Cena: Gv 17,16 «Essi non sono del mondo come io non sono del mondo».
E questo non è richiesto solo agli apostoli, ma tutti i discepoli.
Se vuoi servire il mondo devi differenziarti dal mondo, pur rimanendo nel mondo.
3- È anche importante rilevare la composizione di questo gruppo di dodici.
I primi quattro: Pietro, Andrea, Giovanni e Giacomo erano stati chiamati a seguire il Maestro mentre passeggiava lungo il mare di Galilea, erano pescatori (Mc 1,16-ss).
Matteo o Levi era un esattore delle imposte per conto dei romani (Mc 2,13-ss), perciò un collaborazionista venduto agli invasori.
E adesso arriva anche Simone lo zelota. Gli zeloti avevano costituito un gruppo che, fatte le debite proporzioni, praticavano una guerra di resistenza armata, che voleva eliminare i romani e restaurare l'antico Regno Davidico. Essi non esitavano ad assassinare nemici, collaborazionisti e a compiere attentati imponenti, per cercare di fare sollevare il popolo. Come Matteo e Simone potessero evitare di scannarsi l'un l'altro, il vangelo non lo dice.
Della compagnia fa parte anche Giuda iscariota. L'apposizione potrebbe riferirsi alla sua personalità: menzognero, falso, traditore; oppure alla provenienza: il villaggio di Qeryot. Ciò che conta è la specificazione "quello che poi lo consegnò / paradìdōmi"; e questo è un verbo strategico perché può essere tradotto con "arrestare".
E così, ancora una volta si manifesta l'ombra della croce.
Nel complesso una compagnia di gente avventizia, raffazzonata che potrebbe trovare l'aggettivo appropriato nei dialetti lombardi: una compagnia "de mal-tra-insema".
Questo ci consente di ribadire ancora una volta, la forma anomala, rispetto alla tradizione, di come Gesù abbia reclutato i suoi inviati.
Possiamo tentare di spiegarlo attraverso il verbo insegnare, in greco didaskō: insegnare, istruire, ammaestrare.
Ci interessa "ammaestrare", come talvolta troviamo nelle nostre traduzioni, che di primo acchito ci stupisce, perché "ammaestrare" è l'azione che un domatore fa verso gli animali; agli esseri umani si insegna e gli allievi imparano.
Tuttavia se un animale non impara la colpa è del domatore, non dell'animale.
Allora l'uso di "ammaestrare" nei vangeli vuole significare che Gesù si prende la responsabilità del insegnamento e dell'apprendimento dei discepoli.
In definitiva, Gesù si assume il compito dell'ammaestramento del suo gruppo, indipendentemente dalle differenti preparazioni precedenti, dalle qualità individuali, e dalla stessa composizione del gruppo.
I dialetti meridionali ci consentono di usare il verbo imparare in una forma scorretta, ma adatta al nostro caso: è Gesù stesso che "li fa imparati".
4- Il compito che gli inviati devono adempiere è «li chiamò a sé perché li mandasse a predicare e avere il potere di scacciare i demoni».
Il potere di scacciare i demoni non è una capacità propria acquisita, ma un dovere da compiere.
Il predicare / kerussō dice una funzione, ma non ne specifica il contenuto.
La stessa cosa però vale anche per Gesù, del quale si dice che predicava di qua e di là, ma il contenuto dell'annuncio è indicato da Marco solo in
Mc 1,14 «Il tempo è compiuto / kairòs il Regno di Dio è vicino convertitevi / metanoeìte e credete al Vangelo / lieta notizia».
E questo doveva essere anche l'annuncio degli inviati.
Allora gli inviati non proponevano se stessi agli ascoltatori alla maniera di chi dice: "guarda come sono bravo".
Al contrario potevano annunciare il Regno di Dio, nonostante i propri limiti.
Esattamente come dovremmo fare anche noi.
Lettura 30 L'incomprensione dei suoi. Primo gruppo. Mc 3,20-21
Mc 3,20 «Entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo. 21 Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; poiché dicevano: «È fuori di sé».
Questa casa circondata da una grande folla in cui non si riesce neanche più a mangiare è diventata una sinagoga, una sorta di luogo di studio e preghiera, che separa quelli dentro da quelli fuori.
Vedremo nelle prossime letture un continuo movimento tra "dentro" e "fuori". Sembra che Marco abbia voluto giocare su questi due avverbi di luogo, ma in realtà essi sono molto importanti dal punto di vista di comprensione dell'annuncio / kerussō.
È facile censurare l'atteggiamento dei suoi perché noi siamo a priori schierati dalla parte di Gesù e diciamo che se quelli dicono che "è fuori di sé", sicuramente sbagliano.
Ma noi veniamo dopo gli eventi pasquali, sappiamo che Gesù crocifisso e risorto ha manifestato in quegli eventi la sua divinità, ma per quelli che venivano prima di quegli eventi...
Forse noi siamo un po' timorosi ad applicare integralmente il dogma di Calcedonia "Gesù vero uomo e vero Dio" ed enfatizziamo la seconda parte scivolando sulla prima. D'altra parte sin da bambini ci hanno insegnato a pregare Gesù che è Dio.
Però di tutti i contemporanei di Gesù, apostoli, discepoli, e oppositori, mai nessuno ha potuto vedere il "Figlio di Dio" ad occhio nudo. Vedevano solo un uomo come loro, che parlava aramaico, magari con l'accento della Galilea, che svolgeva tutte le funzioni umane comprese quelle fisiologiche più umili, proprio come tutti gli altri umani.
In quella sua umanità, nulla lasciava trasparire la divinità: era proprio "vero uomo" come definito a Calcedonia.
L'unica persona che, forse, poteva avanzare qualche osservazione era la Madre, Maria, ma durante tutta la vita pubblica del Figlio, non ha mai aperto bocca. Un silenzio molto più eloquente del chiasso di tanti altri personaggi.
Ora proviamo a metterci dalla loro parte di questi "suoi che vengono a prenderlo" e osservare dal loro punto di vista tutto quello che ha combinato il loro congiunto. Essi potevano dire grosso modo così:
«All'inizio era un bravo ragazzo, aiutava suo padre nella bottega, andavano in giro a fare riparazioni di falegnameria e carpenteria; avrebbero potuto allargare la loro attività e avere successo. Invece ad un certo punto gli viene una crisi mistica, sai quelle robe che capitano addosso come l'influenza e ci vuole un po' di tempo e molta pazienza per venirne fuori. Invece questo qui, un bel giorno senza tanti convenevoli molla tutto e se ne va dalle parti del Mar Morto (Qumaran) insieme ad altri che vivevano da eremiti, in una zona dove c'erano solo scorpioni e serpenti. Resta lì per un bel po' con quelli, che detto tra di noi erano un po' matti, e poi di punto in bianco li lascia con un palmo di naso e si mette a girovagare di qua e di là in cerca di qualcosa che non sa cosa sia.
Poi entra nel giro di Giovanni, un altro matto che girava tra il deserto e il Giordano a battezzare la gente. E il bello è che erano in tanti ad andargli dietro, ma poi prima o poi rinsavivano e tornavano a casa.
Lui invece no. Un bel giorno decide di mettersi in proprio e incomincia a girare su e giù tra la Giudea e la Galilea farneticando su un regno di Dio che nessuno sa cosa sia. Poi si mette a scacciare i demoni dalla gente, ma nessuno ha mai visto un demonio uscire da qualcuno. Sai, un tizio tutto rosso, con le corna, le zampe di capra... Oppure tutto nero, metti anche giallo, viola, quello che vuoi, ma insomma, qualcosa da vedere.
E la gente che gli corre dietro da tutte le parti perché lo vogliono toccare; dicono che fa i miracoli, ma finché è stato qui da noi, a Nazareth, di miracoli... neanche l'ombra (Mc 6,5).
Adesso chi ne fa le spese di tutto questo siamo noi. Quando si va per strada quelli che ti vedono vanno dall'altra parte. Se ti fermano è per chiederti cosa sta combinando questo ragazzo, che sembrava così per bene... e invece adesso... Così salta completamente la reputazione della famiglia. Ma noi abbiamo un onore e una tradizione da difendere. Già parecchi clienti vanno a farsi fare i lavori da altre parti.
Insomma, non c'è niente da fare, bisogna farlo ricoverare. Sia chiaro: per il suo bene»!
Ovviamente il vangelo non dice tutto questo, ma lo possiamo immaginare, anche perché Gesù è vissuto in questo mondo, tra persone che ogni giorno dovevano mettere sul tavolo pranzo e cena, problemi concreti indilazionabili.
Nella nostra drammatizzazione di fantasia ci siamo lasciati orientare dal film "I giardini dell'Eden" di D'Alatri con Kim Rossi Stuart, che ha cercato di riempire quel silenzio su Gesù esistente dai dodici anni, quando viene smarrito a Gerusalemme, all'inizio della sua vita pubblica.
Ma "i suoi" che erano venuti a prenderlo erano così duri testa da non capire chi fosse e cosa facesse Gesù?
Noi sappiamo chi erano alcuni di essi: Giacomo, Ioses, Giuda e di Simone? (Mc 6,3)
Sappiamo che Giacomo diventerà capo della chiesa di Gerusalemme (At 12,17; 15,13; 21,18; 1Cor 15,7) e sarà l'autore della lettera di Giacomo.
Questo ci suggerisce che la conversione è il risultato di un processo di ricerca e confronto, oltre che di elaborazione di tutte le difficoltà che le diverse persone, ciascuna con la storia, ha dovuto superare.
Però in questo testo Marco vuole sottolineare un aspetto molto importante, con questo primo gruppo, "i suoi", la Parola non ha avuto effetto, è andata a vuoto: il terreno non era adatto... per il momento!
Lettura 31 L'incomprensione degli scribi. Secondo gruppo. Mc 3,22-30
Mc 3,22 «E gli scribi / grammateis, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl» e: «Per mezzo del capo dei demoni scaccia i demòni». 23 E avendoli chiamati a sé, diceva loro in parabole: «Come può Satana scacciare Satana? 24 Se un regno è diviso contro se stesso, quel regno non può sussister; 25 e se una casa / famiglia è divisa contro se stessa, quella casa non può sussistere. 26 Alla stessa maniera, se Satana si è levato contro se stesso ed è diviso, non può sussistere, ma sta per finire.
27 Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e depredare le sue cose se prima non avrà legato l'uomo forte; allora ne saccheggerà la casa.
28 Amen / in verità vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e le bestemmie che diranno; 29 ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito santo, non avrà perdono in eterno, ma è colpevole di eterno peccato». 30Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito immondo».
Gli scribi / grammateis sono gli esperti delle Scritture, i più profondi conoscitori delle antiche profezie. Potremmo dire: i teologi, quelli che meglio di altri avrebbero potuto riconoscere i "segni" che Gesù stava disseminando a piene mani. Questo però avrebbe richiesto di riconoscere anche il suo nuovo insegnamento autorevole, la sua exousia, che, come abbiamo visto nelle letture della precedente sezione, era stata largamente apprezzata dalle folle.
Verso questi scribi Gesù mostra di avere pazienza: quel "chiamatili a sé" indica che Egli cerca di fare capire loro la "sua" verità. Si esprime con una domanda retorica su Satana (23a) e due miniparabole: il regno diviso in se stesso e la casa (o famiglia) pure divisa in se stessa.
La conclusione del v26, riprende il tema di Satana: il demonio che combatte se stesso è una proposizione priva di senso perché afferma nulla.
Segue poi la miniparabola dell'uomo forte. Essa non è di comprensione immediata perché rimanda ad una tradizione profetica che mette il campo "un forte", uomo o spirito che sia, a volte dalla parte di Dio a volte contro Dio.
Non stiamo ad analizzare questa tradizione, ci limitiamo a riportare come esempio un testo di Isaia che tratta della liberazione e del ritorno degli esiliati da Babilonia, un evento che sembrava impossibile.
Is 49,24 «Si può forse strappare la preda al forte? / Oppure può un prigioniero sfuggire al tiranno?
25 Eppure dice JHWH: / «Anche il prigioniero sarà strappato al forte, / la preda sfuggirà al tiranno.
Io avverserò i tuoi avversari; / io salverò i tuoi figli.
26 Farò mangiare le loro stesse carni ai tuoi oppressori, / si ubriacheranno del proprio sangue come di mosto.
Allora ogni uomo saprà / che io sono il Signore, tuo salvatore, / io il tuo redentore e il Forte di Giacobbe».
In questo caso sono due forti in competizione, chi tiene prigionieri i figli di Israele e il Forte che li libera: Dio.
Anche la nostra breve parabola entra in questa tematica per significare che le liberazioni degli ossessi dal demonio non è cosa tanto semplice perché richiede un grande impegno da parte di Gesù anche se pare che basti solo la sua parola autorevole.
v28 "Amen". L'originale greco ha voluto conservare il termine ebraico "amen" perché le possibili traduzioni, in greco ne avrebbero perduto la forza espressiva. A maggior ragione la stessa cosa vale per l'italiano.
Amen, contiene la radice di "roccia", un materiale che più duro non si può; tradurlo con "verità" equivale ad annacquarlo. Forse si potrebbe dire: "verità rocciosa", ma rischierebbe di non essere compresa.
Ricordiamo che la recita del Credo, nella Liturgia Eucaristica, viene chiusa con "Amen" non un semplice: "Così sia".
Se è così l'affermazione di Gesù, che segue questo "amen", ha un grande valore rivelativo. Gesù sta per dire qualcosa che nessuno mai potrà modificare: "C'è un peccato che non può essere perdonato: la bestemmia contro lo Spirito Santo".
La gravità della cosa diventa più evidente se riflettiamo che essa è preceduta dall'annuncio del perdono universale di tutti i peccati, che è il fondamento di tutta la fatica di Gesù: da Betlemme a Pasqua.
Come mai questo peccato è così grave?
Dobbiamo tenere presente che ogni opera di Dio e pertanto anche di Gesù è sempre mediata dallo Spirito Santo, perciò quando Gesù scaccia i demoni dagli ossessi compie un'azione nello Spirito Santo, anche perché ogni azione di Gesù è sempre Trinitaria; Gesù non opera mai in proprio.
Quindi chi si ostina a non riconoscere i segni dello Spirito e addirittura a confonderlo con Satana, rende se stesso incapace di chiedere perdono... e a Dio di perdonarlo.
Dio nutre sempre un grande rispetto della libertà umana... che però non è priva di responsabilità.
Per saperne di più vedi in Glosse: nota esegetica 9 e più in dettaglio 8.
Lettura 32 La madre e i fratelli. Terzo gruppo. Mc 3,31- 35
Mc 3,31 «E viene sua madre e i suoi fratelli con lei e stando fuori, mandarono a lui per chiamarlo. 32 E una folla era seduta intorno a lui e gli dicono: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano». 33Ed egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 34 E guardando intorno coloro che gli stavano intorno seduti, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 35 Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre».
Diversi commenti di questo brano si preoccupano di salvaguardare apologeticamente i rapporti tra Gesù e la sua famiglia di origine, in particolare la madre, ma dovremmo cercare di capire quale fosse la situazione nel momento in cui Marco scrive questi testi, quando diventare cristiani comportava sempre un rischio di rimostranze, esclusioni ed anche persecuzioni. La decisione per la fede richiedeva grande coraggio e un impegno radicale perché ne andava della vita: il cristianesimo era questione di vita o di morte.
Come lo è oggi per molti nostri fratelli che vivono in paesi islamici. Ma veniamo al testo.
"Gesù al centro" non indica tanto una disposizione spaziale, ma un rapporto di scuola tra maestro e ascoltatori, anche perché secondo l'uso del tempo i discepoli stavano seduti ai piedi del maestro.
Nel nostro caso il rapporto appare profondo, perché se intorno c'è una grande folla vuol dire che gli insegnamenti di Gesù trovavano una grande consenso, un legame che va oltre a quello di maestro - scolaro, potremmo parlare, in senso lato, di un legame affettivo, analogo a quello che si instaura tra i membri di una famiglia: una nuova famiglia, appunto.
Un rapporto già incontrato in Mc 3,14, Lettura 29: «E ne fece Dodici, che denominò anche apostoli, perché stessero con lui».
Lo "stare con Lui" impegna in una reimpostazione della propria vita, che il brano definisce con: «compiere la volontà di Dio»; attività che si può compiere solo come conseguenza dell'ascolto della Parola.
Il latino ci aiuterebbe molto in questo passaggio perché l'ascolto: audire, produce l'obbedienza: ob-audire, cioè "udire per..." Ma oggi "obbedienza" non è di moda...
Se è così non ci dovrebbe sorprendere che gli ebrei iniziassero le loro preghiere e lo fanno ancora oggi, con lo "Shemah Israel": "ascolta Israele...". Forse perché la caratteristica fondamentale dell'uomo di fede è di diventare "uditori della Parola".
Riflettiamo allora sul fatto che essere "madre, fratelli e sorelle" non assicura un rapporto di discepolato come Gesù intende; non per altro il testo dice che essi non fanno parte di quelli "seduti intorno", ma "restano fuori".
Ora, se riprendiamo le ultime letture possiamo rilevare un filo rosso.
1- "I suoi" (Lettura 30) che lo conoscevano da trent'anni, non avevano capito quello che Gesù diceva, anzi, dicevano: " è fuori di sé".
2- Gli scribi (Lettura 31) si erano data una risposta teologica: "scaccia i demoni perché è posseduto dal principe dei demoni".
3- La "madre, i fratelli e le sorelle", non fanno neanche parte della cerchia dei discepoli e infatti "restano fuori".
Allora Marco ha posto le premesse per affrontare un grande problema che tratta nel prosieguo: il rapporto tra proclamazione / kerussō della Parola e uditori della Parola.
Lettura 33 - Il discorso in parabole. Prima parte Mc 4,1- 9; 21-23; 26-32.
Mc 4:1 «Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. 2 E insegnava loro molte cose in parabole e nel suo insegnamento diceva loro:
3 «Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare. 4 Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono. 5 Un'altra cadde su terreno pietroso dove non c'era molta terra, e spuntò subito perché non c'era un terreno profondo; 6 e quando si levò il sole, fu riarsa e, non avendo radice, si seccò. 7 Un'altra parte cadde tra le spine; le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. 8 E altri caddero sulla terra buona, e davano frutto salendo e crescendo, e resero il trenta, ora il sessanta e ora il cento per uno». 9 E diceva: «Chi ha orecchi per intendere intenda!».
In prima battuta il racconto di questa semina resta oscuro, però ci sono dei numeri che chiedono di essere presi in considerazione altrimenti non si comprende il paradosso che qui viene esposto. E si tratta della resa di quella semina.
Anche se non viene esplicitamente detto si capisce dal contesto che si tratta di frumento o di orzo.
Non è il caso di fare un confronto specifico tra le attuali tecniche di coltivazione e quelle del tempo di Gesù; basti ricordare che i nostri aratri scendono fino a cinquanta centimetri senza difficoltà, mentre allora l'aratro era poco più di un chiodo. Gli esegeti poi discutono se si usasse prima seminare e poi arare o viceversa. La semina comunque avveniva a spaglio, mentre le nostre seminatrici meccaniche seminano in linee predeterminate, perfettamente parallele, depositando tutti i semi perfettamente alla profondità prestabilita.
Lasciamo perdere: irrigazione, diserbo, antiparassitari, concimazioni, ecc.
Ad ogni modo le nostre rese vanno dal 10 - 15 per uno per il grano duro e dal 25 - 35 per uno per il grano tenero.
Quali fossero le reali rese di quei tempi non è dato di conoscere, ma è evidente che la semina doveva essere praticata con grande accuratezza perché la semente era comunque grano sottratto all'alimentazione... e le carestie erano sempre dietro l'angolo.
Ora, quando gli ascoltatori di questo discorso, in gran parte contadini, sentono parlare di questo seminatore che sparge il seme senza nemmeno curarsi di dove vada a finire avranno pensato tra loro: "Ma questo non è capace neanche di tenere un geranio sulla finestra"!
Ma poi, quando sentono di quelle rese, restano a bocca spalancata e orecchie tese perché rese del 30 per uno non se le sono mai sognate e per giunta arriva il 60 per uno e poi il 100... averne di quel seme!
Tuttavia il problema del nostro racconto non riguarda l'agricoltura perché esso è una parabola, dal greco parabolè: mettere accanto, mettere su un altro piano. Allora si tratta di individuare il piano a cui Gesù si riferisce perché solo lì si potrà cogliere il senso del suo racconto.
Già ci rendiamo conto che se vogliamo comprendere qualcosa dobbiamo guardare al contesto in cui il racconto è posto e chi è il narratore. Si tratta di quel movimento che sempre ci deve essere tra gli esseri umani che quando vogliono comprendere il senso di ciò che uno dice devono anticipargli un consenso. Se tra due interlocutori non c'è questa "cordialità", la comunicazione muore. Se "misuri le parole" al tuo corrispondente non capirai mai quello che ti vuole dire. Se appena uno apre la bocca incominci a criticarlo la comunicazione diventa impossibile. Che è l'esatta fotografia dei nostri talk show televisivi!
Allora dobbiamo guardare Gesù e ripercorrere quello che ha detto e fatto.
Egli ha incominciato a girare per la Galilea cacciando demoni da molti ossessi la cui vita era diventata impossibile, guarendo tanti malati e annunciando/kērussō: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo» Mc 1,15.
A questo punto, se anticipiamo, cordialmente, il nostro consenso dobbiamo muoverci in direzione del "Regno di Dio". La nostra parabola ha il suo piano, il suo centro sul tema del Regno di Dio.
Allora quel seme e quel grano vogliono significare l'annuncio del Regno di Dio.
Nascono immediatamente due aspetti: un paradosso e un'interdizione.
1- Il paradosso è rappresentato dalla prodigiosa capacità di crescita di quel seme che cerca di attecchire anche nelle condizioni più sfavorevoli e che, quando poi, trova il terreno adatto produce addirittura rese impensabili: cento per uno! E infatti il Marco prosegue con una miniparabola:
4,26 «Diceva: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra; 27 dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa. 28 Poiché la terra produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. 29 Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura».
C'è un forza intrinseca in quel seme che ci fa dire: tutte le cure dei "servi" sono superflue.
4,30 «Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? 31 Esso è come un granellino di senapa che, quando viene seminato per terra, è il più piccolo di tutti semi che sono sulla terra; 32 ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra».
Con esiti impensati.! Perfino quello di diventare tanto grande da offrire riparo agli uccelli del cielo.
2- L'interdizione riguarda, anzitutto il seminatore che non si preoccupa minimamente dello spreco durante la semina. E di riflesso coinvolge i discepoli e i futuri servi del Regno, che non dovranno mai lesinare nel diffondere la Parola escludendo i terreni poco propensi ad accoglierla, come, ad esempio, uscendo dalla metafora, certe preoccupazioni efficientistiche che serpeggiano nei nostri Consigli Pastorali.
Anzi quella parola ha da essere sbandierata ai quattro venti, come suggerisce il prosieguo di Marco:
Mc 4,21 «Diceva loro: «Si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? O piuttosto per metterla sul lucerniere? 22 Non c'è nulla infatti di nascosto che non debba essere manifestato e nulla di segreto che non debba essere messo in luce. 23 Se uno ha orecchi per intendere, intenda!».
Un vecchio linguaggio, ormai desueto, chiamava il mettere la lampada sotto il letto: "rispetto umano":
3- Le qualità del terreno
Certo c'è il problema dei terreni di varie qualità. Anche Gesù li ha incontrati e Marco li ha già menzionati.
Ci sono i suoi venuti a prenderlo «...poiché dicevano: «È fuori di sé». 3,21
Ci sono gli scribi che dicono: «Costui è posseduto da Beelzebul...». 3,22
C'è la madre i fratelli che «stanno fuori e lo cercano». 3,31
E poi c'è tutta la folla che assedia la casa tanto che non possono neanche mangiare. 3,20
E ci sono quelli dentro che vogliono altre spiegazioni. 4,10
E qui abbiamo ancora Mc 4,1 «...attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva».
Di tutti questi terreni alcuni erano già pronti, altri lo sarebbero diventati di lì a poco, altri ancora avrebbero avuto bisogno di segni più grandi: gli eventi pasquali.
Ma il Regno di Dio sa aspettare!
Lettura 34 - Il discorso in parabole
Seconda parte Mc 4,10- 13
Mc 4, 10 «Quando poi fu solo, quelli che erano intorno a lui con i Dodici lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: 11 «A voi è stato dato il mistero del regno di Dio; a quelli di fuori tutto avviene in parabole, 12 affinché: guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non intendano, perché non si con-vertano e venga loro perdonato (Is 6,9)».
13 E dice loro: «Non sapete questa parabola? E come potrete conoscere tutte le parabole»?
Questo brano è indubbiamente problematico. Che Gesù faccia differenza tra le persone, "quelli fuori da quelli dentro" è distinzione molto dura per i nostri orecchi abituati ad egalitarismo acritico.
In parte abbiamo già abbozzato una soluzione nella lettura precedente: se non entri in rapporto con Gesù non puoi comprendere la sua parola, perché lui è la Parola e lui è il Regno.
Certo che le parabole si accompagnano ad un effetto di illuminazione ed allo stesso tempo, ad un effetto di oscuramento.
Ma allora, perché usare le parabole e non esprimersi in modo diretto?
Il fatto è che certe realtà astratte: i sentimenti, le emozioni, le realtà spirituali, possono essere comunicate e intuite solo mediante un linguaggio obliquo, preso dal mondo concreto dell'esperienza quotidiana. Quando, ad esempio, diciamo che una persona è dolce o ruvida o spigolosa capiamo subito che non stiamo parlando della sua epidermide, ma del suo carattere; e per farlo dobbiamo usare i guadagni frutto della nostra esperienza. Devo avere sperimentato la differenza esistente tra lo zucchero e il limone, tra la carta vetrata e un panno di velluto, tra la superficie del tavolo le spigolo contro cui ho battuto il gomito.
Così anche Gesù per parlare del Regno, che è una realtà spirituale, non ha a disposizione che questo linguaggio: deve riferirsi a delle immagini, a dei racconti, a dei fatti appartenenti alla vita di tutti i giorni.
E comunque il senso preciso del suo dire può essere raggiunto solo mediante la di lui frequentazione.
Il testo usa il verbo convertire che, diventato termine tecnico, ha perso il suo significato corrente; con-verto significa: girarsi verso, voltarsi verso. Certo, verso Gesù.
E questo è il movimento che produce la fede e di conseguenza il perdono.
Tutto questo vale se ci limitiamo a considerare esclusivamente la citazione del versetto di Isaia, ma molto probabilmente, la citazione intendeva richiamare alla mente il contesto da cui lo stesso versetto è stato estrapolato e così stabilire dei paralleli.
Is 6,1 Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi JHWH seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto riempivano il tempio. 2 Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali; con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. 3 Proclamavano l'uno all'altro:
«Santo, santo, santo è JHWH Zevahot. / Tutta la terra è piena della sua gloria».
4 Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. 5 E dissi: / «Ohimè! Io sono perduto, / perché un uomo dalle labbra impure io sono / e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito; / eppure i miei occhi hanno visto / il re, JHWH Zevahot».
6 Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. 7 Egli mi toccò la bocca e mi disse: / «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità / e il tuo peccato è espiato».
8 Poi io udii la voce di JHWH che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?».
E io risposi: «Eccomi, manda me!». 9 Egli disse: «Va' e riferisci a questo popolo:
Ascoltate pure, ma senza comprendere, / osservate pure, ma senza conoscere.
10 Rendi insensibile il cuore di "questo popolo", / fallo duro d'orecchio e acceca i suoi occhi
e non veda con gli occhi / né oda con gli orecchi / né comprenda con il cuore
né si converta in modo da esser guarito».
11 Io dissi: «Fino a quando, Signore?». Egli rispose: / «Finché non siano devastate / le città, senza abitanti, le case senza uomini / e la campagna resti deserta e desolata». / 12 Il Signore scaccerà la gente / e grande sarà l'abbandono nel paese. / 13 Ne rimarrà una decima parte, / ma di nuovo sarà preda della distruzione / come una quercia e come un terebinto, / di cui alla caduta resta il ceppo.
Progenie santa sarà il suo ceppo.
La situazione storica. Dal punto di vista storico, pur con molte incertezze documentali, si può dire che il re di Israele e il re di Siria, pretendevano che il piccolo regno di Giuda si alleasse con loro per fare fronte alla superpotenza dell'epoca: l'Assiria. Al rifiuto del re di Giuda, Acaz, essi iniziarono una guerra chiamata Siro - Efraimita, che terminò grazie ad un patto di sottomissione di Giuda all'Assiria; una decisione, contrastata da Isaia, che ebbe infauste conseguenze per più di un secolo. In forma estesa vedi 2 Re 16-ss.
La profezia di Isaia. La prima parte narra la vocazione di Isaia che avviene mentre si trova nel tempio; uno scenario grandioso per sottolineare l'importanza della chiamata e il suo scopo.
Il contenuto della profezia è una minaccia che riguarda Giuda e che di lì a poco storicamente si realizzerà.
Il senso della minaccia divina appare subito dal fatto che Dio non parla del "mio popolo", ma di "questo popolo", uno stilema dispregiativo che indica l'approssimarsi del giudizio divino. Infatti il messaggio di Isaia è destinato a non essere compreso perché gli orecchi sono resi sordi e gli occhi accecati. Esso sarà compreso solo "post eventum", cioè dopo che il castigo si sarà manifestato in tutta la sua drammaticità; e compreso solo da un "piccolo resto" di quel popolo. È la teologia del "Resto d'Israele", rappresentato anche dal ceppo la cui radice rimane sempre viva.
Tornando al brano evangelico, quella citazione così sintetica di Isaia, porta a pensare che il testo voglia alludere all'insieme delle vicende storiche che erano seguite a quella profezia.
La distinzione tra quelli fuori che non comprendono e quelli dentro cui sono spiegati i misteri del Regno, porta inevitabilmente a ritenere che anche il messaggio di Gesù, di per sé destinato a tutti, di fatto sia compreso e portato avanti solo da un piccolo resto.
Se è così, questo ci dice che pervenire alla fede è una questione seria, molto seria.
Lettura 35
Il discorso in parabole - Terza parte
Mc 4,13- 25
Mc 4, 13 E dice loro: «Non sapete questa parabola? E come potrete conoscere tutte le parabole»?
14 Il seminatore semina la parola. 15 Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola; ma quando l'ascoltano, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. 16 Similmente quelli seminati su terreni pietrosi sono quelli che quando ascoltano la parola l'accolgono subito con gioia, 17 ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e poi venendo una tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito si scandalizzano.
18 E altri sono quelli seminati tra le spine: sono coloro che hanno ascoltato la parola, 19 e le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e i desideri per le altre cose entrano e soffocano la parola che rimane senza frutto.
20 Quelli poi che ricevono il seme su un terreno buono, sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto nella misura chi del trenta, chi del sessanta, chi del cento per uno».
24 E diceva loro: «State attenti a quello che ascoltate. Con la misura con cui misurate sarà misurato a voi e sarà dato di più a voi. 25 Perché a chi ha, gli sarà dato e chi non ha, anche quello che ha sarà tolto».
Gli studiosi ritengono che la presente spiegazione allegorica non risalga direttamente a Gesù, ma sia frutto della elaborazione della chiesa di Marco che cercava di attualizzare l'insegnamento del Maestro alla situazione attuale.
Anche la diversità dei tempi verbali ci spinge verso questa soluzione; infatti l'esposizione della parabola iniziava con un verbo al passato:
Mc 4,2 «E insegnava loro molte cose in parabole e nel suo insegnamento diceva loro...»
mentre il nostro testo usa l'indicativo presente. Questo vuole significare che Gesù parla nell'oggi del credente anche a duemila anni di distanza. È sempre lui che spiega la Parola perché è lui la Parola / Verbo / Logos. In particolare è lui l'esegeta autentico, l'esegeta di riferimento. Ogni lettura, ogni interpretazione deve essere cristologicamente compatibile (Vedi in Glosse: Nota esegetica n.5).
Primo terreno / gruppo
In questo senso il primo tipo di terreno, ovvero il primo gruppo di uditori della parola, sono subito oggetto dell'attenzione di Satana, il mentitore per eccellenza, il divisore che sin dall'inizio ha distorto le parole di Dio cercando di convincere gli uditori alla sua interpretazione. È quanto succede nel Giardino di Eden con gli antichi progenitori.
Gen 3:1 Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?». 2 Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, 3 ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». 4 Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! 5 Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male».
Come la cosa sia finita lo sappiamo molto bene, ma qui ci interessa sottolineare come il serpente / Satana è abile a manipolare le parole di Dio per attuare il suo progetto malvagio.
Egli tenterà di attuare il suo progetto anche con Gesù.
Mt 4:1 «Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. 2 E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. 3 Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, di' che questi sassi diventino pane». 4 Ma egli rispose: «Sta scritto: / Non di solo pane vivrà l'uomo,/ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio».
5 Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio 6 e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: / Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani,/ perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede».
7 Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: / Non tentare il Signore Dio tuo».
8 Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: 9 «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai». 10 Ma Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto: / Adora il Signore Dio tuo/ e a lui solo rendi culto».
11 Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano».
Non commentiamo questo testo, ma solo vorremo sottolineare come Satana parla con Gesù a suon di citazioni bibliche; segno che conosce molto bene le scritture, ma Gesù è in grado di tenergli testa, anche perché in definitiva è lui la Parola.
Tutto questo ci suggerisce che bisogna essere molto attenti a rincorrere novità esegetiche che non siano cristologicamente e ecclesiologicamente fondate (soprattutto in internet).
Secondo terreno / gruppo
In questo caso il discepolo è chiamato a non essere superficiale, un tema che nel nostro tempo di persone "perennemente connesse" è più che mai cruciale. Si può rimanere entusiasti di un incontro, ma se la Parola non entra a far parte del nostro quotidiano, della nostra esperienza, rischia di perdersi nel fiume di parole che continuamente ci bombardano.
L'accenno alla persecuzione è chiara indicazione delle difficoltà che la chiesa di Marco aveva incontrato.
Terzo terreno / gruppo
Il terzo gruppo è composto da coloro che apprezzano la Parola, ma nello stesso tempo vogliono restare attaccati all'andazzo precedente, ovvero salvare capra e cavoli. Potremmo anche parlare degli idoli di oggi: la carriera, i soldi, la televisione, lo smartphone, cioè tutte le nostre care ed amate "dipendenze".
La terapia non può essere altro che il silenzio.
In definitiva questa spiegazione allegorica della parabola sposta l'attenzione dalla prodigiosa forza e vitalità del seme, alla responsabilità del discepolo nel farlo fruttare.
In questo caso il Regno di Dio appare condizionato dai limiti dell'uomo, mentre nell'altra lettura il medesimo Regno si sviluppava e cresceva per una sua propria capacità.
E nasce nel fedele il problema di cercare di capire di quale tipo di terreno fa parte. Con due rischi pericolosi.
La tentazione di "pretendere" l'adeguata ricompensa per i frutti che la Parola ha prodotto in lui e cioè, un atteggiamento mercenario verso Gesù.
A livello più generale, la convinzione di essere noi a fare il Regno di Dio; una tentazione che spesso si insinuata in diversi gruppi ecclesiali.
Ma il buon discepolo non deve mai dimenticare che alla fine egli è un "servo inutile" Lc 17,10.
Lettura 36
Dalla predicazione alle opere.
La prima traversata del mare Mc 4,35- 41
Nelle letture precedenti abbiamo visto Gesù proclamare la Parola del Regno attraverso diverse parabole, ora Marco vuole presentare Gesù all'opera, per cui abbiamo una serie di prodigi e guarigioni che, lo ribadiamo, sono sempre segni di liberazione dal male.
Mc 4, 35 «In quel medesimo giorno, venuta la sera, dice loro: «Passiamo all'altra riva». 36 E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. 37 Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. 38 Egli era a poppa addormentato sul cuscino, e dormiva. E lo svegliano e gli dicono: «Maestro, non t'importa che siamo perduti?». 39 Destatosi, minacciò il vento e disse al mare: «Taci! Calmati!». E il vento si placò e vi fu grande bonaccia. 40 Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?». 41 E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?».
Gli esperti ci dicono che il Mare di Galilea, a nord del quale ci sono montagne che arrivano fino a 3000 metri, a est il deserto e a ovest il Mediterraneo è soggetto a tempeste di vento improvvise. Quindi il racconto è meteorologicamente attendibile.
Ma vi sono alcune tensioni. Ovvia la domanda relativa alle "altre barche" che troviamo all'inizio, delle quali poi non si sa più nulla. Così come dormire tranquillamente durante una tempesta furiosa. Domande valide che però non rientrano nell'interesse dell'evangelista, il quale non intende semplicemente narrare una bella escursione in barca.
A Marco interessa porre in evidenza il contrasto con cui è terminato il brano precedente con questo evento che avviene subito dopo.
Ricordiamo che il discorso parabolico era terminato con una sorta di conclusione:
Mc 4, 33 «E con molte parabole simili diceva loro la Parola, secondo che potevano intendere. 34 Ora, senza parabole non diceva loro nulla, ma in disparte, ai propri discepoli spiegava ogni cosa».
Se è così i discepoli erano in grado di comprendere "ogni cosa" perché a loro veniva spiegato tutto e questo nuovo episodio costituisce una sorta di verifica.
Ora, il nostro brano possiede una grande forza evocativa di antichi fatti riportati dalle Scritture.
1- Il racconto della creazione inizia con questi due versetti:
Gen 1:1 «In principio Dio creò il cielo e la terra. 2 La terra era caos e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito / ruah / vento di Dio aleggiava sulle acque».
Il caos primordiale è caratterizzato da deserto, tenebre e un abisso, ma ci sono anche acque sopra le quali sta lo spirito di Dio. Però l'ebraico ha un solo termine per dire: spirito, vento, respiro. Quindi abbiamo un orribile quadro dominato dal vento. Dobbiamo anche tenere presente che per gli antichi ebrei le acque, il mare erano simbolo del male; essi, ordinariamente nomadi, erano molto abili a muoversi nel deserto, ma non sono mai stati marinai e sono sempre stati diffidenti nei confronti delle attività marine; ricordiamo altresì che la costa mediterranea era abitata dei fenici, quelli sì, abili navigatori.
Abbiamo approfondito questo rapporto tra vento e acque, nella lettura 4 del libro di Giona e ad esso rimandiamo.
2- La traversata del Mar Rosso
Siamo rimandati anche all'episodio dell'attraversamento del Mar Rosso, quando gli schiavi fuggiti dall'Egitto e inseguiti dall'esercito di Faraone si trovarono bloccati dal mare. Dio allora manda un forte vento che divide le acque e assicura un passaggio asciutto sul fondo marino. Il tutto è dettagliatamente narrato in Es 14. Anche in questo caso giocano un ruolo fondamentale l'acqua del mare e il vento. Ne abbiamo parlato nelle letture 30 e seguenti del libro di Esodo.
3- Il sonno di Gesù.
Nella Bibbia troviamo molti episodi in cui ci sono uno o più personaggi che dormono, tema che abbiamo trattato nella Lettura 4 del libro di Giona.
Ora, il sonno di Giona era un tentativo di fuggire dalla realtà che per lui era insopportabile: disubbidire a JHWH che egli amava rifiutandosi di andare a predicare la conversione agli abitanti di Ninive, la grande città nemica di Israele.
È un sonno analogo a quello di Elia (lettura 10 del libretto di Elia), che sentendosi abbandonato da Dio si inoltra nel deserto per una giornata senz'acqua, sicuro di morire per disidratazione. Ad un certo punto si addormenta sotto un arbusto attendendo che arrivi la fine. Sarebbe stato un sonno che precede la morte se non ci fosse stato un intervento di Dio.
C'è anche il sonno di Adamo quando viene creata Eva (Gn 2,21), c'è il sonno di Abramo mentre viene stipulata l'Alleanza (Gn 15,12) e da ultimo quello dei discepoli nel Getzemani che esamineremo a suo tempo.
Al contrario del sonno di Giona quello di Gesù non è conseguenza di una fuga, perché egli sta semplicemente andando verso l'altra riva del mare di Galilea, dopo il più che impegnativo discorso parabolico che lo aveva costretto a destreggiarsi tra malati che cercavano guarigioni, oppositori pronti a misurargli ogni parola; diviso tra quelli dentro e quelli fuori... e non è chiaro quali fossero quelli più ricettivi.
Probabilmente è un sonno che denota una profonda stanchezza e tuttavia diventa occasione per istruire i discepoli.
I quali, pur abili pescatori che conoscevano ogni metro del loro mare, sorpresi da quel vento improvviso, non capiscono più niente e sono presi da uno spavento terribile. Non perdiamo di vista che erano al buio.
Certo, Gesù è con loro, ma il suo sonno è una forma di assenza. Il sono in qualche modo era considerato una specie di anticamera della morte.
Così Marco ci porta in una doppia situazione: quella attuale sul mare di Galilea, e quella che avverrà a Gerusalemme di lì a qualche tempo: Gesù non parla, non agisce, non reagisce a ciò che accadde intorno.
E tuttavia è presente... nella forma dell'assenza. Esattamente come accade per la comunità di Marco. E questa è una terza situazione.
La paura dei discepoli viene rimarcata come mancanza di fede, cioè non sono stati capaci di affidarsi a...
Eppure a loro erano state spiegate per filo e per segno tutte le parabole, i misteri del Regno, ma al momento della prova vanno in crisi.
Ricordiamo che stiamo esplorando la prima parte del Vangelo di Marco che abbiamo intitolato: "Chi è Gesù" oppure: "La ricerca dell'identità di Gesù" (lettura 6) e questa sezione è intitolata: "Istruzione dei discepoli". Quindi questi primi discepoli erano ancora a scuola.
Però, questi discepoli chissà quante volte avevano pregato il salmo 107 e alla loro esperienza di pescatori doveva essere di buon auspicio il passaggio che recita:
Sal 107, 23 Coloro che solcavano il mare sulle navi / e commerciavano sulle grandi acque,
24 videro le opere di JHWH, / i suoi prodigi nel mare profondo.
25 Egli parlò e fece levare / un vento burrascoso che sollevò i suoi flutti.
26 Salivano fino al cielo, / scendevano negli abissi; / la loro anima languiva nell'affanno.
27 Ondeggiavano e barcollavano come ubriachi, / tutta la loro perizia era svanita.
28 Nell'angoscia gridarono a JHWH / ed egli li liberò dalle loro angustie.
29 Ridusse la tempesta alla calma, / tacquero i flutti del mare.
30 Si rallegrarono nel vedere la bonaccia / ed egli li condusse al porto sospirato.
Possiamo dire che allo sgomento suscitato dalla tempesta, ai discepoli, si aggiunge quello relativo all'identità di Gesù, perché, appunto, solo Dio può causare tempeste o bonacce.
Ma noi dovremmo astenerci dal giudicare questi ex pescatori perché ancora non avevano capito chi era il loro Maestro e, magari, chiederci cosa avremmo fatto noi al loro posto.
Soprattutto perché oggi la risposta all'interrogativo finale: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?», riguarda più noi che loro.
Lettura 37
Dalla predicazione alle opere. L'indemoniato di Gerasa. Mc 5,1- 20
La lettura precedente si è chiusa lasciandoci un interrogativo: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?». Il presente brano troviamo la risposta; anche questo caso data dai demoni: «Gesù Figlio del Dio Altissimo».
C'era stata anche la grande paura dei discepoli che nella tempesta temevano di affogare nel mare; qui ci saranno i maiali invasati dai demoni che precipiteranno nel mare e affogheranno.
Mc 5:1 «Intanto giunsero all'altra riva del mare, nella regione dei Gerasèni. 2 Come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. 3 Egli aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con catene, 4 perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva sempre spezzato le catene e infranto i ceppi, e nessuno più riusciva a domarlo. 5 Continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. 6 Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi, 7 e urlando a gran voce disse: «Che hai tu in comune con me, Gesù, Figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!». 8 Gli diceva infatti: «Esci, spirito immondo, da quest'uomo!». 9 E gli domandò: «Come ti chiami?». «Mi chiamo Legione, gli rispose, perché siamo in molti». 10 E prese a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione.
11 Ora c'era là, sul monte, un numeroso branco di porci al pascolo. 12 E gli spiriti lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi». 13 Glielo permise. E gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci e il branco si precipitò dal dirupo nel mare; erano circa duemila e affogarono uno dopo l'altro nel mare. 14 I mandriani allora fuggirono, portarono la notizia in città e nella campagna e la gente si mosse a vedere che cosa fosse accaduto.
15 Giunti che furono da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla Legione, e furono presi da timore. 16 Quelli che avevano visto tutto, spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. 17 Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio.
18 Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di permettergli di stare con lui. 19 Non glielo permise, ma gli disse: «Va' nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato». 20 Egli se ne andò e si mise a proclamare / kērussō per la Decàpoli ciò che Gesù gli aveva fatto, e tutti ne erano meravigliati».
Gli studiosi ci dicono che ci sono un paio di località il cui nome è simile a Gerasa, ma non si trova in riva al mare di Galilea, allora possono esserci stati degli errori nella tradizione orale che potrebbe anche avere collegati due avvenimenti differenti. La cosa non ci interessa più di tanto perché noi facciamo una lettura sincronica. Quello che è sicuro è che ci troviamo in territorio pagano: la Decapoli come affermato alla fine e inoltre ce lo rivela l'allevamento di così tanti maiali, animali la cui carne non poteva essere consumata dagli ebrei; una regione, nel complesso, considerata impura.
In questo brano Gesù inaugura la sua predicazione ai pagani con la liberazione di un ossesso, proprio come aveva fatto all'inaugurazione della predicazione a Cafarnao Mc 1,21 (Lettura 14).
In prima battuta potremmo pensare che l'ossesso dimorasse tra i sepolcri perché emarginato dalla comunità, ma se egli era in grado di spezzare ceppi, catene e girare per monti possiamo affermare che la sua abitazione fosse una sua scelta o, meglio, una scelta dei demoni che lo possedevano. Il luogo dei sepolcri, luogo di morte, è quello più consono alla natura dei demoni stessi.
In questa linea ci indirizza anche il libro della Sapienza che così commenta l'ingresso della morte nella creazione avvenuta come conseguenza del peccato dei progenitori nel Giardino, su istigazione del serpente / diavolo:
Sap 2,24 «Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo; / e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono».
E Paolo, nella prima lettera ai Corinti ci ricorda che la morte è radicale nemico di Dio:
1 Cor 15, 25 «Bisogna infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 26 L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte».
E l'affogamento di 2000 maiali, posseduti a loro volta dai demoni, va in questa direzione.
I demoni che posseggono questo uomo si chiamano "Legione" perché sono tanti da costituire una legione. È difficile dire da quanti uomini fosse composta una legione romana, perché il numero è cambiato più volte nel corso del tempo e delle località in cui stanziavano: un ordine di grandezza attendibile è di 5 - 6000 uomini. Non è il caso di stabilire delle proporzioni matematiche, ma il fatto che alla fine siano 2000 maiali a precipitare nel lago porta a pensare che effettivamente il malcapitato geraseno fosse alquanto tormentato dai suoi sgraditi ospiti.
Ancora una volta rileviamo che la cacciata dei demoni non avviene a seguito di un rito o di particolari preghiere o di qualche "abracadabra", ma semplicemente da un imperativo comando di Gesù: «Esci, spirito immondo, da quest'uomo!».
La richiesta dei demoni è duplice: non essere cacciati dalla regione v10 e prendere possesso della mandria dei porci v12.
L'azione di Gesù sembra accogliere queste richieste, ma l'esito è ben più radicale perché i porci indemoniati si gettano nel precipizio e annegano nel mare. Così la regione risulta purificata in vista della missione.
Adesso sì, possiamo censurare i geraseni perché da parte loro non c'è alcun apprezzamento di avere un concittadino liberato dal male e piena salute, si preoccupano piuttosto del lato economico - in verità non indifferente - e pregano Gesù di allontanarsi dalla regione.
L'uomo risanato invece, contento di avere ritrovato se stesso, chiede a Gesù di restare con lui e di mettersi alla sua sequela insieme ai dodici, ma Gesù non può accettare questa offerta perché assumerebbe la forma di un pagamento e un'adesione di qualità precaria. Infatti nessuno degli apostoli è mai stato miracolato, ma, come abbiamo visto, hanno seguito il Signore solo a seguito di un suo invito. È una fede completamente gratuita.
Allora l'ex indemoniato, mostra il suo ringraziamento e la sua gioia girando per la Decapoli raccontando la sua storia e le meraviglie operate da Gesù.
È un cripto-apostolo, il tredicesimo che inizia la missione verso i pagani, la sua gente. È anche il primo missionario.
Lettura 38
Dalla predicazione alle opere
L'emorroissa. La fede che salva - Mc 5,21-34
Mc 5,21 «Essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. 22 Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi 23 e lo pregava con insistenza: «La mia figlioletta è agli estremi; vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva». 24 Gesù andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno.
25 Or una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia 26 e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, 27 udito parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. Diceva infatti: 28 «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». 29 E subito le si fermò il flusso di sangue, e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male.
30 Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi mi ha toccato il mantello?». 31 I discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: Chi mi ha toccato?». 32 Egli intanto guardava intorno, per vedere colei che aveva fatto questo. 33 E la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. 34 Gesù rispose: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va' in pace e sii guarita dal tuo male».
Tutto il gruppo ha riattraversato il mare ed è tornato in Galilea. Rimandiamo l'episodio della figlia di Giairo alla prossima lettura anche se qui c'è il'inizio.
Gesù è sempre circondato e pressato dalla folla, come rilevano anche i discepoli al v31.
Il brano termina con la sentenza: «Figlia, la tua fede ti ha salvata».
Come la tua fede ti ha salvata? Dovrebbe essere "La tua fede ti ha guarita". Invece per Gesù nel gesto della donna c'è un di più che dice la di lei fede. Ma la fede consiste nel toccare un mantello? E allora, le preghiere, i digiuni, i pellegrinaggi al tempio ecc. dove vanno a finire? Perché tra l'altro è la seconda volta in cui Gesù usa una affermazione di questo genere.
La prima volta, anche se con accento diverso, in occasione della guarigione del paralitico calato dal tetto, Mc 2,5 «E Gesù, vedendo la loro fede, (dei portatori) dice al paralitico: «Figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati», lettura 20.
Le parole sono un po' diverse, ma l'esito è lo stesso: siamo di fronte alla figura della "fede che salva".
Allora ci rendiamo conto che il nocciolo di questo testo è individuare il senso della fede di questa donna.
Il nocciolo nasce dal tema dell'impurità legale legata ad ogni perdita di sangue. Chi perde sangue è immondo e deve starsene a parte, come recita questo versetto del Libro del Levitico, ma tutti i capitoli attorno al 15 trattano dettagliatamente i vari casi.
Lv 15, 25 «La donna che ha un flusso di sangue per molti giorni, fuori del tempo delle regole, o che lo abbia più del normale sarà immonda per tutto il tempo del flusso, secondo le norme dell'immondezza mestruale. 26 Ogni giaciglio sul quale si coricherà durante tutto il tempo del flusso sarà per lei come il giaciglio sul quale si corica quando ha le regole; ogni mobile sul quale siederà sarà immondo, come lo è quando essa ha le regole. 27 Chiunque toccherà quelle cose sarà immondo; dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e sarà immondo fino alla sera. 28 Quando essa sia guarita dal flusso, conterà sette giorni e poi sarà monda. 29 L'ottavo giorno prenderà due tortore o due colombi e li porterà al sacerdote all'ingresso della tenda del convegno. 30 Il sacerdote ne offrirà uno come sacrificio espiatorio e l'altro come olocausto e farà per lei il rito espiatorio, davanti al Signore, per il flusso che la rendeva immonda».
(Sarebbe utile indagare se questo precetto è originario della religione ebraica o appartiene all'antropologia precedente, visto che ancora oggi è praticato in altre culture ad esempio vedi:
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/impura-ciclo-deve-dormire-tenda-f...(link is external))
Tra l'altro nella parabola del Buon Samaritano (Lc 10, 29-36), il sacerdote e il levita che non si fermano a soccorrere l'uomo ferito, non sono due disgraziati che se ne fregano, ma uomini del tempio che se restassero contaminati non potrebbero svolgere il loro servizio liturgico.
Ora, questa donna vive una condizione di impurità da dodici anni, di conseguenza non può toccare nessun oggetto della sua casa altrimenti i suoi famigliari diverrebbero immondi. Non può accarezzare i suoi bambini, non accostarsi al marito, non può preparare loro da mangiare: deve vivere appartata per suo conto, sempre a distanza dagli altri.
Anche perché sin da bambina l'avevano avvertita: quando avrai le tue regole, dovrai startene per tuo conto... e se tocchi qualcuno vai all'inferno immediatamente, capito? Guai a te se oserai toccare la mamma, il papà o i fratelli o qualunque oggetto della casa... perché lo dice la Legge di Dio!
Forse due o tre giorni si poteva sopportare, ma dodici anni...!
E questa donna ha una idea: "Dio non può essere il principio della reclusione dentro un tugurio di una persona. Non può essere il fautore di una simile condanna e di una simile tortura"!
E così decide di toccare il mantello dell'Uomo di Dio, il grande profeta in parole ed opere.
Sa benissimo che di conseguenza l'Uomo di Dio diventa "immondo": non può pregare, non può stare in mezzo all'altra gente, non può toccare nessuna persona e nessun oggetto, ma Dio, secondo lei, non può essere l'autore di questa roba.
Quindi per toccare quel mantello c'è voluto una grande forza, molto coraggio e una grande fiducia nella "sua" immagine di Dio.
Pensa di fare il suo gesto di nascosto, ma Gesù vuole metterlo in luce perché l'immagine di Dio nutrita da questa donna non è frutto di un capriccio, ma è ispirata dal Padre.
E così il brano termina con una asserzione fondamentale: «La tua fede ti ha salvata».
Però!? A nessuno dei suoi discepoli, ad esempio Pietro, ha mai detto: «La tua fede ti ha salvato»... e allora?
Lettura 39
Dalla predicazione alle opere
La figlia di Giairo - Mc 5,21-24; 35-43
Mc 5,21 «Essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. 22 Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi 23 e lo pregava con insistenza: «La mia figlioletta è agli estremi; vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva». 24 Gesù andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. [Il testo prosegue con l'episodio dell'emorroissa che abbiamo esaminato nella lettura precedente]
35 Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». 36 Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, continua solo ad aver fede!». 37 E non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. 38 Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. 39Entrato, disse loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». 40 Ed essi lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. 41 Presa la mano della bambina, le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati / egeirō!». 42 Subito la fanciulla si levò / anestē alzò e si mise a camminare; aveva dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. 43 Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare».
Ricordiamo che avendo la donna impura, toccato il mantello di Gesù, anch'egli è reso impuro: non può rivolgersi a Dio, non può pregare, non può... finché ha lasciato trascorrere il tempo prescritto e compiute la pratiche di purificazione.
Egli avrebbe potuto fare finta di niente, lasciare che la donna guarita andasse per i fatti i suoi e porre una pietra sul tema dell'impurità e, invece, come abbiamo visto, costringe la donna a mettere in luce ciò che aveva fatto, per cui agli occhi di tutta la folla «che lo premeva da ogni parte» anche Gesù appare impuro.
Ma per Gesù il tema di questo tipo di impurità non conta nulla. Un uomo o una donna colpiti dal male non sono immondi, ma sempre esseri umani, creati ed amati da Dio, che devono essere curati, amati e liberati dal male. Il nemico non è l'ammalato, ma il Male che non gli consente una vita gioiosa.
A questo punto, anche Giairo, il capo della sinagoga, deve decidere se mantenere l'invito posto a Gesù ad entrare nella sua casa o declinarlo visto che adesso il maestro si è reso immondo. Tanto più che i servi di casa sono venuti per dirgli che la figlia era ormai morta per cui quella visita sarebbe inutile. E d'altra parte egli ha appena visto la prodigiosa guarigione della donna propiziata dalla di lei fede ed anche sostenuto dall'invito di Gesù: «Non temere, continua solo ad aver fede!».
Il racconto prosegue lontano dalla folla, segno che Gesù non ama gesti teatrali, ma alla presenza di tre discepoli: Pietro, Giacomo e Giovanni. Sono i testimoni che troveremo nei momenti cruciali: la Trasfigurazione (Mc 9,2), il discorso sulla fine (Mc 13,3) e la preghiera nel Getzemani (Mc 14,33). Questo significa che sta per accadere un evento molto importante.
Il gruppo viene accolto tra pianti e lamenti ai quali segue la derisione quando Gesù dice: «... non è morta ma dorme».
Sarebbe del tutto fuori luogo fare ipotesi di coma. Il significato rimanda piuttosto al senso della morte del cristiano che è sempre comunque una passaggio verso la gloria della risurrezione. Non dobbiamo dimenticare che Marco scrive il suo Evangelo come catechesi per la sua chiesa, la quale doveva elaborare e maturare esistenzialmente il senso della risurrezione di Gesù e quella di ogni credente alla fine dei tempi.
Anche in questo caso come nella guarigione della suocera di Pietro Mc 1,31 lettura 15, Gesù prende per mano la ragazzina e al semplice comando " alzati / egeirō " segue la risposta della fanciulla che si alza / anestē. Questa è voce dell'indicativo aoristo del verbo anistēmi: sollevare, alzare, tirare su, ecc. che dopo gli eventi pasquali, si arricchisce della voce: "risorgere".
Allora non sarebbe sbagliato tradurre con "risorgere", ma c'è una differenza sostanziale tra questa risurrezione e quella di Gesù. La risurrezione di Gesù è definitiva, il corpo del Risorto è un "corpo glorioso" che ha una vita senza fine, quello di questa fanciulla può consentirgli una vita normale: sposarsi, avere figli, ecc., ma è destinato ancora a morire; questa tecnicamente si definisce: "risuscitamento".
Il comando di Gesù di non dire niente a nessuno ci spiega come egli temesse l'entusiasmo chiassoso conseguente a queste opere perché non ne coglieva il senso profondo.
Ancora una volta dobbiamo ricordare che gli Evangeli non parlano mai di miracoli, ma sempre di "guarigioni" nei Sinottici e di "segni" nel Vangelo di Giovanni.
Lettura 40
Riflessione complessiva sulle quattro opere
Mc 4,35 - 5,43.
Dopo avere esaminato singolarmente le quattro opere oggetto delle ultime letture, dobbiamo esplorare due temi che in qualche modo le collegano tra di loro: A- Chi è Gesù. B- La fede degli interlocutori.
A- CHI È GESÙ.
Ricordiamo che questo è il titolo della prima parte del vangelo di Marco e che le "Quattro opere" seguono il "Discorso parabolico".
1- Prima opera: traversata del Mare o la tempesta sedata, Mc 4,35-41; Lettura 36.
Questa opera termina con l'interrogativo che si pongono i discepoli:
Mc 4,35«E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?».
Facile rispondere: "è il nuovo Mosè". Così come Mosè ha portato gli ebrei sani e salvi attraverso il Mar Rosso, allo stesso modo Gesù salva i dodici, il nuovo popolo, dalla improvvisa tempesta.
Però notiamo subito delle vistose differenze.
Es 3,15 « JHWH disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. 16 Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all'asciutto» [...] 21Allora Mosè stese la mano sul mare. E JHWH, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto; le acque si divisero».
L'azione di Mosè è semplice risposta obbediente al comando di Dio, che provvede con quel vento impetuoso a dividere le acque e a prosciugare il mare.
Anche nel caso del profeta Giona è il Signore che per richiamare all'obbedienza il suo profeta scatena sul mare una grande tempesta (lettura 4):
Gio 1,4 «Ma JHWH scatenò/ tul sul mare un grande (gadol) vento sul mare e vi fu una grande (gadol) tempesta sul mare e la nave "pensava" di sfasciarsi».
Con queste premesse l'interrogativo dei discepoli è più che plausibile. Non è che Gesù si sia rivolto a Dio perché calmasse gli elementi atmosferici, ma si rivolto imperativamente al vento e al mare:
Mc 4,39 «Destatosi, minacciò il vento e disse al mare: «Taci! Calmati!». E il vento si placò e vi fu grande bonaccia».
Quindi va bene il parallelo con Mosè, ma qui c'è qualcuno che è ben più di Mosè, perché comanda alle onde e al vento... e questi gli obbediscono. Però solo Dio può fare queste cose. Ma allora Gesù chi è?
2- Seconda opera: cacciata di una Legione di demoni dall'ossesso di Gerasa, Mc 5,1-20; Lettura 37.
Gesù aveva già cacciato molti demoni, ma sempre in Galilea, nel territorio di Israele. In questo caso egli opera allo stesso modo anche in territorio pagano, la Decapoli appunto, e anche qui i demoni lo riconoscono e poi sono costretti ad obbedirgli. Anche se fa loro la concessione di impossessarsi di una mandria di porci.
Allora Gesù è in grado esercitare il suo potere ovunque nel mondo. La sua azione, la sua autorità, exousia, non conosce limiti di spazio: è universale. Altra caratteristica di Dio. Ma allora Gesù chi è?
3- Terza opera: guarigione dell'emorroissa, Mc 5,21--34; Lettura 38.
In questo caso la guarigione della donna non avviene come esito di un comando di Gesù, ma solo perché l'emorroissa gli ha toccato il mantello. Allora Gesù può guarire anche in forza della sua presenza. La sua potenza di salvezza, non ha bisogno come abbiamo già visto, di preghiere, riti, liturgie, abracadabra: basta la sua vicinanza.
Però la novità contenuta in questo racconto è l'indifferenza con cui Gesù reagisce all'essere toccato da una donna immonda. Questo contrasta con tutta la tradizione e con la stessa Legge. Nel capitolo di 5 di Matteo troviamo diversi passaggi in cui Gesù si esprime grosso modo così: "Vi fu detto... ma io vi dico". Cioè l'autorità, exousia di Gesù mostra di potere modificare anche la tradizione a la stessa Legge.
Ma solo Dio può modificare la sua legge. Allora Gesù chi è?
4- Quarta opera: risuscitamento della figlia di Giairo, Mc 5,21-24; 35-43; Lettura 39.
In questo caso non solo Gesù mostra di non tenere assolutamente conto del tema dell'impurità legale, del quale egli stesso sarebbe afflitto perché la donna l'ha toccato, ma invita anche il capo della sinagoga a non tenerne conto e infatti è ospitato a casa sua.
L'esito del racconto, come abbiamo visto, e il risuscitamento della ragazza di dodici anni, ormai spacciata; tutti la davano per morta.
Allora ai discepoli si presenta un altro problema: Gesù è signore della vita, perché può richiamare i morti alla vita.
Ma solo Dio ha il potere di dare la vita (e la morte?). Allora Gesù chi è?
B- LA FEDE DEGLI INTERLOCUTORI.
1- Prima opera: traversata del Mare o la tempesta sedata, Mc 4,35-41 Lettura 36.
Quella tempesta non dovette essere roba da ridere, perché quei discepoli, tutti pescatori provetti, con la barca piena d'acqua, prossimi ad affondare, devono essersela vista proprio brutta. Però vengono rimproverati:
Mc 4,40 «Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?».
Ovviamente noi sin dall'inizio siamo schierati dalla parte di Gesù, ma dovremmo essere molto cauti ad esprimere giudizi verso questi ex pescatori.
Certo la loro fede non è ancora "affidamento", ma è una "fede che cerca". Loro sono comunque quelli che per tre anni gli sono trotterellati dietro, nella stanchezza, nelle vittorie, nelle sconfitte. Spesso rimproverati dal loro Maestro, qualche rara volta elogiati. Però è la loro "fede in ricerca" che ha prodotto quei frutti che a duemila anni di distanza noi siamo in grado di apprezzare, compreso il vangelo sul quale stiamo riflettendo.
In questa fase la loro fede è certamente debole, ma Gesù si fida di loro. E questo è ciò che conta.
2- Seconda opera: cacciata di una Legione di demoni dall'ossesso di Gerasa, Mc 5,1-20; Lettura 37.
L'episodio termina così:
Mc 5,18 «Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di permettergli di stare con lui. 19Non glielo permise, ma gli disse: «Va' nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato». 20 Egli se ne andò e si mise a proclamare / kērussō per la Decàpoli ciò che Gesù gli aveva fatto, e tutti ne erano meravigliati».
Un "ingrediente" che Gesù ritiene indispensabile per operare le guarigioni è l'esistenza della fede e questo ci fa intendere meglio il rimprovero rivolto ai discepoli nel brano precedente. Ma è una condizione che, ovviamente non può pretendere agli indemoniati, perché essi non sono padroni della loro volontà e del loro intelletto. E così accade per questo indemoniato.
Però una volta guarito emerge una sua fede che non è di ricerca, ma una fede che vuole "testimoniare" ciò che Gesù gli aveva fatto, a tutta la Decapoli, territorio pagano. E tutti restano stupiti.
3- Terza opera: guarigione dell'emorroissa, Mc 5,21--34; Lettura 38.
Mc 5,27 [...] Diceva infatti: 28 «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». 29 E subito le si fermò il flusso di sangue, e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. 30 Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi mi ha toccato il mantello?».
Potremmo forse addirittura dire che questa guarigione sia opera solo della fede della donna, perché essa avverte l'arresto della perdita di sangue senza che Gesù abbia compiuto alcun gesto o pronunciato parole a suo riguardo.
Un miracolo (termine non usato dal vangelo che adoperiamo solo per intenderci) "strappato" a Gesù a sua insaputa.
Quello che, poi, Gesù dice alla donna ha esclusivamente la funzione di fare emergere la sua fede, che fino a quel momento era rimasta nascosta. E Gesù la definisce "fede che salva"!
Chissà quante fedi nascoste di questo tipo ci sono giro anche oggi!
4- Quarta opera: risuscitamento della figlia di Giairo, Mc 5,21-24; 35-43; Lettura 39.
Anche Giairo deve avere il coraggio della fede perché come l'emorroissa e Gesù stesso, deve superare il tabù dell'impurità legale. Cosa non da poco, perché significa porre in discussione i suoi comportamenti precedenti insieme a quelli della sua famiglia.
Grazie a questa fede, la figlia di dodici anni, cioè che stava entrando nella maturità, secondo le consuetudini epocali, può essere richiamata alla vita.
Lettura 41
Gesù respinto da Nazaret: la non fede dei nazaretani Mc 6,1 - 6a.
Mc 6:1 «E uscito di là viene nella sua patria e lo seguono i suoi discepoli. 2 Venuto il sabato cominciò a insegnare / didaskō nella sinagoga. E molti ascoltandolo restavano sbigottiti dicendo:
Da dove vengono a questo qui queste cose?
E quale sapienza è data a questo qui?
E quei dunameis / potenze / miracoli che avvengono con le sue mani?
3 Non è costui il carpentiere? Il figlio di Maria? Il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?». E si scandalizzavano di lui. 4 Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». 5 E non poteva fare alcun miracolo / dunamin, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì. 6 E si meravigliava della loro incredulità».
Abbiamo visto nella lettura 14, che Gesù aveva esercitato il suo insegnamento autorevole, exousia, in parole e opere nella sinagoga di Cafarnao. Nella stessa sinagoga, avviene lo scontro della quinta e ultima delle controversie galilaiche, lettura 25.
In questo brano Gesù, entra nella sinagoga del suo villaggio, Nazareth. L'accoglienza è molto fredda se non addirittura ostile.
Nel prosieguo dell'Evangelo di Marco non troveremo più Gesù all'interno di una sinagoga.
v2- Notiamo la differenza tra la reazione degli ascoltatori della sinagoga di Cafarnao, Mc 1,22 lettura 14, che rimasero stupiti per il suo insegnamento, contro quelli di Nazareth che "restavano sbigottiti".
Lo comprendiamo meglio dalle prime tre domande, tutte dispregiative.
Prima domanda dispregiativa: "Da dove vengono a questo qui queste cose"?
Questo ragionamento domina anche il nostro tempo: se non conosco la causa, nutro dubbi sulla qualità dell'effetto, secondo il principio causa - effetto. Se non mi spiego il perché, nego l'evidenza della cosa, secondo il principio di ragion sufficiente.
Seconda domanda dispregiativa: "E quale sapienza è data a questo qui"?
Un pio ebreo che frequenta la sinagoga non dovrebbe avere dubbi perché la Bibbia parla chiaro attraverso molti testi di quale sia l'origine della Sapienza; ne riportiamo due:
Gb 28, 12 «Ma la sapienza da dove si trae? / E il luogo dell'intelligenza dov'è?
13 L'uomo non ne conosce la via, / essa non si trova sulla terra dei viventi.
14 L'abisso dice: «Non è in me!» / e il mare dice: «Neppure presso di me!».
15 Non si scambia con l'oro più scelto, / né per comprarla si pesa l'argento.
16 Non si acquista con l'oro di Ofir, / con il prezioso berillo o con lo zaffiro.
17 Non la pareggia l'oro e il cristallo, / né si permuta con vasi di oro puro.
18 Coralli e perle non meritano menzione, / vale più scoprire la sapienza che le gemme.
19 Non la eguaglia il topazio d'Etiopia; / con l'oro puro non si può scambiare a peso.
20 Ma da dove viene la sapienza? / E il luogo dell'intelligenza dov'è?
21 È nascosta agli occhi di ogni vivente / ed è ignota agli uccelli del cielo.
22 L'abisso e la morte dicono: / «Con gli orecchi ne udimmo la fama».
23 Dio solo ne conosce la via, / lui solo sa dove si trovi,
24 perché volge lo sguardo / fino alle estremità della terra, / vede quanto è sotto la volta del cielo.
25 Quando diede al vento un peso / e ordinò le acque entro una misura,
26 quando impose una legge alla pioggia / e una via al lampo dei tuoni;
27 allora la vide e la misurò, / la comprese e la scrutò appieno
28 e disse all'uomo: / «Ecco, temere Dio, questo è sapienza / e schivare il male, questo è intelligenza».
In questo brano del libro di Giobbe, di cui consigliamo leggere interamente i capitoli 27 e 28, il saggio fa una ricerca del luogo in cui sia possibile trovare la sapienza e in che cosa essa consista. In questo caso è stato Dio che l'ha cercata per primo, perché ne aveva bisogno per compiere le sue opere. Però essa era altra da Dio v 27.
Nel brano do Proverbi invece essa è creatura di Dio:
Pr 8,22 «Il Signore mi ha creato all'inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, fin d'allora.
23 Dall'eternità sono stata costituita, / fin dal principio, dagli inizi della terra.
24 Quando non esistevano gli abissi, io fui generata; /quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua;/ 25prima che fossero fissate le basi dei monti, / prima delle colline, io sono stata generata.
26 Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi, / né le prime zolle del mondo;
27 quando egli fissava i cieli, io ero là; / quando tracciava un cerchio sull'abisso;
28 quando condensava le nubi in alto, / quando fissava le sorgenti dell'abisso;
29 quando stabiliva al mare i suoi limiti, / sicché le acque non ne oltrepassassero la spiaggia;
quando disponeva le fondamenta della terra, / 30 allora io ero con lui come architetto
ed ero la sua delizia ogni giorno, / dilettandomi davanti a lui in ogni istante;
31 dilettandomi sul globo terrestre, / ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo».
In questo brano, tratto dal libro dei Proverbi, la Sapienza è la prima creatura di Dio, mezzo indispensabile perché potesse iniziare la creazione. Ma il v 25 va oltre, perché dice che è stata generata da Dio: la Sapienza è Figlia di Dio.
Ma se la sapienza è generata da Dio, allora si afferma una verità ben più grande, messa in chiaro dai primi versetti del Vangelo di Giovanni:
Gv 1,1 «In principio era il Logos / Sapienza / Verbo / Parola // e il Logos era presso Dio / e Dio era il Logos».
Abbiamo mantenuto il termine greco Logos perché tra i vari significati comprende anche quello di "Sapienza".
Con questo vogliamo dire che sin dall'inizio le nascenti chiese, avevano letto, nella immagine della Sapienza, riportata in diverse forme nell'Antico Testamento, la Figura del Figlio Unigenito.
Se è così, allora comprendiamo la provocazione espressa dalla seconda domanda dei nazaretani. Avevano la Sapienza lì sotto il naso, ma non hanno fatto nulla per cercare di comprenderla, accecati com'erano dalla loro precedente conoscenza.
Terza domanda dispregiativa: "E quei dunameis / potenze / miracoli che avvengono con le sue mani"?
Le guarigioni, le cacciate dei demoni di cui avevano avuto notizia erano fatti concreti a partire dai quali avrebbero dovuto porsi la domanda: "Ma allora chi è questo nostro concittadino"? e iniziare una seria ricerca.
Forse essi desideravano che Gesù facesse qualcosa di teatrale anche a Nazareth, ma non c'era una condizione fondamentale perché questo avvenisse: la mancanza di fede o più modestamente l'anticipazione di un credito verso il loro compaesano. Ma lì è emersa soltanto la critica.
v5 abbiamo mantenuto il verbo all'imperfetto che in greco indica il perdurare di un'azione: Gesù per il periodo in cui è stato lì non ha potuto fare le opere che aveva compiuto altrove. E ne conosciamo la ragione che abbiamo elaborato nella lettura precedente: la mancanza di fede. La fede è condizione necessaria perché il miracolo possa avvenire e non il contrario. Non è il miracolo che produce la fede, ma la fede che può produrre il miracolo.
Allora questo brano si pone anche come conclusione coerente con il tema della fede già elaborato: i discepoli durante la tempesta, l'emorroissa, la figlia di Giairo, ognuno con il suo particolare tipo di fede, ma gli ultimi, i nazaretani addirittura non hanno alcuna fede e sono in opposizione a Gesù.
Il loro problema è come ri-conoscere in un essere umano, che loro conoscevano molto bene, la presenza del divino, vale a dire il mistero dell'Incarnazione.
E se così, il loro problema non è anche il nostro?
Lettura 42
Sintetica escursione della terza sezione della prima parte - Mc 6,6b - 8,30.
Mc 6,6b «Gesù andava attorno per i villaggi insegnando».
Questo stenografico sommario segna l'inizio di una nuova sezione che possiamo chiamare: "L'identità di Gesù", perché al termine, finalmente, troveremo la proclamazione della sua identità come Cristo / Messia / Unto.
È sempre bene tenere presente che Cristo non è un nome proprio, ma il termine greco per dire Unto, cioè: Messia.
La sezione inizia con il sommario di Mc 6,6b dove si dice: "Gesù andava attorno per i villaggi insegnando" quindi il simbolo è il ministero itinerante di Gesù.
Prima la localizzazione era il mare, adesso è il ministero itinerante, andare per i villaggi.
Subito dopo in Mc 6,7-13 viene presentato l'invio in missione dei discepoli, un ministero itinerante che è l'esecuzione di quello scopo per cui Gesù li aveva chiamati, come abbiamo visto in: Mc 3,14 «Ne costituì Dodici che stessero con lui 15e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demòni».
Troviamo poi in Mc 6,14-29 l'inserzione riguardante il martirio di Giovanni il Battista, che non è messa lì solo per dovere di cronaca, ma perché svolge una funzione molto significativa facendo inclusione con la fine della sezione: la confessione di Pietro. Qui Erode chiede chi è Giovanni, alla fine Gesù chiede «chi dice la gente che io sia e chi dite voi che io sia?". Per questo l'argomento della sezione è: "L'identità di Gesù".
In modo più ampio il tema dovrebbe essere: "I discepoli chiamati a scoprire Gesù, attraverso le manifestazioni che egli dà di sé".
In particolare questa sezione è dominata da due grandi manifestazioni di Gesù che ne costituiscono la chiave interpretativa: le due moltiplicazione dei pani insieme alla ricorrenza di ben 14 volte della parola "pane". Motivo per cui la sezione può essere denominata anche: "sezione dei pani".
Alla prima moltiplicazione dei pani segue Gesù che cammina sulle acque Mc 5,46-52.
Si tratta di una manifestazione di Gesù che Giovanni pone dopo la risurrezione, ma Marco la inserisce in questa fase dato che i discepoli non riconoscono il Maestro «perché non avevano capito il segno dei pani».
Allora la comprensione del segno del Pane (e lo scriviamo maiuscolo per aiutare a mangiare la foglia) è la condizione per venire a conoscere l'identità di Gesù.
Segue poi Mc 6,53-56 un breve sommario di guarigioni compiute da Gesù.
In Mc 7,1-23 vi è la disputa sulle tradizioni degli antichi, circa il puro e l'impuro. Attraverso questa disputa e la raccomandazione di superare la distinzione tra puro e impuro, Gesù chiede che venga superata la barriera tra giudei e pagani. Il primo effetto di questo superamento, è il miracolo della siro-fenicia di Mc 7, 24-30, la quale chiede che i cagnolini possano avere almeno le briciole del pane che cadono dalla mensa. Gesù premia la sua fede. E così ritorna nuovamente il tema della fede.
In Mc 7,31-37 abbiamo la guarigione di valenza simbolica e di contrasto del sordomuto, che dovremo mettere in luce, perché i discepoli non hanno orecchi per ascoltare e comprendere il segno del pane donato Gesù.
La nostra sezione prosegue con la seconda moltiplicazione dei pani in Mc 8,1-10 che dovrebbe definitivamente aprire l'udito, gli occhi e il cuore dei discepoli per capire chi è Gesù. Ma occhi e orecchi restano ancora tappati!
La collocazione di questa seconda moltiplicazione avviene in territorio pagano.
Segue poi, in Mc 8,11-13 una breve controversia con i farisei per i quali i segni dei pani non contano, ma pretendono un segno dal cielo per stabilire chi è Gesù. La sezione si chiude con la pericope della incomprensione dei discepoli di Mc 8,4-21 dove c'è il più grave rimprovero che Gesù rivolge ai suoi discepoli, i quali, come i farisei, vorrebbero altri segni perché continuano a non capire il segno del pane.
Tutti i sensi: udito, vista, intelligenza, cuore dovrebbero essere messi in funzione, ma i discepoli invece non hanno udito, non hanno vista, hanno il cuore indurito, non hanno comprensione.
È interessante notare come a questo punto i discepoli sono diventati come "quelli di fuori" incontrati nei primi capitoli, cioè quelli che guardano, ma non vedono, che ascoltano, ma non intendono. Prima i discepoli erano quelli che stavano intorno a Gesù e pian piano hanno mostrato la loro incomprensione fino al punto che sembrano essere vicini agli scribi e ai farisei e a coloro che "sono fuori".
È il momento più drammatico di tutta la prima parte.
A questo punto c'è la guarigione simbolica del cieco di Betsaida, Mc 8,22-26, brano che è esclusivo di Marco. Questa guarigione è un miracolo simbolico perché da una parte si lega al rimprovero precedente secondo cui i discepoli non hanno occhi per vedere: ora Gesù dona la vista per vedere a un cieco.
È una guarigione legata alla successiva confessione di Pietro.
Finalmente, almeno Pietro, riconosce chi è Gesù: «Tu sei il Cristo».
Con la prossima lettura riprenderemo a leggere il testo passo passo.
Lettura 43
La missione dei discepoli. Mc 6,6b - 12.
Mc 6,6b «Gesù andava attorno per i villaggi, insegnando.
7 Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli / apostellō a due a due e diede loro potere /exousia sugli spiriti immondi. 8 E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa; 9 ma, calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche. 10 E diceva loro: «Entrati in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. 11 Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene, scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi, a testimonianza per loro». 12 E partiti, predicavano / kērussō che la gente si convertisse, 13 scacciavano molti demòni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano».
Abbiamo già trovato un alcuni versetti simili:
Mc 3,13 «E sale sul monte e chiama a sé quelli che lui voleva ed essi andarono da lui. [...] 14 Ne costituì Dodici che stessero con lui 15 e anche per mandarli / apostellō a predicare / kērussō e perché avessero il potere / exousia di scacciare i demòni».
Osserviamo il parallelismo esistenti tra i verbi relativi alla istituzione dei dodici di Mc 3,13-14, Lettura 29, e questo invio degli Apostoli; letteralmente mandati; dal verbo apostellō.
Tutto inizia da una chiamata, in latino voco, da cui vocazione. Ad essa segue un mandato, l'invio in missione; sostenuta dalla stessa exousia di guarire gli infermi e scacciare i demoni; tutto accompagnato dalla predicazione / kērussō.
In questa attività i discepoli sono prolungamento dell'azione che nei capitoli precedenti faceva Gesù.
Mentre i discepoli sono in missione Marco inserisce il racconto del martirio di Giovanni il battezzatore e questo è parallelo con l'inizio della missione di Gesù, che coincideva con l'arresto di Giovanni, Mc 1,14 .
Può sorprendere lo stile della missione dei discepoli, la loro povertà: la mancanza di denaro, la mancanza di cibo e nemmeno un abito di ricambio, per cui la loro è una predicazione da mendicanti.
L'ascoltatore, infatti, non deve essere colpito dal fascino dei predicatori, dall'eloquenza del linguaggio, ma esclusivamente dal contenuto del messaggio e dall'efficacia delle loro opere.
È anche significativo che vadano due a due, perché se vuoi testimoniare l'amore e la fraternità, non puoi farlo da solo.
In questo c'è anche un aspetto legalistico di quel tempo: una testimonianza per essere valida richiede almeno due testimoni.
Il gesto di scuotere la polvere dai sandali era usato dai pii israeliti quando tornavano da terre pagane e prima di entrare nella "terra promessa", compivano quel gesto, perché l'empietà dei gentili non entrasse in Israele. Nel nostro caso non dovrebbe sorprenderci il distacco o lo sprezzatura con cui rispondere alla non accoglienza. Quello "scuotere la polvere dai sandali", mostra in modo molto efficace che essi non sono commessi viaggiatori che devono a tutti i costi venderti il loro aspirapolvere. C'è una libertà del "servo della Parola" che non deve essere perduta... proprio perché "servo della Parola".
Anche perché la Parola ha in sé la sua efficacia come è stato ben esposta da Marco nel discorso parabolico del capitolo 4.
Anche là c'è quel Seminatore che sparge il seme con sprezzatura, diremmo, con distacco, con libertà, perché Egli sa che il seme ha in sé la forza per germinare e mettere radici nei terreni più improbabili e crescere rigogliosamente... che tu dorma o che vegli.
E anche questo spiega la povertà dei mezzi e degli stessi discepoli.
È sempre la Parola che agisce e riesce a penetrare.
Questo aspetto non è novità nella tradizione biblica perché la troviamo ad esempio nel profeta Ezechiele:
Ez 2,3 «[Dio] Mi disse: «Figlio dell'uomo, io ti mando agli Israeliti, a un popolo di ribelli, che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri hanno peccato contro di me fino ad oggi. 4 Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: Dice il Signore Dio. 5 Ascoltino o non ascoltino - perché sono una genìa di ribelli - sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro».
Se è così la libertà dei servi della Parola, indica che nella ricezione di essa svolge un ruolo significativo anche la responsabilità dell'ascoltatore al quale è richiesto un ascolto perlomeno attento.
Anche perché il cristianesimo è una cosa seria. Molto seria!
Lettura 44
Il martirio di Giovanni il Battista. Mc 6,14 - 29
Mc 6,14 «Il re Erode sentì parlare di Gesù, poiché intanto il suo nome era diventato famoso. Si diceva: «Giovanni il Battista è risuscitato dai morti e per questo il potere dei miracoli opera in lui». 15 Altri invece dicevano: «È Elia»; altri dicevano ancora: «È un profeta, come uno dei profeti». 16 Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risuscitato!».
17 Erode infatti aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo, che egli aveva sposata. 18 Infatti Giovanni diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello». 19 Per questo Erodìade gli portava rancore e avrebbe voluto farlo uccidere, ma non poteva, 20 perché Erode aveva timore di Giovanni, sapendolo giusto e santo, e vigilava su di lui; e anche se nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri.
21 Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i grandi della sua corte, gli ufficiali e i notabili della Galilea. 22 Entrata la figlia della stessa Erodìade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla ragazza: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». 23 E le fece questo giuramento: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». 24 La ragazza uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». 25 Ed entrata di corsa dal re fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia immediatamente su un vassoio la testa di Giovanni il Battista». 26 Il re divenne triste; tuttavia, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. 27 Subito il re mandò una guardia con l'ordine che gli fosse portata la testa. 28 La guardia andò, lo decapitò in prigione e portò la testa su un vassoio, la diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. 29 I discepoli di Giovanni, saputa la cosa, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro».
La narrazione del martirio di Giovanni Battista avvenuto per il capriccio di una ragazzina e l'incapacità di un re che non ha il coraggio di amministrare la giustizia con coerenza - anche in Galilea era in vigore la legge di Roma - rimanda ad un altro magistrato romano che di lì a poco tempo non avrà il coraggio di compiere il suo dovere di magistrato romano e dire di no al chiasso della folla.
Mt 27,24 «Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla: «Non sono responsabile, disse, di questo sangue; vedetevela voi!».
Un esempio diventato paradigma di tutti quei giudici che non amministrano la giustizia secondo la legge, tanto da avere generato l'aggettivo "pilatesco", a perenne vergogna di quell'antico magistrato.
C'è un altro parallelismo che dobbiamo evidenziare e sono le domande e risposte sull'identità di Gesù, vale a dire i vv 14-16 che formano inclusione con la parte conclusiva della sezione:
Mc 8,27 «Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo; e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: «Chi dice la gente che io sia?». 28 Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti».
Notiamo che le risposte sono esattamente le stesse anche se disposte in una differente successione.
Tuttavia dobbiamo formulare un'ipotesi storica che il testo non chiarisce, ma che ai lettori delle prime Chiese era perfettamente nota.
Cosa pensa Erode quando dice "risuscitato"? Egli era infatti idumeo di origine, educato in ambienti romano- ellenisti, con precarie conoscenze dell'ambiente di Israele che probabilmente disprezzava. La sua vita matrimoniale dice chiaramente che la Legge di Israele era per lui acqua fresca. Ma appunto lui, e la cultura che condivideva cosa pensava quando diceva "risurrezione"? E cosa pensava quando diceva: "morte"? E cosa credeva a proposito dei morti? E poi, se già temeva Giovanni il battezzatore quando era in vita, che cosa si attendeva, adesso che era "risuscitato"? I romani avevano una folle paura dei morti e i culti celebrati in loro onore avevano fondamentalmente lo scopo di tenerli buoni... e il più possibile lontani.
Noi quando diciamo "risurrezione" pensiamo agli aventi pasquali e post pasquali che hanno riguardato Gesù Cristo, ma Erode e tutta le gente di quel tempo non aveva mai incontrato uno che fosse risuscitato.
La risurrezione di Gesù Cristo porta nel mondo una nuova concezione della morte che abbiamo fatto nostra e che la cultura condivide senza neanche rendersene conto.
Essa, morte, non è più un evento irreparabile, perché segna il passaggio da una vita precaria, provvisoria, faticosa verso una nuova vita in cui non vi sarà più pianto. Una vita in cui Dio asciugherà ogni lacrima. Una vita piena in comunione con Dio e coloro che ci hanno e abbiamo amato. In breve diciamo che i nostri cari sono nello splendore di Dio.
Non è questo il luogo in cui sviluppare questo tema perché bisognerebbe fare un confronto tra l'antropologia innovata dal cristianesimo e le antropologie antiche e meno antiche prima che ne venissero a contatto.
Possiamo suggerire un testo di facile lettura, con ricca bibliografia: F. Agnoli, Indagine sul cristianesimo. Come si è costruito il meglio della civiltà, La Fontana di Siloe.
Il tema può essere approfondito anche su questo sito, in "approfondimenti - la teologia oggi - morte e resurrezione.
Per tornare al nostro testo vediamo che l'inizio di questa sezione mette subito in scena il tema del martirio. Per il momento è quello di Giovanni, ma i parallelismi cui abbiamo accennato sono già un prologo di ciò che avverrà a Gerusalemme.
Così l'ombra della croce si fa sempre più vicina.
Lettura 45
Il deserto: nuova sinagoga. Mc 6,30- 34.
Mc 6,30 «Gli apostoli si riunirono / sunàgontai intorno a Gesù e gli riferirono tutto quanto avevano fatto e insegnato /didaskō. 31 Ed egli disse loro: «Venite voi soli in disparte in un luogo deserto, e riposatevi un po'». Infatti erano molti quelli che venivano e partivano e non avevano più neanche il tempo per mangiare. 32 Allora partirono con la barca verso un luogo deserto, in disparte.
33 Molti però li videro partire e capirono, e accorsero là a piedi da tutte le città e li precedettero.
34 Sbarcando, vide molta folla e si commosse ed ebbe compassione per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte
Gli apostoli erano stati inviati in missione (Mc 6,6-13, Lettura 43), e al ritorno, raccontano a Gesù tutto quello che avevano fatto. Però Gesù li chiama ad un rapporto più profondo. Intende fare una riunione / sunàgontai in un luogo deserto in greco erèmo; ma lo stesso termine greco per indicare questa riunione suona come "sinagoga". Abbiamo già avuto modo dire che dopo le varie controversie avvenute in sinagoga e da ultima il suo respingimento dalla sinagoga di Nazareth, Gesù non entrerà più in una sinagoga.
Qui sembra di capire che il luogo dell'incontro sia proprio il deserto, cioè un luogo di silenzio dove il discepolo può mettersi a tu per tu con il suo Maestro.
È in questa situazione "privata" che gli apostoli; tornati dalla missione, possono confrontarsi tra ciò che Lui ha fatto e insegnato e ciò che loro stessi hanno fatto e insegnato.
Avevamo già incontrato nella sezione sulle parabole un rapporto particolare tra Gesù e discepoli, "tra quelli fuori e quelli in casa":
Mc 4,10 «Quando poi fu solo, i suoi insieme ai Dodici lo interrogavano sulle parabole. Ed egli disse loro: 11 «A voi è stato confidato il mistero del regno di Dio; a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole. [...] 34 Senza parabole non parlava loro; ma in privato, ai suoi discepoli, spiegava ogni cosa».
Così nel nostro brano quel rapporto di insegnamento si approfondisce.
Però la ricerca di solitudine è un fallimento perché la folla intuisce dove la barca andrà ad approdare e per via di terra li precede.
Abbiamo voluto aggiungere il v 34 per indicare che il distacco dalla gente non è dettata da disprezzo, ma piuttosto dalla necessità di trovare o ri-trovare il senso del proprio essere, del proprio insegnare e servire.
L'essere umano deve sempre ricordare che non rapportarsi con un tu senza essere anche in rapporto con il suo sé. Se questa legge elementare non viene rispettata è inevitabile la dispersione.
In questo brevissimo brano troviamo un'altra traversata del mare. Siamo simbolicamente di fronte ad un nuovo Esodo, perché sull'altra sponda, nel deserto, si ripeterà il prodigio della manna.
Inoltre questo brano fa da cuscinetto tra le vicende precedenti e l'inizio della sezione dei pani. Infatti in quel "luogo deserto" avverrà la prima moltiplicazione dei pani.
Ma già questa lettura e ancor più le successive richiederanno una riflessione su due piani: quello storico che coinvolge direttamente i primi discepoli di Gesù e quello della chiesa di Marco.
I primi pensano di avere a che fare semplicemente con del pane, i discepoli di Marco sanno di avere a che fare con il Pane.
Se è così anche noi ci siamo dentro fino al collo!
Lettura 46 La prima moltiplicazione dei pani. Mc 6,34- 44
Mc 6,34 «Sbarcando, [Gesù] vide molta folla e si commosse /esplagchnisthē per loro, perché erano come pecore senza pastore, (Nm 27,17; Ez 34,5; 1Re 22,17) e si mise a insegnare loro molte cose. 35 Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: «Questo luogo è solitario ed è ormai tardi; 36 congedali / apòluson perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, possano comprarsi da mangiare». 37 Ma egli rispose: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andar noi a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». 38 Ma egli replicò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E accertatisi, riferirono: «Cinque pani e due pesci». 39 Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull'erba verde. 40 E sedettero tutti a gruppi e gruppetti di cento e di cinquanta. 41 Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero; e divise i due pesci fra tutti. 42 Tutti mangiarono e si sfamarono, 43 e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. 44 Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini».
Se perdiamo di vista ciò che precede la moltiplicazione dei pani rischiamo di essere colpiti dal prodigio, ma perderemmo il senso del testo, per cui dobbiamo approfondire il significato del v 34.
Anzitutto è difficile rendere in italiano il termine greco esplagchnisthē che esprime la commozione di Gesù. Esso è un vocabolo che rimanda alle viscere, potremmo parlare di amore viscerale, che però è ancora molto arido. Bisognerebbe pensare ad un tipo di emozione che provoca un tuffo al cuore o un movimento dello stomaco o un emozione che ti fa venire il magone, ma in tutto questo, il linguaggio rimane comunque molto piatto.
Ecco, Gesù prova questo esplagchnisthē perché vede questa folla che ha fatto un sacco di strada a piedi per... Già, per che cosa? Bisogni di salute, bisogni di speranza, bisogni di pace, bisogno di cibo, bisogni di senso, bisogni... bisogni...
Il testo esprime questi bisogni con tre riferimenti intertestamentari. Marco non può citare il numero dei versetti coinvolti perché la numerazione dei testi è opera medievale, ma per lui è talmente importante che riporta la citazione integralmente: «erano come pecore senza pastore».
Allora possiamo dire che tutti quei bisogni sono riassunti nelle parole: «pecore senza pastore».
Quella gente che conosceva a memoria la Scrittura sa subito a cosa la citazione si riferisce, ma noi che non usiamo più la memoria dobbiamo riprendere i testi.
1- Mosè, il profeta, che obbedendo a JHWH ha potuto liberare gli ebrei dalla schiavitù d'Egitto, prossimo a lasciare questo mondo, deve trovare un nuovo capo che guidi Israele nella Terra Promessa per cui si rivolge al Signore con queste parole:
Nm 27,15 «Mosè disse a JHWH: 16 « JHWH, Dio della vita in ogni essere vivente, metta a capo di questa comunità un uomo 17 che li preceda nell'uscire e nel tornare, li faccia uscire e li faccia tornare, perché la comunità di JHWH non sia un gregge senza pastore». 18 Il Signore disse a Mosè: «Prenditi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo spirito; porrai la mano su di lui...»
Giosuè sarà il condottiero che porterà il popolo ad occupare la Terra che Dio gli aveva destinato a Israele. Sotto la sua guida il popolo ha camminato per lunghi anni fino a quando le varie tribù hanno potuto stabilirsi ciascuna nella terra assegnatale.
2- Intorno al 850 a. C. re Acab, che governa il Regno del Nord, vuole fare la guerra al re di Siria e i suoi dignitari trovano una schiera di profeti prezzolati che profetizzano il successo della spedizione. Però a scanso di equivoci vogliono che intervenga anche un santo profeta, Michea, il quale ispirato da Dio vaticina una sconfitta disastrosa, che potrà essere evitata se se non si farà la guerra e l'esercito congedato.
Il profeta sarà messo in prigione, la guerra sarà dichiarata, l'esercito di Israele sarà sconfitto, Acab sarà ucciso e il popolo si troverà senza guida, «pecore senza pastore», appunto. ( Consigliamo di leggere tutto il capitolo)
1 Re 22,17 «[il profeta Michea] disse al re: / «Vedo tutti gli Israeliti / vagare sui monti / come pecore senza pastore. Il Signore dice: Non hanno padroni; ognuno torni a casa in pace».
3- La situazione del popolo trecento anni dopo, al tempo del profeta Ezechiele è ben diversa e il testo la esprime molto bene con immagini simboliche molto forti (e attuali). Di lì a poco Gerusalemme cadrà per mano dei babilonesi e tutta la classe dirigente: Re, ministri, sacerdoti, dignitari, studiosi, ecc. viene deportata a Babilonia:
Ez 34:1 «Mi fu rivolta questa parola del Signore: 2 «Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori d'Israele, predici e riferisci ai pastori: Dice JHWH Dio: Guai ai pastori d'Israele, che pascono se stessi! I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? 3 Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. 4 Non avete reso la forza alle pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. 5 Per colpa del pastore si sono disperse e son preda di tutte le bestie selvatiche: sono sbandate. 6 Vanno errando tutte le mie pecore in tutto il paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura».
Forse Marco ci vuole suggerire che ai tempi di Gesù la situazione non era molto diversa se pensiamo alla struttura politica della regione dove imperava Roma, con diversi intermediari locali e magistrati romani tutti animati da uno stesso principio: arricchirsi a più non posso.
In questo contesto Gesù è presentato come il "Pastore escatologico", il pastore definitivo, ultimo e in questo brano troviamo una immediata applicazione. Che tuttavia i discepoli non hanno compreso.
Ce lo suggerisce il verbo "apòluson" tradotto con "congedali", ma una traduzione più attenta dovrebbe usare dei significati più forti, dispregiativi, qualcosa come "mandali via"; gli esperti suggeriscono che il verbo era usato anche per indicare lo scioglimento di matrimonio.
Se è così l'intervento dei discepoli non riguarda il bisogno della folla rimasta senza cibo, ma piuttosto il desiderio di stare "loro", un po' tranquilli. Però il parere di Gesù va in altra direzione perché lui è il Pastore, appunto.
Anche il v38 segna una contrapposizione al Maestro perché troviamo che le bisacce dei discepoli non erano vuote, ma contenevano cinque e due pesci, in aperta contraddizione a quanto detto in 6,8 dove si diceva che non dovevano neanche avere con sé delle bisacce.
I verbi impiegati in questa moltiplicazione saranno usati anche durante l'Ultima Cena, quando sarà istituita la Frazione del Pane che diventerà Segno del Suo riconoscimento e anticipazione del sacrificio della croce.
Così i discepoli si trovano a dovere "servire" tutta questa gente spezzando e distribuendo loro stessi pane e pesci.
E poi a raccogliere gli avanzi: "dodici ceste piene".
Dodici è un numero simbolico che rimanda al popolo, dodici erano le tribù, quasi a dire che gli avanzi sono sufficienti a nutrire un altro popolo; ma già qui erano stati sfamati 5000 uomini, più le donne e i bambini. Un successo strepitoso!
Però noi, armati dal nostro razionalismo potremmo sempre dire: "ma c'era proprio bisogno di quei cinque pani... già che ha fatto trenta poteva fare anche trentuno".
La critica è opportuna perché ci permette di dire che Dio non salva l'uomo senza l'uomo.
Anche il nostro niente appare molto prezioso ai Suoi occhi.
* Lettura 47 Non avevano compreso il fatto dei pani Mc 6,45-56
Mc 6,45 «E subito costrinse i suoi discepoli a montare nella barca e precederlo all'altra riva, verso Betsàida, mentre egli avrebbe licenziato / apolùei la folla. 46 Appena li ebbe salutati / apotaxamenos (Cei congedati), salì sul monte a pregare. 47 Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli solo a terra. 48 Vedendoli tormentati nel remare, poiché il vento era loro contrario, verso la quarta veglia della notte (dalle tre alle sei del mattino) andò verso di loro camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. 49 Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: «È un fantasma», e gridarono forte, 50 perché tutti lo avevano visto ed erano rimasti turbati. Ma egli subito rivolse loro la parola e disse: «Coraggio, sono io, non temete!». 51 Quindi salì con loro nella barca e il vento cessò. Ed erano grandemente fuori di sé, 52 perché non avevano compreso il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito.
53 Compiuta la traversata, approdarono e presero terra a Genèsaret. 54 Appena scesi dalla barca, la gente lo riconobbe, 55 e accorrendo da tutta quella regione cominciarono a portargli sui lettucci quelli che stavano male, dovunque udivano che si trovasse. 56 E dovunque entrava, in villaggi o città o borgate, ponevano gli infermi nelle piazze e lo pregavano di potergli toccare almeno la frangia del mantello; e quanti lo toccavano guarivano /esōzonto /salvati».
Diversi commenti a questi passi evangelici sovrappongono la moltiplicazione dei pani con il tema dell'Eucaristia. La cosa non è del tutto impertinente, ma se si deve comprendere il comportamento dei discepoli lì, sul lago, non si possono chiamare in causa eventi che non erano ancora accaduti.
Il punto cruciale è il v 52 «perché non avevano compreso il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito» che sintetizza icasticamente la separazione e l'incomprensione tra Gesù e i discepoli. (Ricordiamo che per gli ebrei il cuore è la sede dei pensieri e delle intenzioni, non delle emozioni).
Allora dobbiamo cercare di approfondire la situazione psicologica di Gesù e quella dei discepoli.
Costoro, dopo la prodigiosa moltiplicazione dei pani che aveva sfamato cinquemila uomini senza contare le donne e i bambini, erano sicuri come l'oro che il "loro" Maestro era il Messia atteso e con qualche altro miracolo di questo tipo, avrebbe sicuramente messo insieme tanta gente da far fuori tutti gli oppositori, cacciare i romani e ripristinare il Regno di Davide... e loro ne sarebbero stati i ministri! E dovevano sentirsi molto orgogliosi per il ruolo che sarebbe stato loro assegnato. Qualcosa del genere appare nel Vangelo di Luca, quando dopo l'invio in missione di settantadue discepoli, essi tornano da Gesù e gli raccontano cosa avevano fatto.
Lc 10, 17 «I settantadue tornarono pieni di gioia dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». 18 Egli disse: «Io vedevo satana cadere dal cielo come la folgore. 19 Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico; nulla vi potrà danneggiare. 20 Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli».
Questo breve passaggio esclusivo di Luca dice chiaramente che i discepoli hanno da svolgere un servizio e i poteri che a loro sono stati dati sono esclusivamente finalizzati a quel servizio.
Proprio come nel brano visto nella lettura precedente, nel quale i discepoli sono chiamati a distribuire il pane, quindi a svolgere un servizio. La moltiplicazione non è opera loro per cui essi non hanno di che vantarsi.
Però c'è un'altro aspetto più sottile che allontana i discepoli dal Maestro. Gesù pensa i cosiddetti miracoli come gesti di liberazione dal male, qualunque male, fisico o spirituale. I discepoli li pensano come prodigi atti ad accreditare Gesù quale Messia. Per cui, quanto più il miracolo è strepitoso tanto più le folle e i capi del popolo saranno costretti ad accettarlo come capo o addirittura re.
Ma dobbiamo riprendere il filo del racconto.
Nella lettura 45 avevamo visto che i discepoli tornati dalla missione avrebbero voluto raccontare a Gesù come era andata e Gesù li invita il luogo deserto, lontano dalla folla. Si allontanano con la barca, ma la gente intuisce dove siano diretti e li precede a piedi.
Qui Gesù si rende conto che tutta questa gente «è come un gregge senza pastore» (6,34) e provando un sentimento di viscerale commozione inizia ad insegnare. Quindi possiamo dire che, secondo Gesù, ciò di cui la gente ha bisogno è anzitutto l'insegnamento. Il pane, pur se miracolosamente ottenuto, è in funzione dell'insegnamento. Sembra cioè di capire che per Gesù la proclamazione della Parola stia al primo posto.
Il successo conseguente alla moltiplicazione dei pani è problematico perché rischia di dirigere l'attenzione degli uditori verso obiettivi politici, economici, mettendo in secondo piano o trascurando quello religioso.
Questo è il motivo per cui Gesù costringe i discepoli ad allontanarsi e, concluso il suo discorso con la gente, si ritira in preghiera, da solo sul monte. È la seconda volta che questo accade dopo una faticosa giornata di insegnamento, proclamazione e guarigioni; la prima era in Mc 1,35.
Tra lui e i discepoli ora c'è una distanza orizzontale ma soprattutto di altitudine: il monte indica una vicinanza al cielo, cioè a Dio. I discepoli sono lontani, ma è solo una distanza fisica quella cui il testo descrive?
Allora Gesù deve ricuperare i suoi e lo fa con una teofania. Non dimentichiamo che la sezione è intitolata: "L'identità di Gesù".
La scena sul lago contiene diversi elementi tipici delle teofanie: i fenomeni atmosferici: il lago in burrasca, il vento contrario, l'impossibilità dei discepoli di venirne fuori, la paura che li paralizza.
Da parte di Gesù: andare verso i discepoli, camminare sulle acque, placare il mare e il vento, rassicurare i suoi.
La Sua presenza ristabilisce una certa sicurezza, ma la separazione e confusione in un certo senso rimangono « perché non avevano compreso il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito».
I discepoli dovranno fare ancora molta strada a molta fatica prima di capire chi sia in realtà il loro Maestro e questi dovrà accettare di morire crocifisso e risuscitare il terzo giorno.
Per questo dopo affermeranno il kerygma: «Morto per i nostri peccati».
Ovvero: morto per la nostra durezza di cuore.
* Lettura 48 Coraggio. Egò eimì / Io sono Mc 6,45-56
Mc 6,45 «E subito costrinse i suoi discepoli a montare nella barca e precederlo all'altra riva, verso Betsàida, mentre egli avrebbe licenziato / apolùei la folla. 46 Appena li ebbe salutati / apotaxamenos (Cei congedati), salì sul monte a pregare. 47 Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli solo a terra. 48 Vedendoli tormentati nel remare, poiché il vento era loro contrario, verso la quarta veglia della notte (dalle tre alle sei del mattino) andò verso di loro camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. 49 Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: «È un fantasma», e gridarono forte, 50 perché tutti lo avevano visto ed erano rimasti turbati. Ma egli subito rivolse loro la parola e disse: «Coraggio, Io sono / Egò eimì, non temete!». 51 Quindi salì con loro nella barca e il vento cessò. Ed erano grandemente fuori di sé, 52 perché non avevano compreso il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito.
53 Compiuta la traversata, approdarono e presero terra a Genèsaret. 54 Appena scesi dalla barca, la gente lo riconobbe, 55 e accorrendo da tutta quella regione cominciarono a portargli sui lettucci quelli che stavano male, dovunque udivano che si trovasse. 56 E dovunque entrava, in villaggi o città o borgate, ponevano gli infermi nelle piazze e lo pregavano di potergli toccare almeno la frangia del mantello; e quanti lo toccavano erano salvati /esōzonto (Cei: guarivano)».
Non dobbiamo perdere di vista che il titolo di questa sezione è "L'identità di Gesù" oppure: "Chi è Gesù".
Ora, la camminata sulle acque in tempesta, il forte vento contrario che durante tutta la notte ha impedito ai discepoli di attraversare il mare e la calma piatta, seguente alla salita a bordo di Gesù, costituiscono un racconto rivelativo perché solo Dio può fare quelle cose.
Inoltre questi eventi sono illuminati dalle "sconcertanti" parole di Gesù che al v 50 dice: «Coraggio, IO SONO... » che in greco è: "Egò eimì", cioè il modo con cui la Bibbia LXX traduce il significato del nome di Dio: "JHWH". Di questo abbiamo trattato approfonditamente nelle letture 16 e 17 del libro di Esodo.
Dobbiamo anche segnalare che questa dichiarazione "IO SONO /egò eimì", è largamente usata nel Vangelo di Giovanni, appunto, con intento rivelativo .
E il versetto successivo dicendo: «Ed erano grandemente fuori di sé» lascia in dubbio se ciò dipendesse dalla cessazione dei fenomeni atmosferici o dalla rivelazione di quel nome o di entrambi. Certo è che fino a quel momento pur avendogli pedalato dietro già da un bel po', non avevano ancora capito chi fosse il loro Maestro.
Ad ogni modo la barca approda in una località diversa da quella prevista: non Betsaida, ma Genèsaret; e più avanti ne dovremo elaborarne il senso.
Comunque, ancora una volta, la ricerca di un luogo solitario per stare a tu per tu con il Maestro, iniziata già in Mc 6,30 al ritorno della missione, fallisce perché, sceso a terra, Gesù è subito riconosciuto dalla folla che arriva da tutte le parti.
E, ancora una volta, Gesù privilegia il rapporto di servizio alla gente a quello con i discepoli. Proprio perché lui è il "Pastore escatologico", che si è commosso di un amore viscerale a vedere questo popolo che è «come un gregge senza pastore» 6,34.
L'ultima parte è una sorta di sommario che chiude questa breve sottosezione, ma il versetto 56 dovrebbe fare riflettere perché in esso non si parla di guarigioni semplicemente, ma salvezza / esōzonto. Allora saremmo di fronte ancora alla figura della "fede che salva" di cui abbiamo trattato nell'episodio dell'emorroissa alla lettura 38.
La salvezza implica un di più rispetto alla semplice guarigione: uno può guarire, ma non essere salvato.
La salvezza, secondo i vangeli esprime l'essere venuti alla fede.
Il che significa che Gesù non è riconosciuto come un semplice medico, ma come "IO SONO"...
* Lettura 49 Impurità legale - Il loro cuore è lontano da me Mc 7,1-13.
Mc 7:1 «E si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. 2 Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli mangiavano i pani con mani impure, cioè non lavate -- 3 i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al polso, osservando la tradizione degli antichi, 4 e tornando dalla piazza non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e ci son molte altre cose che hanno ricevuto per tradizione da osservare, come lavature di bicchieri, stoviglie e vasi di rame -- 5 quei farisei e scribi gli domandano: «Perché i tuoi discepoli non camminano secondo la tradizione degli antichi, ma mangiano il pane con mani impure?». 6 Ma egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto:
Questo popolo mi onora con le labbra,/ ma il suo cuore è lontano da me.
7 Invano essi mi rendono culto,/ insegnando dottrine che sono precetti di uomini (Is 29,13).
8 Voi lasciando da parte il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».
9 E diceva loro: «Voi respingete abilmente il comandamento di Dio, per osservare la tradizione degli uomini. 10 Mosè infatti disse: Onora tuo padre e tua madre, (Es 20,12; Dt 5,16) e: chi maledice il padre e la madre sia messo a morte (Es 21,17; Lv 20,9). 11 Voi invece dite: Se un uomo dichiara al padre o alla madre: è Korbàn, cioè offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me, 12 non gli permettete più di fare nulla per il padre e la madre, 13 annullando così la parola di Dio con la vostra tradizione che vi siete tramandata. E di cose simili ne fate molte».
I versetti 3-5 sono una spiegazione parentetica inserita probabilmente da Marco per la sua comunità, verosimilmente di Roma, che poco conosceva di costumi ebraici e passiamo agli altri.
È ovvio che prima di metterci a tavola ci laviamo le mani perché questa è un norma igienica ormai consolidata, ma la sua introduzione nella nostra cultura, ha fatto una grande fatica per essere adottata e oltretutto risale ad un epoca molto recente; le prime avvisaglie si trovano nel '800.
Il nostro testo allora non ci pone di fronte a norme igieniche, ma cultuali dato che non si tratta di rimuovere sporcizia e tanto meno virus e batteri, che a quei tempi erano del tutto sconosciuti, ma di togliere l'impurità che persone oppure oggetti impuri avrebbero potuto trasmettere.
Abbiamo già incontrato questa tematica: impura o immonda non è una persona sporca, ma ad esempio uno che ha perdite di sangue, una donna durante il mestruo, uno straniero, un idolatra, un lebbroso, un peccatore, ecc. Quindi quando uno va al mercato e viene a contato con molte persone può essersi contaminato anche senza saperlo, da cui il dovere di purificarsi appena entrato in casa.
Troviamo sette volte la radice di "tradizione" e ciò indica che il tema è particolarmente importante. Infatti il testo pone una distinzione radicale tra il comandamento di Dio e la tradizione "vostra" o "degli antichi".
Rileviamo anche che il comandamento di Dio è al singolare, mentre la "vostra tradizione" è ovviamente composta da una pluralità di comandamenti.
I rabbini del tempo sostenevano che anche le tradizioni orali fossero state ricevute da Mosè, trasmesse a Giosuè e poi agli anziani per cui esse avevano lo stesso valore della Torah.
Ma noi sappiamo, perché l'abbiamo visto commentando il libro di Esodo (vedi archivio), che all'inizio c'erano solo tradizioni orali che solo in epoca davidica, intorno al 1000 a. C., si incomincio a mettere in forma scritta.
Se è così, si capisce come sia facile aggiungere norme a norme, prescrizioni a prescrizioni fino a rendere la vita impossibile. All'epoca di Gesù questi comandamenti erano diventati 613.
Un'idea della pignoleria con cui questi comandamenti erano applicati, ci viene dal film "Kadosh", nel quale c'è una sequenza in cui due ebrei osservanti di oggi, mentre preparano il tè, discutono se sollevare e intingere la bustina nella teiera trasgredisca il comandamento del riposo festivo.
La moltiplicazione delle norme e la loro osservanza ossessiva, sono la conseguenza dell'orgoglio religioso, il tentativo di autogiustificazione, l'idea di una salvezza assicurata dal comportamento puntiglioso. È ancora la convinzione di salvarsi da sé, facendo a meno di Dio. Al contrario tutta la Scrittura continua a ribadire la figura di una salvezza conseguente al fidarsi di Dio, perché solo Lui, attraverso la sua incondizionata dedizione può salvare.
Il libro di Esodo ci ricorda che la Legge non è condizione della salvezza, ma solo risposta alla salvezza già assicurata. È il Dio Liberatore che diventa Legislatore, non il contrario.
Al Sinai prima viene stipulata l'Alleanza e soltanto dopo vengono consegnate le Dieci Parole.
In altre parole se uno non si affida a Dio, cioè non ha fede, non può trovare salvezza.
Tutto questo è ben sintetizzato dalla citazione di Isaia: «...il loro cuore è lontano da me», oltre che dall'esempio riportato dal v 9 in poi, che non a caso, si riferisce il quarto comandamento del Decalogo.
Cerchiamo di spiegarlo brevemente. Supponiamo che un uomo, in una situazione di pericolo, faccia il voto di donare periodicamente una certa somma per il culto e si trovasse successivamente in ristrettezze economiche. Ora, secondo "la vostra tradizione" sarebbe dispensato dal mantenimento dei genitori invecchiati. In questo modo il voto avrebbe valore superiore al comandamento, ma Gesù condanna questa interpretazione.
Che il problema in questione è quello della ricerca di autosalvezza, lo rileviamo anche dal fatto che la diatriba non è una semplice discussione sulla purità, in quanto la domanda degli scribi e dei farisei intende sottilmente contestare l'autorità di Gesù. Infatti se i suoi discepoli non si comportano secondo la tradizione, cioè la dottrina corrente, la responsabilità ricade sul loro Maestro che pertanto non può pretendere di insegnare in Israele. Quindi Gesù non è maestro in Israele, non può essere il Messia.
Ancora una volta emerge il tema della sezione: ma allora Gesù chi è?
* Lettura 50 Problemi dietetici Mc 7,14-23.
Mc 7,14 E chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e intendete bene: 15 non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro; sono invece le cose che escono dall'uomo che rendono impuro l'uomo». 16 [Se qualcuno ha orecchi per ascoltare ascolti] 17 E quando fu entrato in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella parabola. 18 E disse loro: «Siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, 19 perché non gli entra nel suo cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna?». Dichiarava così puri tutti gli alimenti.
20 Quindi soggiunse: «Ciò che esce dall'uomo, quello sì rende impuro l'uomo. 21 Infatti dal di dentro, dal cuore degli uomini escono i pensieri malvagi: fornicazioni, furti, omicidi, 22 adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, diffamazione, superbia, stoltezza. 23 Tutte queste cose malvagie vengono fuori dal di dentro e rendono impuro l'uomo».
Nella lettura precedente Gesù pone una radicale differenza tra il comandamento di Dio, cioè la Legge e la "vostra tradizione".
In questo brano troviamo un'affermazione inaudita: Gesù mostra di avere un'autorità, un'exousia che gli permette di decidere anche a riguardo della Legge, annullando la distinzione tra cibi puri e cibi impuri.
Infatti le norme di purità legale sono raccolte nel libro del Levitico dal capitolo 11 al 15 e fanno parte di quel gruppo di libri che gli ebrei chiamano Torah, Legge, quindi libri che il Signore avrebbe dato a Mosè sul Sinai.
Dal punto di vista esegetico, non siamo in grado di dire quali libri o parti di essi siano di origine sinaitica e quanti siano successivi e letterariamente riportati al Sinai per evidenziarne l'importanza.
Così, in questi versetti dichiara puri tutti i cibi andando contro il Levitico.
In questo modo Gesù riporta la dieta alimentare alle origini che tuttavia la definiscono in due momenti.
Il primo quando ancora l'uomo è nel Giardino di Eden dopo che il Signore ha completato la creazione e rivolto ad Adamo ed Eva dice:
Gn 1,29 «Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo. 30 A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così avvenne».
Secondo questo comando l'uomo dovrebbe essere vegetariano perché gli animali sono esclusi dalla dieta.
Però dopo il Diluvio universale, quando Dio stabilisce con Noè una prima Alleanza, chiamata appunto "noachica", la quale ha come segno cosmico l'arcobaleno, la dieta viene allargata, perché Dio dice tra l'altro:
Gen 9:1 «Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. 2 Il timore e il terrore di voi sia in tutte le bestie selvatiche e in tutto il bestiame e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono messi in vostro potere. 3 Quanto si muove e ha vita vi servirà di cibo: vi do tutto questo, come già le verdi erbe. 4 Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il suo sangue».
Attenzione però che, se Gesù allarga il regime alimentare, non azzera il tema dell'impurità, ma ne cambia l'origine: non i cibi, ma il cuore dell'uomo, cioè le intenzioni, i pensieri diventano il possibile luogo di impurità.
Non a caso l'elenco dei vizi vv 21ss. inizia con i pensieri malvagi, perché l'inizio di ogni azioni si forma nella mente, diventa desiderio che poi si traduce in gesti. Sono quelle azioni che il catechismo chiama "vizi" il che indica che determinati comportamenti sono diventate abitudini. L'abitudine è di grande aiuto quando si tratta di un comportamento buono, perché uno non deve stare lì di volta in volta a decidere se fare o non fare quell'azione, ma essa viene realizzata senza neanche pensarci, che così quell'atteggiamento diventa virtù.
E questo forse ci aiuta a comprendere come i vizi siano difficile da eliminare.
In definitiva, se prima l'uomo doveva stare a guardare la dieta, adesso, con lo spostamento dell'oggetto dell'impurità, l'uomo deve tenere guardare il suo cuore.
I nostri vecchi parlavano di "esame di coscienza".
Appendice
Gesù e la Legge.
Poiché questo tema è alquanto complesso riportiamo un commento di Bruno Maggioni, Il racconto di Marco, Cittadella, p103.
A proposito del comportamento di Gesù nei riguardi della legge e della tradizione giudaica, l'indagine storica offre una triplice risposta.
Secondo alcuni Gesù sarebbe stato un conservatore che non aggiunse nulla di nuovo alla legge antico-testamentaria ma, anzi, richiamò alla sua osservanza, distinguendo però ciò che è fondamentale e ciò che è accessorio.
Per altri invece Gesù sarebbe stato un rivoluzionario, annunciatore di una nuova morale non più legata alla legge e alla tradizione giudaica.
Per altri infine, Gesù non sarebbe stato né un conservatore né un rivoluzionario, ma avrebbe assunto nei confronti della legge un comportamento critico: non la rifiutò in blocco ma neppure la accettò; intese portarla a compimento.
Tali divergenze nelle interpretazioni del comportamento di Gesù nei confronti della legge e della tradizione trovano il loro fondamento nella situazione stessa dei testi, alcuni dei quali sembrano indicare una osservanza scrupolosa della legge e altri sembrano indicare un suo superamento.
Il fatto è che questi testi, oltre che trovare una loro giustificazione nel comportamento di Gesù, risentono delle situazioni diverse delle comunità cristiane che li hanno ricordati e delle sensibilità dei singoli evangelisti.
* Lettura 51 La donna siro-fenicia converte Gesù Mc 7,24-30.
Mc 7,24 «Partito di là, andò nella regione di Tiro e di Sidone. Ed entrato in una casa, voleva che nessuno lo sapesse, ma non potè restare nascosto. 25 Subito una donna, che aveva la sua figlioletta posseduta da uno spirito immondo, avendo udito parlare di lui, venne e si gettò ai suoi piedi. 26 Ora, quella donna che lo pregava di scacciare il demonio dalla figlia era greca, di origine siro-fenicia. 27 Ed egli le disse: «Lascia prima che si sfamino i figli; non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». 28 Ma essa replicò: «Sì, Signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei bambini». 29Allora le disse: «Per questa tua parola va', il demonio è uscito da tua figlia».
30 Tornata a casa, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato».
Sembra una banalità, ma una religione non può essere universale se impone particolari regimi dietetici.
Infatti dopo avere dichiarato puri tutti i cibi troviamo Gesù dalle parti di Tiro e di Sidone sulla costa del Mediterraneo, in pieno territorio pagano, nell'attuale Libano. Quindi abbiamo a che fare con l'apertura della predicazione di Gesù ai pagani.
L'accostamento è probabilmente redazionale perché subito dopo troveremo Gesù nella Decapoli, che oggi potrebbe essere parte della Giordania. Impensabile che Gesù facesse tutta quella strada senza che lungo il percorso non accadesse alcunché. Questo non vuol dire, come sostiene qualche autore che usa il metodo storico critico, che Marco non conoscesse la geografia dell'antico Israele, piuttosto Marco è attento più alla struttura del testo che alla geografia.
Troviamo ancora un riferimento al pane e infatti siamo ancora nella "sezione dei pani".
È importante rilevare che Gesù è ancora alla ricerca di solitudine v24, ma viene cercato e trovato da questa donna. Questo ci dice che Gesù non va in giro a fare prodigi per accreditarsi come Messia, ma è sempre la gente che lo rincorre; e se fa delle guarigioni è esclusivamente per aiutare chi si trova nel bisogno.
La cosa più importante di questo brano è il brevissimo colloquio di Gesù con la donna straniera, e noi non esiteremmo a dire che la risposta di Gesù alla siro-fenicia sia offensivo. D'altra parte gli ebrei ritenevano che i gentili, fossero come cani. Il diminutivo "cagnolini" attenua in parte l'offesa, ma appunto solo in parte.
Però la donna tiene duro. L'affetto per la sua bambina le dà una forza che solo le madri conoscono.
In merito le esegesi si dividono in due gruppi, quelle che pensano che Gesù intendesse mettere la donna alla prova e quelle che ritengono che la donna abbia "convertito" Gesù ad aprirsi ai pagani.
Evidentemente il problema tocca in pieno la cristologia.
Se Gesù è Dio sa già come la vicenda andrà a finire e allora non avrebbe neanche bisogno di mettere alla prova la donna. Ma Gesù, come lo definisce il dogma di Calcedonia, è "vero uomo e vero Dio". Un Dio che ha accettato, in tutto il suo profondo significato, la kenosi, l'abbassamento, lo svuotamento, l'Incarnazione.
Allora Gesù è pienamente uomo che, come tutti gli esseri umani che vengono a contatto con Dio, deve vivere di fede. Gesù ha imparato sin da bambino ad affidarsi a Dio, a pregarlo e man mano scoprire la particolare relazione esistente con Lui. Certo Maria e Giuseppe gli hanno raccontato gli avvenimenti di Nazareth e poi di Betlemme.
Anche il Padre si è fatto sentire in forma alquanto diretta, come abbiamo visto nella lettura 9 a proposito del Battesimo di Gesù:
Mc 1,10 «E, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. 11 E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».
Se è così anche Gesù non nasce "imparato" (passi l'errore grammaticale), ma deve fare la fatica che fa ogni uomo per diventare uomo e capire chi è se stesso.
Gesù ha imparato a credere, ha imparato a fare la volontà del Padre, ha imparato a pregare; e lo ha imparato dai propri genitori, dagli amici, dai maestri rabbini, dalla tradizione del "suo" popolo; ha imparato il rispetto e l'osservanza della Torah, ha imparato e meditato i Profeti e la sapienza degli Scritti.
Ma ha anche imparato e coltivato gli affetti primari della sua famiglia, dei compagni di giochi, degli amici di studio e di lavoro; ne ha imparato gli affetti e i legami, ha imparato il turbinio dei sentimenti e delle emozioni.
Perché Gesù "di Nazareth" è stato innanzitutto Gesù "a Nazareth".
E "a Nazareth" non ci è stato un giorno, ma trent'anni!
Questo vuol dire andare a scuola dalla storia, non certo quella dei re e dei generali che fanno guerre e conquistano o perdono regni, ma la storia vera, quella di tutti gli uomini e di tutte le donne nati sotto il sole.
Perché l'identità di ogni uomo è la sua storia. Io sono l'insieme delle mie vicende, dei miei incontri, delle persone che ho conosciuto, che mi hanno amato e che io ho amato.
Sono questi incontri che ci fanno diventare uomini. Incontri con i genitori, con le maestre, i professori, i colleghi, con gli studi, e non ultimo le batoste.
Se è così, e Gesù è "vero uomo", come dice il dogma, anche quella sconosciuta siro-fenicia, vissuta 2000 anni fa ha aiutato Gesù a definire la Sua storia... e quella del cristianesimo.
Potremmo dire tutto questo anche in altro modo: Gesù scopre nelle parole di quella donna un messaggio del Padre.
* Lettura 52 Guarigione di un sordomuto o l'ascolto della Parola Mc 7,31- 37.
Mc 7,31 «E di nuovo, uscito dal territorio di Tiro, venne attraverso Sidone, verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. 32 E gli portano un sordo e muto, e lo supplicano di imporgli la mano. 33 E avendolo preso con sé lontano dalla folla, in disparte, mise le sue dita nei suoi orecchi e avendo sputato, gli toccò la lingua; 34 e levando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: «Effatà» cioè: «Apriti!». 35 E subitogli si aprirono i suoi orecchi, e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correntemente. 36 E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi lo proclamavano 37 e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bella ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!».
L'avvenimento accade in pieno territorio pagano e la guarigione riguarda un pagano.
In quanto sordo e pagano non ha mai sentito parlare di quello che Dio ha fatto per il suo popolo lungo la storia.
La guarigione è duplice. Gli esperti dicono che se un bambino non impara entro i primi due anni di vita ad emettere suoni, quindi ad articolare lingua e laringe, dopo non sarà più in grado di parlare. In un certo senso i sordi dalla nascita, sono condannati anche non poter parlare.
Nel nostro caso questo sordomuto, non solo acquista l'udito, ma anche la capacità di parlare correttamente.
A noi può fare schifo quel toccare la lingua del sordomuto con la saliva, ma si è sempre ritenuto che essa avesse la capacità di guarire le ferite, cosa confermata dalla chimica che riconosce alla saliva un certo potere antibatterico. Corretta quindi l'istruzione che ancora si dà ai bambini, quando si sbucciano un dito, in mancanza d'altro, di succhiarselo.
Il senso di questa guarigione appare nell'ultimo versetto, «Ha fatto bella ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!», perché si tratta della citazione di due testi dell'Antico Testamento. Questo non produce una semplice risonanza letteraria, ma richiama altresì la teologia dei brani dai quali le citazioni sono tratte, per cui dobbiamo brevemente esplorarle.
«Ha fatto bella/buona ogni cosa» rimanda al racconto della creazione in sei giorni di Genesi 1, quando Dio man mano che crea gli elementi cioè, dopo avere creato la luce (1,3), la terra con tutte le piante (1,12), le luci del firmamento, il sole e le stelle (1,18), gli animali marini e gli uccelli del cielo (1,21) infine tutti gli animali che popolano la terra e contemplando stupito via via ogni sua opera dice: «E vide che era cosa tov / bella / buona».
Alla fine, dopo avere creato l'uomo, ammirando la sua creazione complessivamente, ripete la stessa espressione con una variante: «Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto tov / bella / buona» Gn1,31.
Allora quella gente con questo rimando dice che Gesù viene da Dio perché come Dio fa delle cose belle / buone.
Però il richiamo della creazione dice anche che siamo di fronte ad una nuova creazione. Ma, allora Gesù chi è?
«Fa udire i sordi e fa parlare i muti». Questo brano rimanda alla "Piccola apocalisse" di Isaia, cioè ai cc 34-35. In realtà si tratta del secondo Isaia perché il testo risale all'esilio babilonese o poco dopo; siamo tra il 580 e il 500 a. C. Gerusalemme è distrutta, la classe dirigente è stata deportata; alla guerra condotta dai babilonesi hanno vigliaccamente partecipato alcuni dei regni confinanti con la Giudea, tra cui Edom.
Il capitolo 34 elenca con grande quantità di immagini e definizione di dettagli la vendetta che il Signore compirà nei confronti di questi popoli che si sono avventati contro il "suo" popolo.
Il capitolo 35 invece racconta ciò che il Signore sta per fare a Gerusalemme e al suo popolo: nel linguaggio apocalittico: la vendetta di Dio. È un testo di salvezza, molto ricco di immagini che indicano una trasformazione radicale della terra e degli uomini.
Nella liturgia ambrosiana è un brano letto durante l'Avvento per cui raccomandiamo di leggerlo.
Ad un certo punto troviamo il nostro collegamento:
Is 35,5 «Allora si apriranno gli occhi dei ciechi / e si schiuderanno gli orecchi dei sordi.
6 Allora lo zoppo salterà come un cervo / griderà di gioia la lingua del muto
perché scaturiranno acque nel deserto / scorreranno torrenti nella steppa».
In questo caso sono i pagani della Decapoli che riconoscono l'attuazione delle promesse proclamate da Isaia 500 anni prima, cioè Gesù sta compiendo la "vendetta di Dio"... e guarisce un pagano? Ma allora Gesù chi è?
Ricordiamo che siamo sempre nella sezione che ricerca l'identità di Gesù.
Nota bene: si può discutere all'infinito sulla traduzione di tov con bello o buono, ma quando noi ci troviamo di fronte a qualcosa che ci stupisce neanche ci sogniamo di dire: "che buono", ma esclamiamo sicuramente: che bello!
Dal punto di vista strutturale e simbolico Marco suggerisce, con questa guarigione, che c'è qualcuno altro che deve aprire i propri orecchi: "altri" della folla che gira intorno a Gesù? La sua comunità? Il lettore implicito?
Bisogna continuare ad interrogare il testo.
Marco ritiene tanto importante la parola pronunciata da Gesù durante questa guarigione da riportarla nella versione aramaica originale: "Effatà", seguita dalla traduzione in greco.
Ricordiamo che il battesimo dei bambini, nel rituale romano, termina appunto con il "rito dell'effatà" che riportiamo di seguito.
RITO DELL'« EFFETA »
121. Il celebrante tocca, con il pollice, le orecchie e le labbra del battezzato, dicendo:
Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, / ti conceda di ascoltare presto la sua parola,
e di professare la tua fede, / a lode e gloria di Dio Padre.
Non è che tutto questo voglia dire che solo Lui, il Cristo, è in grado di aprirci le orecchi per farci udire la sua parola?
* Lettura 53 Seconda moltiplicazione dei pani Mc 8,1 - 9.
Mc 8:1 «In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, chiamati a sé i discepoli e dice loro: 2 «Ho compassione / splagchnizomai di questa folla, perché già tre giorni si trattengono con me e non hanno da mangiare. 3 Se li licenzio digiuni, verso le loro case, verranno meno per via; e alcuni di loro vengono di lontano». 4 Gli risposero i discepoli: «E come si potrebbe sfamarli di pane qui, in un deserto?». 5 E domandò loro: «Quanti pani avete?». Gli dissero: «Sette». 6 Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi allora quei sette pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero; ed essi li distribuirono alla folla. 7 Avevano anche pochi pesciolini; dopo aver pronunziata la benedizione su di essi, disse di distribuire anche quelli. 8 Così essi mangiarono e furono sazi; e raccolsero i resti dei pezzi avanzati in sette sporte. 9 ora, erano circa quattromila. E li congedò.
10 Salì poi sulla barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di Dalmanùta».
Gli esegeti fanno un gran discutere per decidere se si tratta effettivamente di una seconda moltiplicazione dei pani, quella del c 6 e questa, o di due racconti differenti dell'unica moltiplicazione.
La cosa non ci interessa più di tanto, perché non seguiamo il metodo storico critico, cioè quel metodo che cerca di individuare i racconti, le tradizioni che hanno preceduto l'edizione finale, che ovviamente hanno il loro valore.
Noi però facciamo una lettura sincronica, cioè leggiamo il testo così come Marco lo ha composto senza cercare di individuare tradizioni e racconti precedenti. (Per saperne di più vedi note esegetiche 2-3-4 in "Glosse").
Infatti ammesso che Marco abbia fatto due racconti del medesimo accadimento, resta il fatto che le due moltiplicazioni hanno significati alquanto differenti; che noi dobbiamo cercare di evidenziare
Dobbiamo anzitutto rilevare come questa gente, per lo più pagana, sta seguendo Gesù da tre giorni, nel deserto, però non era una festa a base di polenta e salamini, con musica dal vivo tenuta da band di grido, ma gli andavano dietro per sentirlo parlare ed essere istruiti, in quanto Lui «... visceralmente commosso / splagchnizomai per loro (stesso verbo di 6,34), perché erano come pecore senza pastore, si era messo ad insegnare loro molte cose» Mc 6,34. Mentre nel capitolo 6, alla prima moltiplicazione dei pani, eravamo in territorio ebraico, adesso siamo nella Decapoli in cui gli uditori sono pagani o in grande maggioranza pagani.
Allora possiamo comprendere il numero dei sette pani e delle sette sporte di avanzi. Il numero sette è la radice di 70 che secondo la "Tavola dei popoli" di Gn 10,1-32 mostra la genealogia dei settanta popoli conosciuti, tutti discendenti da Noè e dai suoi figli.
Le sette sporte di avanzi possono suggerire una disponibilità di pane per altri popoli, ma non possiamo perdere di vista il richiamo alle "briciole" menzionate nell'episodio della donna siro-fenicia di Mc 7,24, lettura 51.
Tutto il dialogo si svolge tra Gesù e i discepoli mentre la folla, pur essendo in scena, resta muta sullo sfondo. Da questo dialogo sembra che i discepoli non hanno ancora elaborato il senso della prima moltiplicazione: l'avere sfamato 5000 uomini più le donne non suggerisce loro alcunché. La loro risposta è deludentemente terra, terra. Tuttavia, sempre disponibili al servizio; sono loro che distribuiscono alla gente il pane e i pesciolini. Essi sono gli intermediari tra il Maestro e la folla.
Il numero 4000, 4x1000, potrebbe significare i quattro punti cardinali, suggerendo così che questa folla veniva da ogni dove.
Se è così, ricordando che questa sezione è alla ricerca dell'identità di Gesù, possiamo pensare Gesù come "pastore universale".
* Lettura 54 Un segno dal cielo Mc 8,11 - 13.
Mc 8,11«E uscirono i farisei e incominciarono a discutere con lui, cercando di ottenere un segno dal cielo mettendolo alla prova 12 Ed egli gemendo nel suo spirito dice: «Perché questa generazione cerca un segno? Amen vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione».
13 E lasciatili, montato di nuovo in barca, se ne andò all'altra riva».
C'era stata una prima moltiplicazione dei pani che aveva sfamato 5000 persone, poi molte guarigioni a Genesaret, quindi la liberazione della figlia di una donna siro-fenicia, la guarigione di un sordomuto e infine la seconda moltiplicazione dei pani che aveva saziato 4000 persone digiune da tre giorni, ma tutti questi per i farisei non erano segni.
Perché un segno sia tale è necessario che esso avvenga come dico io. Sono io a priori che decido di che tipo debba essere l'evento perché io lo possa riconoscere come segno. Sicuramente deve essere qualcosa di indiscutibile, di terribile come un terremoto, un fulmine che durante un temporale carbonizzi almeno una decina di persone, la caduta di un meteorite che apra una voragine nel terreno, insomma uno di quei segni come da sempre un vero dio si è sempre manifestato. Proprio come hanno sempre fatto le divinità che abitavano l'Olimpo.
Ma proprio questi sono i segni che i Vangeli di Matteo e Luca chiamano: "Tentazioni messianiche"
Mt 4:3 «Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, di' che questi sassi diventino pane».
che si tratterebbe di usare la potenza di Dio per i propri comodi.
4,5 «Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio 6 e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo,
ed essi ti sorreggeranno con le loro mani,perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede».
che se poi si fra la ripresa TV in diretta trasmessa in Eurovisione e in Mondovisione te li trovi tutti ai tuoi piedi.
4,8 «Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: 9 «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai».
Che consisterebbe nell'instaurare un potere politico sul pianeta che faccia impallidire tutti gli imperi esistiti fino ad oggi.
Esattamente queste sono le tentazioni, le prove, alle quali Gesù, spinto dallo Spirito, è stato sottoposto da Satana nel deserto. È in quella situazione che Gesù, sempre sostenuto dallo Spirito, ha dovuto decidere il "suo" modo di essere Messia... ma più che suo, è il modo voluto dal Padre. Un modo che troverà l'esito finale nella Croce e nei successivi eventi pasquali.
Se è così, comprendiamo come tutti i cosiddetti miracoli, gli sono quasi sempre strappati dalle mani, perché dovevano evitare l'aspetto spettacolare e hanno sempre avuto come oggetto la liberazione di uomini e donne dal male.
Proprio l'opposto di quello che si sarebbero attesi questi farisei che avrebbero sicuramente riconosciuto il dito di Dio se, durante una discussione, Gesù avesse fatto stramazzare un paio di oppositori, se avesse fulminato Pilato o qualche soldato che lo flagellava e via dicendo. Tutti segni che le tradizioni religiose di ogni epoca e di ogni luogo hanno sempre riconosciuto come opere divine.
E invece no. Il Dio di Gesù non ha fatto nessun morto ammazzato, ma ha sempre e soltanto liberato uomini dal male: indemoniati, lebbrosi, ciechi, storpi e ha perfino risuscitato dei morti...
E questo è assolutamente imperdonabile! Bisogna proprio farlo fuori!
* Lettura 55 Mc 8,14 - 21 Guardarsi dal lievito dei farisei.
Il guaio è che la teologia dei farisei, vista nella lettura precedente, è completamente condivisa dai suoi discepoli. Anche loro come tutti i capi del popolo sono convinti che ad un bel momento, quando i tempi saranno maturi, instaurerà il suo dominio che sottometterà tutti i nemici e silenzierà tutti gli oppositori. Non sanno ancora come questo avverrà, ma hanno sperimentato che Gesù è profeta potente in parole ed opere e prima poi farà uno di quei miracoli che lascerà tutti a bocca aperta. L'unica differenza è che quelli sono contro Gesù mentre loro, i discepoli, che ormai lo seguono da un bel po', sono sicuri che ad un bel momento sbaraglierà tutti gli avversari.
In questo brano Gesù cerca di metterli in guardia.
Mc 8,13 «E lasciatili, risalì sulla barca e si avviò all'altra sponda.
14 Ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé nella barca che un solo pane. 15 Ed egli intimava loro dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!». 16 E quelli dicevano fra loro: «Non abbiamo pane». 17 Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non intendete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? 18 Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non ascoltate? (Ger 5,21; Ez 12,) E non vi ricordate, 19 quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici». 20 «E quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Sette». 21 E disse loro: «Non capite ancora?».
Questa è la terza scuola che avviene in barca, sul lago.
Nella prima 4,35, mentre Gesù dorme, si scatena una tempesta tanto che la barca è ormai piena d'acqua e i discepoli, provetti pescatori, hanno paura di morire. Gesù, dopo avere calmato la tempesta, li rimprovera: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?». E loro restano stupiti chiedendosi: «Ma chi è costui al quale il vento e il mare obbediscono»?
Nella seconda 6,45 dopo avere remato quasi tutta la notte controvento e senza riuscire a completare la traversata vengono raggiunti da Gesù che cammina sulle acque. E sono impauriti perché lo scambiano per un fantasma. Salito a bordo in breve guadagnano terra. Ancora una volta sono presi dallo stupore perché si chiedono ancora chi sia costui che cammina sulle acque, Lui che dice: "IO SONO" .
Adesso Gesù è con loro. Ormai sono insieme da diverso tempo. Hanno visto molti segni. Sono anche stati mandati in missione e hanno sperimentato di poter fare parecchi prodigi come il Maestro. Hanno appena servito alla distribuzione di sette pani per 4000 persone, hanno avanzato sette sporte piene di avanzi, ma sono preoccupati perché hanno con loro soltanto un pane.
E questo è un problema drammatico: hanno solo un pane e sono in tredici! E allora come si fa?
Ma quando li aveva inviati in missione non aveva detto loro di non portarsi né pane né bisaccia come abbiamo visto alla lettura 43?
Mc 6,8 «E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa».
Il nuovo insegnamento di Gesù si fonda su di un avvertimento: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!» seguito da sette domande.
Il lievito dei farisei consiste nel tentativo di raggiungere la salvezza attraverso l'osservanza meticolosamente applicata della Legge. La loro speranza è collegata all'arrivo del Messia che butti a mare i dominatori di Roma e ripristini l'antico Regno davidico.
Oppure il lievito dei farisei ha a che fare con il desiderio o la necessità, anche per questi discepoli, di avere segni ulteriori
Il lievito di Erode è la ricerca del successo ottenuto allargando il suo potere politico, sempre cercando di compiacere i dominatori romani, che di fatto sono i padroni. In definitiva lui è solo un servo del potere.
Non dimentichiamo che nei confronti di Gesù il lievito di questi personaggi aveva deciso, sin dall'inizio di ucciderlo Mc 3,6; Lettura 25.
Ora, insegnare attraverso delle domande è una forma molto intelligente perché costringe i discepoli a riflettere sulla loro esperienza per trovarne il senso.
La domanda più incisiva è la quarta del v 18, anche perché cita direttamente ben due profeti del Primo Testamento:
18 « Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non ascoltate»? (Ger 5,21; Ez 12,).
Allora ci sono delle orecchie sorde e degli occhi ciechi che devono essere aperti.
Marco è stato particolarmente attento nello strutturare il testo perché prima della seconda moltiplicazione dei pani aveva trattato la guarigione di un sordo e muto dalla nascita (Mc 7,31ss Lettura 53) e nell'episodio che seguirà dovremo riflettere sulla guarigione di un cieco.
Con questo forse ci vuole suggerire che solo Gesù è in grado di fare accogliere la sua parola.
Ma l'ultima domanda è sicuramente più lancinante perché resta senza risposta e ha direttamente a che fare con la capacità di cogliere negli accadimenti quotidiani dei segni: «Non capite ancora?».
Però, se usciamo dalla vicenda storica e pensiamo alla comunità di Marco, ci rendiamo conto che l'Unico Pane, è l'Eucaristia, cioè Gesù stesso, e allora queste domande non sono rivolte soltanto ai discepoli di Galilea o alle comunità di 2000 anni fa, ma anche al discepolo di ogni tempo, compreso quello del 2018.
Se è così ci siamo dentro tutti fino al collo!
* Lettura 56 Mc 8,22 - 26 Il cieco di Betsaida.
Mc 8,22 «Giunsero a Betsàida, dove gli condussero un cieco supplicandolo di toccarlo. 23 E presa la mano del cieco lo condusse fuori del villaggio; e, avendo sputato sui suoi occhi, avendogli imposto le mani, lo interrogava: «Vedi qualcosa?». 24 Quegli, alzando gli occhi, disse: «Scorgo gli uomini, poiché vedo come degli alberi che camminano». 25 Poi di nuovo gli impose le mani sugli occhi ed egli guardò fisso e fu guarito e eneblepsen / vedeva dentro (Cei: vedeva a distanza) ogni cosa distintamente. 26 E lo rimandò a casa sua dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio».
Il brano precedente era terminato con l'ultima delle sette domande poste da Gesù ai suoi discepoli, la più drammatica: 8,21 E disse loro: «Non capite ancora?». Non possiamo trascurare che tutta la serie di quelle domande, rimaste senza risposta, rivelano lo sconcerto di Gesù a riguardo dei suoi apostoli.
E proprio in questo clima di tensione, Marco inserisce il racconto della guarigione di cieco nel villaggio di Betsaida: "Casa della pesca", in aramaico.
Possiamo giustamente rimanere sorpresi dal fatto che sia l'unica volta in tutti i vangeli che la guarigione non riesca al primo colpo, ma richiede a Gesù due tentativi.
Il primo tentativo consiste nello sputare negli occhi al cieco e nell'imporgli le mani. Certo, se un medico ci trattasse in questo modo parleremmo subito di "malasanità", ma noi viviamo in un'altra epoca e in un'altra cultura. Per gli ebrei la saliva era aria concentrata e pertanto liquefatta. Se poi teniamo presente che l'ebraico non distingue "respiro" da "Spirito", allora possiamo dire che Gesù gli ha applicato sugli occhi un superdose di Spirito Santo.
Tuttavia l'operazione non riesce completamente, la visione non è chiara e distinta. Quegli alberi o uomini che si muovono stando al greco sembrano indicare piuttosto che sono gli occhi di quell'uomo incapaci di fissare lo sguardo su un determinato oggetto.
Il secondo tentativo di Gesù riesce perfettamente con la semplice imposizione delle mani. Adesso l'ex cieco è in grado non solo di vedere le cose e fissare lo sguardo, ma, come dice il verbo greco en-eblepsen / "dentro-guardo", cioè vedere dentro le cose.
Ora, "vedere distintamente" è la semplice soluzione di un problema oftalmico, ma "guardare dentro le cose" è molto di più. È la capacità di cogliere il senso delle cose e tutti i loro significati.
"Guardare dentro" significa rendersi conto che Gesù l'ha guarito chiamandolo in disparte, a tu per tu, lontano dalla folla, perché non ha voluto usare la sua guarigione come argomento di propaganda. Tanto più che gli ha poi detto: "vai a casa senza passare dal paese". Infatti la propaganda, come la pubblicità resta in superficie, non va a scrutare dentro le cose.
"Vedere dentro" vuol dire che adesso lui potrà tornare dai suoi senza essere più un peso morto e andare a pesca nel mare insieme agli altri.
"Vedere dentro", significa intuire improvvisamente che adesso potrà mettere su famiglia, avere una moglie, visto che le donne sono così deliziose e avere anche dei figli. "
"Vedere dentro" vuol dire appunto rendersi conto che le cose non sono semplici oggetti, ma annunciano sempre un disegno, una rete di relazioni, delle intenzioni, le quali a occhio nudo non si possono assolutamente riconoscere.
In questo modo comprendiamo il disegno di Marco. Questo cieco è la figura di contrasto che accusa i discepoli che sono incapaci di "guardare dentro le cose" che sicuramente hanno visto, ma non hanno compreso.
Se loro avessero avuto la capacita di "guardare dentro le cose" fatte da Gesù, esse sarebbero diventate segni.
Ma purtroppo, loro che sono stati dietro a Gesù fin dall'inizio, non hanno ancora capito.
Però anche noi abbiamo un problema perché i vangeli non sono stati scritti per quei discepoli, invece sono loro che li hanno scritti per noi.
Allora...?
* Lettura 57 Mc 8,27 - 30 La confessione di Pietro.
Mc 8,27 «Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo; e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: «Chi dicono gli uomini che io sia?». 28 Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti». 29 Ma egli replicò: «E voi chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo».
30 E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno».
La sezione si era aperta con un brano in cui la gente ed in particolare Erode si chiedevano: "Chi è Gesù"?
Mc 6,14 «Il re Erode sentì parlare di Gesù, poiché intanto il suo nome era diventato famoso. Si diceva: «Giovanni il Battista è risuscitato dai morti e per questo il potere dei miracoli opera in lui». 15 Altri invece dicevano: «È Elia»; altri dicevano ancora: «È un profeta, come uno dei profeti». 16 Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risuscitato!».
Ora, la sezione si chiude con lo stesso interrogativo, prima attraverso una sorta di sondaggio d'opinione, poi con una domanda diretta ed ineludibile ai discepoli. Non è difficile rilevare un certo imbarazzo da parte loro, perché dei dodici solo uno risponde. E gli altri undici non avevano nulla da dire?
Ricordiamo che poco prima della guarigione del cieco di Betsaida, erano state rivolto loro da Gesù ben sette domande a riguardo della molteplicità dei segni di cui erano stati testimoni e che essi non avevano capito:
Mc 8,21 E disse loro: «Non capite ancora?» ma adesso, improvvisante, Pietro esce fuori con quella frase lapidaria: «Tu sei il Cristo».
Forse era preso dall'entusiasmo, forse ammirava Gesù, forse...
Forse ci può aiutare Matteo che nello stesso passaggio prosegue dicendo:
Mt 16,17 E Gesù: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli».
Cioè, stando alla spiegazione di Matteo la confessione di Pietro sarebbe frutto di una rivelazione da parte del Padre. Una professione di fede in piena regola, che mostra la fede come dono di Dio.
Se è così anche in altri luoghi abbiamo avuto la percezione di una fede già presente negli interlocutori di Gesù, in tutti quei casi in cui si mostra la figura della "fede che salva". Il paralitico calato dal tetto scoperchiato di Mc 2,1-12 lettura 20; l'emorroissa di Mc 5,21-34, lettura 38; la donna siro-fenicia di Mc 7,24-30, lettura 51.
Però nel nostro brano non accade che Gesù dica a Pietro: "la tua fede ti ha salvato", come ha detto agli altri, ma esprime una semplice beatitudine secondo Matteo, il silenzio in Marco e Luca.
Possiamo dare anche una seconda spiegazione. Quando questi testi vengono redatti Pietro era un personaggio importante nella comunità cristiana e gli era riconosciuta autorevolezza nel dirimere problemi e controversie esistenti nelle varie chiese. È un tema che appare a più riprese nel libro di Atti e nelle Lettere di Paolo, in cui lo stesso Paolo dice che più volte si è recato a Gerusalemme per chiarire le sue intuizioni con "le colonne della Chiesa", cioè Pietro, Giacomo e Giovanni.
Ora, le lettere di Paolo sono redatte almeno vent'anni prima del Vangelo di Marco. Quindi potremmo dire che già dai primissimi tempi a Pietro era riconosciuta questa primazialità.
Se è così allora possiamo ritenere che nel nostro testo Pietro possa essere una sorta di portavoce dei dodici.
Certo, dovremmo anche chiederci cosa intesse l'affermazione: "Tu sei il Cristo" che non è il cognome di Gesù, ma il termine greco per dire "Unto" corrispondente all'ebraico "Messia".
Essere il Messia significa, nella cultura epocale, essere portatore di tutte le attese nutrite dal popolo di Israele. E il problema si complica perché i vari gruppi presenti in quella società avevano attese differenti gli uni dagli altri, per cui il Messia poteva essere un nuovo Mosè che avrebbe riportato la religione al rigore degli inizi, oppure un liberatore politico che avrebbe ripristinato il regno di Davide, oppure un semplice capo guerriero che avrebbe cacciato i romani e così via. Potremmo dire: tanti idee e attese, anche le più disparate, quanti erano i gruppi sociali presenti in Israele.
Cosa pensasse effettivamente Pietro il testo non lo dice, ma la prosecuzione della lettura di Marco ci mostrerà subito che le sue idee non sono quelle di Gesù, anzi sono molto divergenti.
L'imperativo presente nell'ultimo versetto del nostro brano, di non parlare di Lui con nessuno, mette già in evidenza che Gesù sa già che l'idea di Messia nutrita dai suoi discepoli è falsa e come tale non deve essere divulgata.
Con questo brano termina la terza sezione e la prima parte del Vangelo di Marco.
Nella Lettura 6che trattava la struttura del Vangelo di Marco, abbiamo detto che avremmo potuto intitolare questa prima parte: "Chi è Gesù?" oppure "La ricerca dell'identità di Gesù" oppure espresso in modo affermativo: "Gesù è il Messia".
La confessione di Pietro è l'approdo di questa ricerca: "Gesù è il Messia".
* Lettura 58 Mc 1,14 - 8,30 Ripresa sintetica della prima parte.
Finora abbiamo esaminato il racconto di Marco in forma puntuale, analitica, ora cerchiamo di farne una lettura sintetica per cercare di fare emergere alcuni collegamenti e punti fondamentali che possono essere sfuggiti.
La prima parte del racconto di Marco si svolge tutta in Galilea o comunque attorno al Mare di Galilea, con una sola puntata a Tiro e Sidone.
I SEZIONE Mc 1,14 - 3,6 Un insegnamento nuovo.
Mc 1,14 «Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio...»
La Galilea segna l'inizio della proclamazione del Regno e sarà anche il luogo di partenza della predicazione da parte dei discepoli dopo la Risurrezione. Infatti troviamo subito molte citazioni:
v 14 "Dopo l'incarcerazione, la consegna di Giovanni il Battista, Gesù venne in Galilea...".
v 16 "Gesù passando presso il mare di Galilea...". Alla fine del primo esorcismo di Cafarnao:
v 28 "la sua fama si diffuse subito dappertutto, in tutta la regione della Galilea...".
v 39 " e venne annunciando nelle loro sinagoghe in tutta la Galilea...".
Quindi la Galilea segna buona parte di questa sezione, più avanti anche quando non menzionata, sono richiamati luoghi che si trovano in Galilea.
All'inizio il centro dell'attività è Cafarnao, sulla riva del mare. Possiamo dire che Marco ha pensato il primo momento dell'impegno di Gesù chiuso geograficamente dentro l'ambito della Galilea.
Però per Marco essa diventa anche un simbolo teologico perché il termine Galilea è strettamente associato a due altri termini che sono fondamentali: il termine kērussō, proclamazione, predicazione, annuncio e il termine Vangelo: lieta notizia, buona novella.
La Galilea perciò è il luogo della proclamazione del Vangelo e luogo simbolico della missione del regno e diventerà luogo simbolico della ripresa dopo gli eventi pasquali. In 16,7 quando l'angelo annuncia alle donne "andate a dire ai suoi discepoli che Egli li precederà in Galilea e là lo vedranno". Perciò la Galilea diventa luogo dell'incontro con il Risorto e quindi è il luogo in cui ri-comincerà la missione della proclamazione ecclesiale.
Questo ci consente di dire che i luoghi geografici hanno per Marco valenza teologica per cui bisognerebbe essere attenti a ciò che accade in ciascuno di essi.
Possiamo aggiungere un altro elemento: non solo la Galilea è il luogo della proclamazione del Vangelo, ma anche il luogo dell'inizio del discepolato 1,16-20 e sarà alla fine il luogo dove di nuovo incomincerà il discepolato e incomincerà la missione ecclesiale.
Già questo ci dice che il Vangelo di Marco dovrebbe essere letto in modo circolare: l'inizio e la conclusione in Galilea come luogo della proclamazione del Vangelo, della prima sequela, della ripresa della sequela dopo la Pasqua e della missione ecclesiale che ricomincia.
Allora proviamo a vedere come è composta materialmente questa sezione e poi cerchiamo di ricavarne il senso che Marco attribuisce al proclamare il Vangelo in Galilea.
Dopo le due pericopi fondamentali sommario/chiamata dei discepoli, abbiamo
- un esorcismo a Cafarnao 1,21-28;
- la guarigione della suocera di Pietro 1,29-31;
- poi un sommario delle guarigioni di Gesù a Cafarnao.
In pratica abbiamo un giornata tipica del ministero di Gesù a Cafarnao.
Osserviamo come Marco sviluppa la narrazione: presenta un esorcismo, una guarigione e poi offre un sommario per dire che questo non era un caso isolato, ma che Gesù esercitava in modo ampio l'azione di esorcista e di guaritore.
La giornata a Cafarnao è il paradigma del ministero di Gesù in Galilea.
Subito dopo c'è 1,35-39, un cambiamento e un ampliamento del ministero di Gesù: Gesù si ritira, i discepoli lo trovano e gli dicono "tutta la gente ti cerca" e Gesù dice "non torniamo a Cafarnao, andiamo altrove affinché io anche là proclami / kērussō ".
Allora Gesù inizia a proclamare, ma il testo non esprime il contenuto di questa proclamazione fatta soprattutto di gesti nella giornata di Cafarnao, e poi annuncia che ciò che ha annunciato qui deve essere annunciato altrove. E infatti "e venne proclamando nelle loro sinagoghe per tutta la Galilea" in definitiva, Gesù entra in Galilea e proclama.
Abbiamo visto così, un paradigma della proclamazione di Gesù a Cafarnao, poi un momento di distacco da Cafarnao, la domanda dei discepoli, la risposta di Gesù "occorre che io vada nelle altre città affinché anche là io proclami" di nuovo: kērussō, e poi l'ultimo v39 mostra che Gesù va in tutta la Galilea proclamando.
Ciò che sta in mezzo è il paradigma di che cosa significa proclamare il Vangelo.
Dopo questa estensione del ministero di proclamazione del Vangelo in tutta la Galilea, abbiamo esaminato il brano cuscinetto non localizzato e non inquadrato temporalmente: la guarigione del lebbroso 1,40-45.
Se osserviamo la finale di questo brano porta l'annotazione che. questo lebbroso una volta guarito, se ne va anche lui proclamando/ kērussō: "... e uscito cominciò a proclamare...".
Così si comprende bene l'importanza di questo brano cuscinetto di passaggio senza inquadratura né temporale né geografica. Ciò che finora è stato caratteristico di Gesù, quello di proclamare, ora diventa caratteristica di uno che ha sperimentato la salvezza di Gesù. Marco ha di questi espedienti che sono molto interessanti e tante volte non vengono notati, cioè alla proclamazione di Gesù segue qualcuno che, salvato da Gesù, a sua volta proclama.
Sono le figure dei criptomissionari cristiani,cioè figure che nascostamente anticipano quello che faranno i credenti dopo la Pasqua: continueranno la proclamazione / kērussō dopo aver sperimentato la salvezza.
La stessa cosa accadrà con l'indemoniato di Gerasa: anche lui alla fine non seguirà Gesù, ma andrà a proclamare, l'abbiamo chiamato il tredicesimo apostolo per di più in terra pagana 5,1-20, lettura 37.
Ecco, quindi, in un certo senso la proclamazione di Gesù indica che la proclamazione verrà continuata da qualche altro che ha sperimentato la sua salvezza.
Poi segue 2,1-3,6 che sono cinque dispute in blocco:
- La disputa per il perdono concesso al paralitico, 2,1-12, lettura 20.
- La chiamata di Levi e la disputa perché Gesù mangia con pubblicani e peccatori 2,13-17, lettura 21.
- La disputa sul digiuno 2,18-22, lettura 22 e 23.
- La disputa per le spighe strappate di sabato 2,23-28, lettura 24.
- la disputa per la guarigione dell'uomo dalla mano secca 3,1-6, lettura 25.
che si conclude poi in 3,6 col proposito di mettere a morte Gesù. Naturalmente qui ci accorgiamo che siamo su un altro versante, qui è la proclamazione mostrata in positivo del Vangelo da parte di Gesù, qui il Vangelo di Gesù crea conflitto e in mezzo quel brano cuscinetto del lebbroso guarito. Possiamo ulteriormente suddividere la sezione in modo più articolato:
1,14-20 sommario dei discepoli
1,21-34 la giornata a Cafarnao
1,35-39 l'allargamento a tutta la Galilea
1,40-45 cuscinetto del lebbroso e poi la sezione delle dispute
Allora qui abbiamo visto che i termini tipici sono Galilea e kērussō / proclamazione del Vangelo.
Ma cosa significa questo proclamare il Vangelo per Marco?
Se guardiamo alla prima sezione ci accorgiamo che questa proclamazione non avviene in parole, ma in gesti, si dice che proclamava, ma non ci viene detta neanche una parola circa il contenuto.
Però troviamo altri due, termini chiave uniti al verbo insegnare:
«Che è mai questo? Una dottrina nuova,insegnata con autorità / exousia » 1,27
Quindi la proclamazione del Vangelo di Gesù è un insegnamento che avviene non in parole, ma in gesti potenti che manifestano la novità e l'autorità che viene menzionata due volte; in 1,22 e 1,27.
Allora i due termini chiave che esplicitano ulteriormente l'insegnamento del Vangelo in gesti sono: novità e autorità. Potremmo dire che Gesù proclama il Vangelo insegnando in gesti esorcistici e terapeutici manifestando così il suo potere come proveniente da Dio e mostrando la radicale novità escatologica di questa proclamazione del Vangelo.
Questi due termini chiave ritornano nelle dispute, le quali sono distribuite, dal punto di vista della struttura in forma concentrica, a chiasmo: A - Al - C- B - B1.
Ci sono due dispute che hanno come tema il perdono dei peccatori:
A- Gesù perdona il paralitico e
A1 - Gesù va a mensa con i peccatori. E vi sono due dispute che riguardano il sabato:
B - i discepoli mangiano le spighe in giorno di sabato e
B1 - Gesù guarisce un uomo in giorno di sabato.
Al centro rimaneC che è la disputa sul digiuno che così risulta essere la più importante.
Sia nelle dispute sul sabato sia in quelle sul perdono dei peccatori ricorre il termine "Figlio dell'Uomo" e sono le uniche due volte in cui questo termine ricorre nella prima parte del Vangelo e precisamente in 2,10 e 2, 28.
"il Figlio dell'Uomo ha il potere ... di rimettere i peccati"
"il Figlio dell'Uomo è Signore del sabato".
I termini Kyrios ed exousia sono abbastanza vicini. Quindi le dispute manifestano che quel potere che Gesù sta manifestando nella proclamazione del Vangelo è messo sotto contestazione dai suoi nemici.
Nella disputa centrale sul digiuno è messo in risalto il detto di Gesù con il ripetersi più volte del termine "nuovo": un tempo definitivo, un tempo opportuno: kairòs.
I termini che ricorrono nella disputa centrale sono "vecchio" e "nuovo" che si contrappongono.
Ecco come viene spiegato il fatto che quell'autorità manifestata da Gesù, proclamando il Vangelo, viene contestata, perché egli porta una novità radicale che è incompatibile, con la vecchia mentalità del giudaismo. La sua novità è di tipo escatologico, è un "nuovo" qualitativo e quindi è la sua novità che viene messa sotto processo nelle dispute. Poiché la novità e legata alla venuta dello Sposo e al banchetto messianico, è Gesù stesso in quanto sposo che porta la novità e che porta e rende manifesta l'autorità di Dio per cui i suoi nemici decidono di metterlo a morte.
In definitiva due sono i termini chiave: kērussō e Vangelo che si esplicitano in un insegnamento, in particolare nella giornata di Cafarnao, che è fatto con autorità / exousia e che manifesta la radicale, novità escatologica.
Nelle dispute questa proclamazione fatta con novità ed autorità, è messa in questione dai suoi avversari fino alla decisione di metterlo a morte.
Mettendo insieme questi termini chiave si ha la sintesi di ciò che Marco vuole dire nella prima sezione.
II SEZIONE Mc 3,7 - 6,6 Istruzione dei discepoli
Inizia con il sommario di 3,7-12 che indica una svolta nel ministero di Gesù: "Gesù intanto si ritirò presso il mare con i suoi di scesoli", il testo greco usa angoreō che significa certamente prendere una distanza spaziale ma soprattutto morale. Poiché il ministero in Galilea si è chiuso con il proposito omicida degli scribi, dei farisei e degli erodiani, la seconda sezione comincia con l'annotazione di Gesù che assieme ai suoi discepoli si ritira materialmente e moralmente dalla Galilea e stabilisce come nuovo luogo geografico il mare.
È interessante l'annotazione del v.7b e 8 dove si dice: "...e molta folla dalla Galilea lo seguì / akoloutheō. Dalla Giudea e da Gerusalemme e dell'Idumea e dalla Transgiordania e dalle parti di Tiro e Sidone una gran folla avendo udito ciò che faceva venne da lui".
Così il nuovo uditorio di Gesù, che si è ritirato presso il mare, è costituito da due parti: una folla che viene dalla Galilea "che lo seguì akoloutheō", che è il verbo tipico della sequela, in conseguenza dell'annuncio del Vangelo fatto in Galilea; poi un'altra gran folla che, avendo udito, viene a lui da tutta la Palestina e dai territori pagani.
Cambiamento di scena e di uditorio: i destinatari non sono più esclusivamente i galilei, ma una folla composta da galilei che hanno accolto il messaggio, da giudei e pagani.
Poi c'è un sommario sull'attività taumaturgica di Gesù in 3,10; "infatti ne aveva guariti molti, così che quanti avevano qualche male gli si gettavano addosso per toccarlo".
Segue la chiamata ufficiale dei dodici, l'istituzione degli Apostoli, con due caratteristiche:
la scelta libera di Gesù: "chiamò a sé quelli che egli volle" e la finalità della chiamata: "perché fossero con lui e per mandarli /apostellō a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni".
All'interno di questa sezione che termina in 6,1 possiamo trovare questi elementi caratteristici.
All'inizio il sommario e il brano che riguarda i discepoli da 3,7-19.
Anzitutto la nuova localizzazione, il mare che per alcuni esegeti sarebbe il luogo privilegiato della formazione dei discepoli. Quindi se la Galilea è il luogo della proclamazione del Vangelo, il mare diventa il luogo della formazione dei discepoli e quindi della comunità.
Si potrebbe dire: dalla proclamazione universale del "Regno che viene", alla edificazione della comunità in questa seconda sezione.
Allora, il mare come luogo di formazione della comunità che è indicata da Marco con tre espressioni differenti:
i dodici, i discepoli e quelli intorno a Gesù, che però nella sostanza si equivalgono e stanno ad indicare e a simboleggiare la comunità cristiana.
In 3,20-35abbiamo tre pericopi significative. I parenti di Gesù cercano di andarlo a prendere perché lo credono fuori sé 3,20-21.
Questo atteggiamento dei parenti di Gesù viene congiunto in 3,22-30 con l'atteggiamento degli scribi e dei farisei i quali accusano Gesù di cacciare i demoni in nome di Beelzebul.
In 31-35 la madre e i suoi fratelli stanno fuori dall'insieme della folla e questo viene comunicato a Gesù; allora ecco la prima espressione significativa al versetto 34 "E girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno disse: Ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio costui è mio fratello, sorella e madre".
Ecco quindi le connessioni di questo primo blocco.
I parenti lo credono pazzo, gli scribi e i farisei lo accusano di scacciare i demoni in nome di Beelzebul; questi non sono dei suoi. È chiaro che costoro non fanno parte di quelli intorno a Gesù; non accolgono e non comprendono il suo ministero, ma lo rifiutano.
Viceversa ecco chi è la nuova famiglia a cui Gesù si dedica: quelli che sono intorno a lui e che compiono la volontà di Dio. Questa é la famiglia, la comunità che egli comincia a costruire.
Quindi questa prima parte serve a distinguere due gruppi: i parenti, gli scribi e i farisei che rifiutano il ministero di Gesù e quelli intorno a lui che invece compiono la volontà di Dio; e questi sono suo fratello, sua sorella e sua madre. Questa è la nuova famiglia di cui fanno parte quei dodici che sono appena stati chiamati.
Nella seconda parte di questa sezione c'è un grosso nucleo che è il cosiddetto insegnamento sul mistero del Regno in parabole che comprende la parabola del seminatore, la sua spiegazione e alcuni detti: sulla lucerna, sull'ascoltare, la parabola della semente che cresce da sola e infine quella del granello di senape. Quindi il grosso complesso dell'insegnamento in parabole.
In questo grosso complesso emerge di nuovo quella distinzione che era stata fatta all'inizio di questa sezione quelli fuori e quelli dentro, quelli intorno e quelli distanti.
In 4,10-12 troviamo la teoria di Marco sulle parabole.
Prima c'è la chiamata dei dodici, poi si parla di quelli che erano intorno a lui. Adesso quelli che sono intorno a lui insieme coi dodici gli chiedono spiegazione della parabola del seminatore. Ed egli disse loro: «A voi è stato confidato il mistero del regno di Dio a quelli di fuori tutto avviene in parabole perché guardino ma non vedano, ascoltino ma... ».
Quindi Gesù stesso distingue due gruppi: i dodici con quelli che sono intorno a lui ai quali è dato, è offerto il mistero del Regno e quelli invece che sono paragonabili agli scribi, ai farisei, ai parenti che non accolgono il suo ministero
e sono quelli per i quali tutto avviene in parabole circa il mistero del Regno. A quelli cui è confidato il mistero del Regno, Gesù dà una ulteriore istruzione sul significato delle parabole.
Gli altri invece, ponendosi fuori, rifiutando Gesù, non hanno la possibilità di una ulteriore istruzione catechetica.
Dopo il mistero del Regno in parabole seguono tre grandi narrazioni di miracoli:
- la tempesta sedata
- l'indemoniato geraseno
- e la risurrezione della figlia di Giairo in cui è inclusa anche l'emorroissa 4,35 - 5,43.
La tempesta sedata è una epifania, una anticipazione di Gesù risorto. I miracoli sull'acqua come il camminare sulle acque, in Marco, sono narrazioni che richiamano la Pasqua, il Risorto.
Gesù si manifesta ai discepoli sul mare come colui che ha la potenza di vincere il mare come simbolo delle potenze malefiche e che lo vincerà definitivamente quando risorgerà. C'è la presenza del verbo "si svegliò" che rimanda alla risurrezione. Quindi Gesù ha istruito i suoi discepoli sui misteri del Regno e poi manifesta se stesso ai suoi discepoli; mostra la sua potenza che si manifesterà in pienezza nella resurrezione.
Quindi questo primo miracolo è una ulteriore manifestazione ai suoi, i quali ancora non capiscono, solo pongono la domanda: "Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?"
Potremmo dire che la tempesta sedata è legata al mistero del Regno in parabole; questo mistero del Regno è Gesù stesso che si svelerà in pienezza quando si sveglierà risorto e calmerà le acque, cioè vincerà definitivamente la potenza del male.
Di solito questo episodio è unito al ciclo dei miracoli, ma è più centrato congiungerlo al tema dei discepoli istruiti da Gesù sul Mistero del Regno e quindi destinatari dell'epifania di Gesù sul mare. Proprio questa manifestazione di Gesù nei confronti dei fenomeni atmosferici istruisce i suoi e nello stesso tempo pone la domanda: "Ma chi è costui"? che sarà il tema della terza sezione
In 5,1-20 è descritto il secondo miracolo e ci troviamo in terra pagana: la guarigione del Geraseno il quale, una volta guarito, fa anche lui la domanda di diventare discepolo "...lo pregava di permettergli di stare con lui".
Che è la stessa espressione usata per la chiamata dei dodici: "perché stessero con lui".
Poiché il Geraseno è un pagano e il tempo dei pagani non è ancora giunto, Gesù non accetta che stia con lui ma lo manda dai suoi ad annunciare ciò che il Signore ha fatto per lui.
E la finale è: "egli se ne andò e si mise a proclamare kērussō, per la Decapoli", e sarà il tredicesimo apostolo, un cripto-discepolo
Quindi Gesù chiama i dodici, distingue la sua famiglia da quelli che non sono la sua famiglia, istruisce i suoi perché ad essi è confidato il mistero del Regno, mentre quelli fuori non potranno comprendere; si manifesta ai suoi durante la tempesta, raccoglie un discepolo in terra pagana, un cripto-discepolo perché non può stare con lui, però può andare a predicare tra i suoi, a proclamare, e perciò anticipa la missione dei discepoli.
Infine la resurrezione della figlia di Giairo a cui assistono Pietro, Giacomo, Giovanni, i testimoni sempre presenti nei momenti cruciali: nel Getsemani, sul monte della Trasfigurazione, ecc...
Di nuovo Gesù svela se stesso in un cerchia ristretta. Quindi è un progressivo svelarsi di Gesù per educare la sua comunità la quale è distinta dal gruppo che ha rifiutato Gesù, che rimane fuori e quindi non potrà né vedere, né comprendere, né convertirsi.
Se all'inizio c'erano i parenti di Gesù, in chiusura ci sono i compaesani di Gesù, i nazaretani che, mostrandosi increduli nei suoi confronti, non vedranno che pochi segni.
In definitiva tutta questa sezione è imperniata, da una parte attorno agli avversari di Gesù e agli increduli, dall'altra attorno ai suoi che vengono istruiti e ai quali Gesù si manifesta, anche se essi faticano a capire.
Se è così possiamo dire che i discepoli chiamati nel corso della prima sezione, lasciate subito le reti, lo avevano seguito con entusiasmo, in questa sezione pur avendo una istruzione dedicata e puntuale, cominciano a fare fatica e non sempre riescono a capire: un movimento che si aggrava nella terza sezione.
III SEZIONE Mc 6,6b - 8,30 Chi è Gesù
Inizia con il sommario di Mc 6,6b dove si dice: "Gesù andava attorno per i villaggi insegnando" quindi il simbolo è il ministero itinerante di Gesù.
Dapprima era la Galilea, poi la localizzazione diventa il mare, adesso è il ministero itinerante, andare per i villaggi. Subito dopo questo andare di Gesù, in Mc 6,7-13 si presenta l'invio in missione dei discepoli che è l'esecuzione di quello scopo per cui Gesù li aveva chiamati: "e cominciò a mandarli a due a due e diede loro il potere sugli spiriti immondi", che era lo scopo iniziale già enunciato in 3,14-15.
Dopo questi che sono i due elementi caratteristici di inizio sezione: il sommario su Gesù e la missione dei dodici, abbiamo una prima introduzione che è costituita dai vv.14-29 la citazione di Erode e il martirio di Giovanni, inserzione che apparentemente sembra disturbare e che invece è molto significativa.
Così si parla di Erode e della sua opinione su Gesù, 6,14-16 "Erode diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risuscitato / egeire". Sente cioè parlare di Gesù e lo associa a Giovanni Battista risuscitato. Altri invece dicono che è Elia, altri che è un profeta. Quindi la sezione dopo l'introduzione incomincia con l'interrogativo su Gesù: chi è questo Gesù? che è appunto il tema della III sezione.
Questi versetti formano inclusione con la confessione di Pietro a cui Gesù chiede: "Chi dice la gente che io sia?" e si ripeteranno queste stesse risposte.
Cioè, nei vv.14-16 viene introdotto il tema della identità di Gesù che poi verrà ripreso alla fine in "chi dice la gente che io sia e chi dite voi che io sia?". Perciò questi primi versetti danno il tono a tutta la sezione.
Allora i tema di questa sezione sarà chi è Gesù. E i discepoli alla fine dovranno dire chi è Gesù, il quale si rivelerà in modo tale che i suoi discepoli potranno dire chi veramente egli è.
Riproponendo allora il tema dell'identità di Gesù attraverso l'aggancio con l'opinione di Erode che ritiene che Gesù è quel Giovanni Battista che egli ha fatto decapitare, l'evangelista aggancia la narrazione del martirio del Battista fino al versetto 6,29.
Allora il tema dovrebbe essere: i discepoli chiamati a scoprire Gesù attraverso le manifestazioni che egli dà di sé.
Così, abbiamo visto due grandi manifestazioni di Gesù che costituiscono il tema chiave di questa sezione chiamata anche "sezione dei pani" perché caratterizzata da due moltiplicazioni dei pani.
In 6,30 ci si riaggancia al tema della missione. Si narra il ritorno dalla missione dei discepoli i quali raccontano quello che hanno fatto e Gesù li chiama in disparte; ma mentre sono in disparte accorrono le folle ed ecco la prima moltiplicazione dei pani. Questo episodio costituisce un l'introduzione sulla identità di Gesù.
La prima moltiplicazione dei pani dovrebbe avere svelato Gesù come pastore escatologico che raccoglie attraverso il dono del pane il gregge che è disperso: "ebbe compassione perché erano come pecore senza pastore".
Alla fine viene indicato che ne avanzarono dodici ceste, probabilmente dodici è il simbolo delle tribù d'Israele da cui si raccoglie i primo nucleo del popolo di Dio.
Alla prima moltiplicazione dei pani segue Gesù che cammina sulle acque vv 46-52.
Anche qui è Gesù che si manifesta e capiamo che la valenza è post-risurrezionale perché Giovanni farà camminare Gesù sulle acque dopo la Pasqua. Sarebbe allora il Gesù risorto che si manifesta ai discepoli i quali non capiscono e hanno paura "perché non avevano capito il segno dei pani".
Il termine pane ricorre quattordici volte in questa sezione, ed è un termine chiave che lega tutto. Quindi Gesù si rivela come Pastore escatologico che raccoglie il nuovo popolo di Dio con il dono del pane; si manifesta come risorto ai suoi discepoli i quali hanno paura perché non hanno capito il segno dei pani, segno questo, che dovrebbe rivelare loro la vera identità di Gesù. Aumenta così l'incomprensione dei discepoli verso Gesù.
Dopo il camminare sulle acque c'è un breve sommario vv 53-56 di guarigioni compiute da Gesù.
In 7,1-23 vi è la disputa sulle tradizioni degli antichi, circa il puro e l'impuro.
Attraverso questa disputa e la raccomandazione di superare la distinzione tra puro e impuro, Gesù chiede che venga superata la barriera tra giudei e pagani e il primo effetto di questo superamento è il miracolo della siro-fenicia nei vv 24-30, la quale chiede che "i cagnolini possano avere le briciole del pane che cadono dalla mensa"; e Gesù premia la sua fede. In altre parole è una donna pagana che chiede di poter partecipare in qualche modo al banchetto.
In 31-37 abbiamo la guarigione del sordomuto.
Questa guarigione era legata alla guarigione del cieco di Betsaida alla fine di questa sezione.
Sono due miracoli simbolici, almeno nella loro collocazione. Poiché i discepoli non hanno orecchi per ascoltare e comprendere il senso del pane donato, Gesù simbolicamente guarisce questo sordomuto come segno della necessità di aprire l'udito.
Qui si chiude la prima sezione dei pani: prima moltiplicazione dei pani e successiva manifestazione di Gesù sulle acque. I discepoli hanno paura e non capiscono perché hanno ancora il cuore duro.
Poi Gesù chiede loro che si superi la divisione puro-impuro ed accoglie la siro-fenicia accettando la sua richiesta delle briciole; quindi un'apertura degli orecchi perché occorre aprire l'udito, gli occhi e il cuore per capire questi segni.
In 8,1-21 la seconda moltiplicazione dei pani di cui in 8,1-10 si ha un breve dialogo che dovrebbe definitivamente aprire l'udito, gli occhi e il cuore dei discepoli per capire chi è Gesù.
La collocazione di questa seconda moltiplicazione, poiché è fatta in territorio pagano e alla fine si parla delle sette sporte e non più delle dodici ceste, nella Genesi il numero 70 è riferito alle popolazioni pagane, probabilmente simboleggia la raccolta dei popoli pagani nel popolo di Dio attraverso il dono del pane.
In 8,11-13 ci sono i farisei per i quali i segni dei pani non contano nulla e vogliono un segno dal cielo per stabilire chi è Gesù. La sezione si chiude con la pericope della incomprensione dei discepoli 14-21 dove c'è il più grave rimprovero che Gesù rivolge ai suoi discepoli. All'inizio del v.14 ritorna il tema del pane: i discepoli avevano portato solo un pane per il tragitto sulla barca ed erano preoccupati perché come si fa a dividere un pane in tredici?.
Allora Gesù li rimprovera: "guardatevi dal lievito dei farisei" cioè non mettetevi sulle stesse posizioni degli scribi e dei farisei, i quali hanno appena chiesto un segno dal cielo, piuttosto cercate di capire i segni dei pani.
I verbi che emergono sono: non comprendono, hanno il cuore indurito, non vedono, non ascoltano e tutto questo perché non hanno capito il segno dei pani. Questi verbi sono sparsi all'interno della sezione.
Tutti i sensi: udito, vista, intelligenza, cuore dovrebbero essere messi, in moto e i discepoli invece non hanno l'udito, non hanno vista, hanno il cuore duro, non hanno comprensione.
È interessante notare come a questo punto i discepoli sono diventati come quelli di fuori che guardano, ma non vedono, che ascoltano ma non intendono. Prima erano quelli intorno a Gesù e pian piano hanno mostrato la loro incomprensione fino al punto che sembrano essere vicini agli scribi e ai farisei e a coloro che sono fuori.
È il momento più drammatico di tutta la prima parte.
A questo punto c'è la guarigione simbolica del cieco di Betsaida, brano che è proprio solo a Marco.
Questa guarigione è un miracolo simbolico perché da una parte si lega al rimprovero precedente secondo cui i discepoli non hanno occhi per vedere: ora Gesù dona la vista per vedere.
E si lega alla pericope seguente quella della confessione di Pietro.
Osservando bene il brano, Gesù guarisce il cieco secondo questa scaletta:
Un primo intervento sul cieco e la domanda: che cosa vedi. Vedo gli uomini come alberi che camminano, cioè una vista molto approssimativa, insicura.
Un secondo intervento di Gesù e il cieco vede tutto chiaramente e Gesù che ordina di non dire nulla di quello che gli è stato fatto.
Quindi tre momenti: il primo e secondo intervento e il comando del silenzio.
La stessa struttura la presenta la "confessione di Pietro":
= Un primo intervento con: "chi dice la gente che io sia" e una vista approssimativa: sei Elia, un profeta, ecc.
= Un secondo intervento più preciso di Gesù con il "chi dite voi che io sia" e la vista chiara: tu sei Cristo
= E ordinò loro di non dire niente a nessuno, come il terzo elemento.
Quindi il brando del cieco di Betsaida fa da cuscinetto perché richiama la "non vista" dei discepoli che Gesù guarisce e rimanda alla confessione di fede di Pietro per via del parallelismo delle strutture.
Allora in questa terza sezione abbiamo Gesù che si manifesta nel giorno del pane, cioè lo svelarsi di Gesù che raccoglie il nuovo popolo di Dio attraverso il dono del pane, più chiaramente nella seconda moltiplicazione che nella prima, sono in riferimento all'Eucaristia perché la terminologia è quella della istituzione dell'Eucaristia.
È proprio qui che si accentua l'interesse di Gesù ed è proprio qui che invece si accentua l'incomprensione dei
discepoli che porta a quel rimprovero molto duro da parte di Gesù.
Ma nonostante queste difficoltà il dono della fede permette di professare chi è Gesù: "Egli è il Cristo".
Sezione 2.1 Insegnamento sul Messia sofferente Mc 8,31-10,52
* Lettura 59 Mc 8,31- 8,33 Prima predizione della passione e opposizione di Pietro
Mc 8,31 «E cominciò ad insegnare loro«Il Figlio dell'Uomo deve / dei patire molte cose ed essere riprovato dagli anziani, dai gran sacerdoti e dagli scribi ed essere ucciso e dopo tre giorni risorgere». 32 E annunziava la Parola apertamente. E Pietro presolo in disparte cominciò a rimproverarlo.
33 Ma egli voltatosi indietro e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: «Va' via dietro me Satana! Perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma di quelle degli uomini».
Il brano precedente, Lettura 57, aveva trattato la confessione entusiasta di Pietro: "Tu sei il Messia / Cristo / Unto", che costituiva anche l'approdo della prima parte del Vangelo di Marco: "L'identità di Gesù".
In questo modo sembravano superate tutte le incomprensioni emerse nel corso della terza sezione della prima parte.
Adesso Gesù ritiene che i suoi discepoli siano in grado di comprendere il suo modo di essere Messia. In verità qualche dubbio doveva essergli rimasto perché aveva raccomandato ai suoi di non dirlo a nessuno, che è il tema del "Segreto messianico".
Infatti, appena accenna a rivelare loro il "suo" cammino, cioè la Parola / Logon, proprio Pietro si mette a rimproverarlo.
Ma come? Il Messia che dovrebbe sgominare tutti gli oppositori, già prevede che sarà ucciso e, scandalosamente, non accolto dai capi del popolo, ma condannato proprio da loro. Un Messia così non serve a nulla.
D'altra Pietro era stato un tranquillo pescatore che viveva con la famiglia in riva al mare di Galilea, poi un giorno passa Gesù: "Vieni e seguimi". E lui pianta lì, reti, barca, moglie, figli e suocera e si mette a seguire Gesù. E adesso il maestro, "profeta potente in parole ed opere", comincia ad esitare, proprio dopo i successi ottenuti a seguito delle moltiplicazioni dei pani e tutti gli altri prodigi. E allora bisogna proprio intervenire per cercare di tirarlo su perché è andato in crisi.
È una ragionamento molto razionale e molto umano quello che fa muovere Pietro.
La difficoltà di Pietro è la stessa che vive la prima comunità cristiana... Ma anche quella di oggi non ha di che vantarsi!
Il fatto che i racconti della Passione costituiscano la parte più corposa, dettagliata e insistente dei Vangeli, dice proprio che questo era il punto più difficile da accettare. Nessun essere umano, sano di mente, potrebbe pensare di salvare qualcosa attraverso la sua propria eliminazione fisica.
Ma Marco ci mette sull'avviso perché chiama queste predizioni di Gesù: "Parola / Logon", cioè l'essenza della sua predicazione e della sua stessa esistenza.
Abbiamo evidenziato un piccolo verbo in v31 "deve / dei" che rischia di sfuggire all'attenzione del lettore. Quel "dei" greco è un riferimento esplicito alla Scrittura e quindi al disegno di Dio. In qualche modo ciò che Gesù subirà è già presente nella Scrittura. Infatti l'aveva già descritto il Deuteroisaia cinque secoli prima e sono i canti del Servo di JHWH, ovvero del Giusto Sofferente, in particolare il quarto canto in Is 52,13-53,18, che raccomandiamo di leggere per comprendere meglio il nostro brano.
Se è così, dobbiamo affermare che la salvezza passa attraverso la sofferenza del Giusto, quello che in teologia è chiamata "sofferenza vicaria".
Se tutto questo è vero, allora la passione e la morte di Gesù non è un incidente di percorso, una tragica fatalità, ma il perseguimento "obbediente" del disegno di Dio. Solo così poi è possibile la Risurrezione e pertanto la "morte della morte".
Il problema per quei discepoli era allora di comprendere il senso di questa morte atroce e in questa sezione Gesù cerca di spiegarne il motivo. Impresa che non riesce.
Vedremo che dopo ogni predizione della Passione, oltre a questa ne troveremo altre due in 9,31 e 10,32-34, all'annuncio di Gesù segue l'incomprensione dei discepoli e un tentativo di spiegazione da parte del Maestro.
Osserviamo la scena del nostro brano. Gesù ha parlato del suo destino "apertamente" v32, Pietro invece lo rimprovera "in disparte". Poi Gesù, guardando i discepoli a distanza, rimprovera Pietro che invece di seguirlo, cioè, "camminare dietro", vorrebbe che facesse a modo suo, cioè camminargli davanti. In sostanza Gesù si trova "da solo" con un oppositore.
Questa solitudine raggiunge il suo acme sulla croce, quando dei suoi discepoli uno l'ha tradito, uno l'ha rinnegato e tutti gli altri hanno tagliato la corda. Sotto la croce restano quelli che lo deridono, la madre, una ex prostituta e un ragazzino, cioè Giovanni. Ma si tratta di un procedimento di isolamento che inizia sin da ora.
In tutta la sezione, che vede i nostri avviarsi pian piano verso Gerusalemme, le folle spariscono o restano sullo sfondo, anche le guarigione si riducono ad un paio e tutto lo sforzo di Gesù è teso a fare comprendere ai suoi la sua messianità.
E ogni volta Gesù resta sempre più solo: un'incomprensione che lo lascia del tutto solo.
* Lettura 60 Mc 8,34- 9,1 Condizioni della sequela di Gesù
Mc 8,34 «E chiamata a sé la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 35 Perché chi vorrà salvare la propria vita / psuchē (Cei: anima), la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà. 36 Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero e rovinare la sua vita? 37 E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della sua vita? 38 Chi si sarà vergognato di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'Uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi».
9,1 E diceva loro: «Amen, vi dico: vi sono alcuni di coloro che stanno qui, che non gusteranno la morte senza aver visto il Regno di Dio venuto con potenza».
Gesù aveva preannunciato ai suoi discepoli la sua condanna seguita da crocifissione e risurrezione. Pietro l'aveva preso in disparte cercando di persuaderlo a cambiare prospettiva, ma si era preso l'appellativo di "Satana" e l'imperativo di camminargli dietro, Mc 8,31-33.
Ora Gesù si rivolge "apertamente" alla folla, oltre che ai discepoli, chiarendo che la prospettiva della croce riguarda tutti coloro che si pongono alla sua sequela.
Allora possiamo rilevare che la sequela avviene con una certa gradualità.
In 1,16 ss i discepoli erano stati invitati a lasciare le reti per diventare pescatori di uomini.
In 3,14 erano stati chiamati ad un rapporto più stretto «Ne costituì Dodici che stessero con lui».
In 6,7 ss li aveva inviati im missione perché scacciassero i demoni, guarissero gli infermi e convertissero la gente.
Nel nostro brano il rapporto si fa ancora più stretto: ora si tratta di portare la croce insieme a lui, in un destino comune.
Quando Gesù parla di croce o Marco ne scrive per la sua chiesa, essa non è la figura del mal di denti o dell'ulcera che uno si deve sopportare. La croce è uno strumento di supplizio nato molto tempo prima a Babilonia che si era perfezionato nel tempo, nel senso di procurare una grande e lunga sofferenza e i romani si erano specializzati al punto che un condannato poteva stare lì appeso anche per quattro o cinque giorni. Gesto di clemenza era la flagellazione che riduceva il tempo di attesa della morte o la rottura delle gambe che in breve impediva al crocifisso di respirare per cui moriva per asfissia.
Queste crocifissioni erano pubbliche quindi la gente sapeva molto bene di quale atroce usanza si trattasse. Non dobbiamo perdere di vista che oltre alla sofferenza fisica c'è anche una sofferenza morale, costituita dalla vergogna per quel tipo di pena riservata alle persone più infime della scala sociale; vergogna che coinvolgeva anche tutti i famigliari del condannato.
Seguendo molti esegeti, abbiamo scelto di tradurre "psuchē" con "vita", perché il dualismo corpo anima, che si è radicalizzato durante la modernità, ha finito per considerare l'uomo come giustapposizione di due principi tra di loro separati e contrapposti.
Ora, "perdere la propria" vita per salvare la vita stessa, non significa buttare la vita, ma spenderla bene perché essa possa proseguire senza fine nel tempo.
Circa il significato di questo comando, Gesù porta il tema alla condizione limite, la croce appunto. Ma l'esempio riportato in v 36 vale anche per noi che viviamo in paese dove, fortunatamente, la possibilità di incontrare la croce è alquanto remota. Questo comando però ci dice che certi miti della nostra società, sbandierati senza fine dalla comunicazione pubblica, dovrebbero essere accuratamente valutati: pensiamo alla carriera, al successo, al fare soldi, ecc.
Così Gesù ci richiama che c'è qualcosa che conta di più perché tutte quelle "robe" ad un certo punto le dovremo lasciare.
v34 induce un'altra considerazione. Tutto il discorso era stato introdotto dalla predizione della passione e dalle rimostranze di Pietro. In questo versetto viene richiamato il tema del rinnegamento: per salvare la propria vita è necessario "rinnegare se stesso".
E sarà proprio Pietro che nell'atrio del Sinedrio rinnegherà Gesù.
Sembra che Marco mediante questi rimandi voglia proprio mettere sull'avviso i suoi lettori.
* Lettura 61 Mc 9,2- 9,13 La Trasfigurazione
Mc 9,2 «Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in disparte, loro soli. E fu trasfigurato davanti a loro 3 e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, quali alcun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. 4 E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. 5 E Pietro prendendo allora la parola disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!». 6 Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. 7 E venne una Nube che li coprì con la sua ombra e venne una voce dalla nube: «Questi è il mio Figlio, il prediletto; ascoltatelo!» (Sl 2,7; Dt 18,15). 8 E ad un tratto guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro.
9 Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'Uomo fosse risorto dai morti. 10 Ed essi tennero per sé la Parola /Logos, domandandosi però che cos'è questo risuscitare dai morti.
11 E lo interrogarono: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?». 12 Ma egli dichiarò loro: Certamente, Elia venendo prima ristabilisce ogni cosa (Ml 3,23-24) ; e come mai sta scritto sul Figlio dell'Uomo, che avrebbe patito molto e sarebbe stato disprezzato? 13 Ebbene, io vi dico che Elia è già venuto, e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui».
I tre apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni sono i testimoni dei momenti cruciali della vita di Gesù. Li abbiamo trovati alla presenza del risuscitamento della figlia di Giairo 5,22 ss. e li troveremo nell'orto dei Getsemani 14,32 ss. uno dei momenti più drammatici della vita di Gesù, quando egli sarà in "lotta" con il Padre.
Adesso a questi tre discepoli « in disparte, loro soli » sta per essere fatto un dono veramente importante: vedere come Egli è. Ma sappiamo dalle letture precedenti a quale livello di incomprensione erano giunti i rapporti tra Gesù e i suoi, incapaci di affrontare il significato della via della croce.
Non per niente questa teofania accade tra la prima e la seconda predizione della condanna e della crocifissione del Maestro.
Questo brano è tutto intrecciato di rimandi all'Antico Testamento e nello stesso tempo anticipa o prelude agli incontri con il Risorto che Marco non riporta perché, a rigore, il suo Vangelo termina in 16,8 con l'annuncio della tomba vuota e l'invito ai discepoli di recarsi in Galilea: «Là lo vedrete». I vv 16,9-20 infatti sono un'aggiunta successiva di qualche copista. Potremmo dire che secondo Marco l'incontro con il Risorto avviene durante l'ascolto della "Parola" e in quelle manifestazioni in cui Gesù è presentato in forma sovrumana, tecnicamente "gloriosa", come durante le traversate del Mare di Galilea: quella della tempesta sedata 4,35-ss. in cui egli comanda al mare di tacere e al vento di calmarsi, poi quando cammina sulle acque 6,45-ss. e, inoltre in tutte le guarigioni e cacciate di demoni, azioni, queste, che solo Dio può compiere.
Qui troviamo due personaggi importanti dell'Antico Testamento: Mosè ed Elia, ai quali era stato fatto il dono di una teofania sul Sinai, nella medesima caverna. Mosè potè parlare con Dio "faccia a faccia" anche senza poterne vedere il volto. Elia lo conobbe come «voce di silenzio svuotato», che è il titolo che abbiamo dato alla lettura del Libretto di Elia (vedi archivio).
Se è così allora in Gesù abbiamo la sintesi di questi due personaggi: Egli è il nuovo Mosè ed è stato già preceduto dal ritorno di Elia secondo le antiche profezie.
Il tutto è avvolto dalla Nube che a partire dalla Lettura 29 del libro di Esodo, abbiamo mostrato essere che la manifestazione della Presenza di Dio. La Nube abbiamo detto: "rivela e nasconde".
Nel nostro caso dalla Nube promana una voce: «Questi è il mio Figlio, il prediletto; ascoltatelo!» che rimanda al momento del battesimo di Gesù quando egli si trovava lì, in fila con i peccatori, con la ripetizione quasi testuale delle medesime parole: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto» Mc 1,9 Lettura 9.
La prima parte del Vangelo di Marco ricercava l'identità di Gesù ed era giunta alla confessione di Pietro: «Tu sei il Cristo». Qui ci ricolleghiamo all'inizio dove già era presente la testimonianza del Padre: «Questi è il Figlio mio...».
Ci stiamo sempre più avvicinando alla confessione del centurione che l'aveva crocifisso:
15,39 «Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!».
E questo è l'approdo a cui dovranno arrivare tutti i suoi discepoli... quelli di ieri e quelli di oggi.
* Lettura 62 Mc 9,14- 9,29 Guarigione del fanciullo indemoniato e la fede. Tutto è possibile a chi crede.
Mc 9,14 «E giunti presso gli altri discepoli, li videro circondati da molta folla e da scribi che discutevano con loro. 15 E subito tutta la folla, al vederlo, rimase sgomenta e corse a salutarlo. 16 Ed egli li interrogò: «Di che cosa discutete con loro?». 17 Gli rispose uno della folla: «Maestro, ho portato da te mio figlio, posseduto da uno spirito muto. 18 e dovunque si impossessi di lui, lo afferra, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». 19 Egli rispondendo loro disse: «O generazione incredula! Fino a quando starò tra voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatemelo!».
20 E glielo portarono. E lo spirito vedendolo, subito lo contorse e, caduto per terra si ravvoltolava schiumando. 21 E Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?». Ed egli rispose: «Dall'infanzia; 22 anzi, spesso lo ha buttato persino nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, aiutaci, muovendoti a compassione per noi». 23 Ma Gesù gli disse: «Se puoi? Tutto è possibile per chi crede». 24 Subito il padre del fanciullo rispose ad alta voce: «Credo, aiuta la mia incredulità». 25 Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito immondo dicendo: «Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più». 26 E uscì gridando e contorcendolo molto; e il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: «È morto». 27 Ma Gesù, presa la sua mano, lo fece alzare / egeirēe si levò / ànèstē.
28 Ed essendo egli entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogavano in disparte: «Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo?». 29 Ed egli disse loro: «Questa specie di demòni non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera».
Il brano è strutturato intorno a tre scene:
vv 14-19 La prima scena presenta ciò che trovano Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni appena scesi dal monte della Trasfigurazione. È lo smacco subito dagli discepoli rimasti a valle, che non erano riusciti a scacciare il demone dal ragazzo. Smacco molto pesante perché avvenuto sotto gli occhi degli scribi e "molta folla" che erano lì per vedere il "miracolo", come fossero a teatro.
vv 20-27 Nella seconda scena folla e scribi restano sullo sfondo mentre in primo piano troviamo il ragazzo indemoniato, il suo papà e Gesù.
vv 28-29 La terza scena avviene "in casa", che Marco ci ha ormai abituati a considerare un luogo simbolico dove Gesù può trovarsi a tu per tu con i discepoli, mentre gli altri sono "fuori".
Tutte le tre scene sono attraversate dal tema della fede o, se vogliamo, della preghiera.
Di questo brano la parte importante è il dialogo, non tanto la liberazione del ragazzo, perché il dialogo evidenzia che la guarigione è "segno" di altro.
Abbiamo già detto in precedenti letture che i cosiddetti miracoli sono "segni di liberazione dal male". La fatica di Gesù è tutta tesa a mostrare che quando Dio agisce i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati. Non accade mai in tutti gli Evangeli che qualcuno diventi improvvisamente cieco, zoppo o lebbroso; eventi che le tradizioni religiose ha sempre ritenuto interventi delle divinità.
L'esorcismo praticato dai discepoli, secondo le parole di Gesù, non ha avuto successo perché in presenza di una "generazione incredula", letteralmente in greco: apistos: senza fede. L'italiano presenta qualche difficoltà perché non dispone di un verbo che abbia la stessa radice di fede per cui deve utilizzare il verbo "credere"..
In questa "generazione incredula" sono compresi tutti: scribi, il padre del ragazzo oltre agli stessi discepoli. Tutti sono il segno dell'incredulità.
Già, ma cosa è la fede.
Nel canto XXIV del Paradiso, San Pietro pone questa domanda a Dante, il quale risponde:
«Fede è sustanza di cose sperate / e argomento de le non parventi...»
Risposta teologicamente perfetta, ma che alla gente comune non dice granché.
Il nostro brano ci può aiutare dal punto di vista pratico, esistenziale.
Gesù appena arrivato al piano chiede ai suoi: «Di che cosa discutete con loro?».
I discepoli non rispondono. Forse si vergognavano di riferire di un fiasco così clamoroso di fronte alla folla e soprattutto davanti a degli scribi venuti apposta per misurare ogni loro parola.
È il padre del ragazzo che sblocca la situazione raccontando a Gesù la sua situazione e quella del figlio.
Qui siamo di fronte ad un papà che ha fatto chissà quanti e quali numeri per cercare di liberare il suo bambino e ha dovuto passare la sua vita a tenerlo d'occhio, perché lo spirito immondo cercava continuamente di farlo fuori.
In questo racconto, come in altri già esaminati, alla vista di Gesù, il demone induce nel ragazzo una specie di crisi epilettica (i greci chiamavano l'epilessia: male sacro) e il padre anche in questo caso avrebbe potuto proteggerlo come aveva sempre fatto tante altre volte, abbracciandolo e portandolo via. E invece "lo affida" a Gesù. Che è già un inizio di fede... ed è anche preghiera. «Ma se tu puoi qualcosa, aiutaci, muovendoti a compassione per noi».
La risposta di Gesù mette in luce una certa impazienza e forse sofferenza, ma più verosimilmente, stanchezza: ormai era qualche anno che girava per la Galilea a insegnare, guarire, scacciare demoni, ma la gente continuava ad inseguire l'aspetto teatrale della sua attività... oggi avrebbero filmato tutto e messo su YouTube senza parlare dei selfie... poi c'erano gli scribi, i farisei che venivano addirittura da Gerusalemme per contestargli persino le sillabe e i congiuntivi... da ultimo i suoi discepoli che ancora erano allo stesso livello delle folle ad inseguire lo spettacolo e il successo del Maestro. Quindi se esclama: «O generazione incredula! Fino a quando dovrò sopportarvi»? vuol dire che fino a quel momento, salvo rari casi, non era stato colto il senso della sua attività.
La situazione è salvata dal padre del fanciullo con una professione di fede che si fa preghiera... o viceversa... proprio perché non si dà fede senza preghiera né preghiera senza fede.
Il ragazzo viene guarito e liberato dalla sua condizione, che va ben oltre la salute fisica perché qui troviamo i due verbi che indicano la risurrezione, i due verbi della Pasqua: «... fece alzare / egeirē e si levò / ànèstē».
La finale ci presenta Gesù in casa con i suoi, dove viene sottolineata ancora una volta la necessità della preghiera.
Da tutto lo svolgimento non possiamo dire che si giunge alla fede mediante la preghiera?
Lettura 63 Mc 9,30- 32 Seconda predizione della Passione
Mc 9,30 «Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. 31 Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo viene consegnato / paradidotai (Is 53.6.12) nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risusciterà». 32 Ma essi però non comprendevano la Parola e avevano timore di chiedergli spiegazioni».
Siamo sempre nella seconda parte del Vangelo di Marco che abbiamo intitolato: "Gesù il Messia Figlio di Dio Crocifisso", nella prima sezione: "Insegnamento sul Messia sofferente". Marco ce lo ricorda dicendo che Gesù sta percorrendo la Galilea diretto a Gerusalemme, cercando di stare lontano dalle folle, quasi di nascosto.
Adesso il suo compito è quello di istruire i discepoli perché all'indomani della crocifissione e della risurrezione possano diventare "testimoni", perché incontrando il Risorto possano dire: "È proprio Lui".
Essi saranno testimoni anche perché dovranno portare avanti i suoi insegnamenti e permettere ad altri, compresi noi, di incontrarLo. In questo modo sta già dando forma ad un primo barlume di Chiesa.
Troviamo qui il verbo paradidotai che è la forma passiva di paradidomi: consegnare, arrestare, tradire, che è il verbo tipico che attraversa tutto il racconto della passione. Ci può sorprendere quel "consegnare", ma possiamo ricordare che quando un militare era in punizione non poteva andare in libera uscita perché era "consegnato" in caserma.
In questo caso la forma passiva impersonale intende affermare il passivo divino, un modo per dire che si tratta di opera di Dio, da Lui voluta. E infatti è quasi una citazione della "consegna" del Servo di JHWH che troviamo nel secondo Isaia; redatto probabilmente nel IV secolo a. C.
Is 53,6 «Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, / ognuno di noi seguiva la sua strada;
il Signore fece ricadere su di lui / l'iniquità di noi tutti».
Is 53,12 «Perciò io gli darò in premio le moltitudini, / dei potenti egli farà bottino,
perché ha consegnato se stesso alla morte / ed è stato annoverato fra gli empi,
mentre egli portava il peccato di molti / e intercedeva per i peccatori».
Ci può sorprendere che il disegno di Dio preveda la morte del suo inviato, ma era l'unico strumento che gli era rimasto a disposizione per convincere gli uomini che Egli non vuole sacrifici, che Egli vuole essere figura della dedizione incondizionata all'uomo. E se l'uomo questo non lo capisce proprio, e a tutti i costi vuole crocifissi, allora che questo crocifisso sia Lui.
Così che gli uomini dovrebbero finalmente comprendere quanto a Dio costi il suo amore per loro.
Gesù, che è animato dalla stessa volontà del Padre ed opera in "simbiosi" con Lui sin dall'inizio persegue il disegno che lo porterà agli eventi pasquali: crocifissione e risurrezione. Quegli eventi che il Vangelo di Giovanni chiama "la mia ora" cui Gesù accenna sin dal primo segno (miracolo): "Le nozze di Cana" quando, sollecitato da Maria a risolvere il problema della mancanza di vino risponde: Gv 2,4 «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora».
È sorprendente il mutismo dei discepoli che non comprendono la Parola... e non chiedono spiegazioni. Forse l'accostamento della liberazione da Satana che rendeva muto il ragazzo del precedente racconto, ci vuole suggerire che anche i discepoli sono finiti sotto l'influenza del Satana.
Ricordiamo che anche dopo la prima predizione della Parola della croce aveva fatto guadagnare a Pietro l'appellativo di Satana.
Non possiamo fare a meno di rilevare che da quando Gesù inizia a chiarire cosa gli accadrà a Gerusalemme i discepoli non lo comprendono più. E forse Lui cercava un po' di sostegno dai suoi amici.
Così Gesù rimane sempre più solo e incompreso.
Solitudine e incomprensione che troverà il suo punto massimo nell'orto del Getzemani.
Lettura 64 Mc 9,33- 37 Il più grande dei discepoli
Mc 9,33 E vennero a Cafarnao. E quando fu nella casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo lungo la via?». 34 Ma essi tacevano, perché per la via avevano disputato tra loro chi fosse il più grande. 35 Allora, sedutosi, convocò i Dodici e disse loro: «Se qualcuno vuol essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e servitore di tutti». 36 E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro:
37 «Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».
Come al primo annuncio della passione (8,27-33) segue un insegnamento dei discepoli, anche in questo caso troviamo un'istruzione piuttosto lunga che giunge fino a 9,50.
Il testo suggerisce che si tratta di un insegnamento molto importante perché lo caratterizza con alcuni verbi che indicano il modo di insegnare dei maestri d'Israele: "entrare in casa"; "interrogare"; "convocare", "sedersi".
Il contenuto riguarda le conseguenze o le condizioni della sequela del maestro, che possiamo sintetizzare così: come il Figlio dell'uomo sarà "consegnato / paradidomi" nella mani degli uomini, anche i discepoli dovranno accettare di "essere consegnati" e anche di "consegnarsi"... E non definiamo il complemento di termine perché si tratta di una consegna ad ampio raggio.
Dal punto di vista letterario è un'istruzione non molto fluida perché si passa da un argomento all'altro senza un legame comprensibile. Gli esperti ci dicono che si tratta di detti di Gesù, "ipssima verba Jesu", pronunciati in situazioni differenti collegati tra loro da parole gancio che facilitavano la memorizzazione e la tradizione orale; parole gancio che la traduzione dall'aramaico al greco ha irrimediabilmente perduto.
Il tutto avviene a Cafarnao, in Galilea dove tutto era incominciato; non in "una" casa, ma "nella" casa, quella che tutti conoscono. Evidentemente quella di Pietro e Andrea, vedi 1,29ss.
Se è così possiamo dire che ci troviamo di fronte ad un nuovo inizio, quindi un'istruzione puntuale e precisa riservata ai dodici.
Il racconto precedente era terminato con lo sconcertante silenzio dei discepoli dopo la predizione della prossima passione e ora comprendiamo che il loro ordine di pensieri era alquanto differente da quello del Maestro: loro pensavano alla carriera in particolare chi dovesse essere il primo.
Gesù non censura la ricerca di un primato, ma ne modifica il fine e la modalità per arrivarci: diventare servi delle persone più disprezzate, cioè consegnarsi / paradidomi ai più sfortunati.
Così il termine di paragone diventa un bambino. Non perché i bambini sono così piccini, carini e bellini, ma perché nelle culture epocali i bambini non contavano nulla; erano solo un costo in quanto non erano in grado di produrre alcunché. Forse in futuro avrebbero potuto diventare di aiuto alla famiglia, ma con i tassi di mortalità infantile del tempo si trattava di un'eventualità alquanto remota.
Questo gesto di Gesù avrà una portata rivoluzionaria della quale abbiamo perduto la memoria, perché i suoi effetti hanno plasmato tutta la società occidentale. Non dobbiamo dimenticare, ad esempio che i civilissimi romani, se un bambino nasceva con qualche difetto lo gettavano dalla rupe Tarpea e l'esposizione dei neonati era frequentissima soprattutto se erano femmine. Non parliamo poi di quello che accadeva nel vicino o lontano oriente.
Ebbene questo gesto di Gesù spinge i già i primi cristiani a valorizzare i neonati e sin dai primi secoli le comunità cristiane cercano di salvare i bambini abbandonati.
È mondo significativo che attualizza il servizio agli ultimi.
Lettura 65 Mc 9,38- 41 I confini del Regno
Mc 9,38 «Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto un tale scacciare i demòni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato, perché non era dei nostri (letteralmente: "non ci seguiva")». 39 Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. 40 Chi non è contro di noi è per noi.
41 Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità / amen vi dico che non perderà la sua ricompensa».
Certo, Giovanni insieme agli altri ci deve essere rimasto male di fronte all'insuccesso subito nel tentativo di liberare dal demonio il ragazzo di 9,14-29, Lettura 62.
La sconfitta diventa bruciante alla scoperta che uno fuori dal loro "giro", ci riesce facilmente, nel nome di Gesù. È una cosa insopportabile e bisogna assolutamente intervenire.
Però Gesù non è dello stesso parere. Il Regno ha confini molto più grandi che non il gruppo ristretto degli addetti ai lavori. In verità i suoi confini non esistono affatto... Chiunque opera per il bene dell'uomo, chiunque compia gesti di liberazione dal male è in qualche modo legato a Gesù... anche se non ne ha mai sentito parlare.
I discepoli invece sono sintonizzati su altre lunghezze d'onda: "Chi è il primo"?, cioè una competizione all'interno del gruppo, come abbiamo visto nella precedente lettura.
Ed ora un primato esclusivo ed escludente a favore del loro "giro", del loro gruppo.
Ma Gesù li lascia tutti di sasso: basta un bicchiere d'acqua per entrare nel suo "giro"!
Lettura 66 Mc 9,41-50 - La cura della fede
Mc 9,41 «Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa.
42 Chi ostacola / skandalizō uno di questi piccoli che credono (in me), è meglio per lui che gli si metta attorno al suo collo una macina da somaro e venga gettato nel mare.
43 E se la tua mano ti è di ostacolo (Cei: scandalizza), tagliala: è meglio per te entrare nella vita monco, che con due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. 44 dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue.45 Se il tuo piede ti è di ostacolo (Cei: scandalizza), taglialo: è meglio per te entrare nella vita zoppo, che esser gettato con due piedi nella Geenna. 46 dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. 47 Se il tuo occhio ti è di ostacolo (Cei: scandalizza), cavalo: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, che essere gettato con due occhi nella Geenna, 48 dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue (Is 66,24).
49 Perché ciascuno sarà salato con il fuoco. 50 Buona cosa il sale; ma se il sale diventa senza sapore, con che cosa lo salerete? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri».
Tradurre il v 42 skandalizō con scandalizzare può essere letterariamente corretto, ma la nostra attuale comprensione intende lo scandalo quasi esclusivamente legato alla sessualità. In greco esso significa anche ostacolare, fare inciampare, impedire, per cui abbiamo tradotto, al seguito di alcuni esegeti, con "ostacolare"; anche perché l'ostacolo riguarda la fede dei piccoli, che in questo caso non sono i bambini, ma coloro che hanno una fede piccola o che stanno crescendo nella loro fede in Gesù.
Coloro che ostacolano o impediscono la crescita della fede di chi c'è appena entrato commette un peccato talmente grave da meritare una pena superiore ad uno dei supplizi più temuti nella cultura antica e soprattutto dagli ebrei, quello di essere affogato nel mare con una pietra legata attorno al collo in modo da impedire al corpo di tornare a galla. In questo modo viene impedita la sepoltura, l'anima non potrebbe trovare il suo corpo e quindi la pace nello sheol.
Non dobbiamo dimenticare che la lettura dei testi in genere e della Bibbia nel nostro caso, richiede che si debba sempre essere attenti: a chi parla; a chi è diretto il discorso oltre ovviamente di che cosa si parla e dove il discorso è pronunciato. Ricordiamo allora che tutta questa sezione è rivolta non alle folle, ma ai discepoli, più esattamente ai dodici, che sono racchiusi nella casa di Pietro a Cafarnao, una specie di "ritiro spirituale o catechetico".
Allora possiamo dire che i "servi della Parola" sono messi in guardia per non diventare pietra d'inciampo a coloro che sono appena approdati alla fede.
Per venire ai nostri giorni, non possiamo buttar fuori coloro che non sanno esporre correttamente la dottrina della Trinità oppure chi arriva fino a S. Rita o a S. Antonio da Padova o alla Madonna, ma non riesce ad andare oltre. Oppure coloro che biascicano rosari ma non si ricordano tutti i comandamenti.
La figura della "Fede che salva", che abbiamo incontrato nella guarigione dell'emorroissa o del paralitico calato dal tetto, mostra che l'intervento di Gesù non è avvenuto previo esame di catechismo.
E d'altra parte abbiamo chiuso la lettura precedente affermando che basta un bicchiere d'acqua per entrare nel suo "giro"!
I versetti 43 e successivi intesi letteralmente sono alquanto duri, ma si riferiscono agli usi del tempo.
L'amputazione di arti era una pena sostitutiva della pena di morte che, secondo l'uso romano poteva essere la crocifissione, che in questo modo "attenuato" trattava gli autori di furti, rapine, adulterio, ecc. Quindi si trattava di pene alternative alla morte. Tuttavia il testo non è invito ad auto-amputazioni che erano e restano proibite.
Si devono intendere questi detti in modo metaforico. Anche oggi incontriamo e ci trastulliamo con tante cose che ci ostacolano nel nostro cammino di fede alla sequela di Gesù, così egli invita i discepoli a liberarsi di tutto ciò che frena l'andargli dietro.
L'alternativa sarebbe di finire nella Geenna che è una valle a sud di Gerusalemme in cui scorre il torrente Hinnon, un tempo dedicata al culto degli dei cananei, trasformata intorno al 600 a. C. in una discarica, la pattumiera della città, in cui venivano bruciate le immondizie; di conseguenza c'era sempre attivo il fuoco che le consumava. Ovviamente l'uso di questo termine rimanda all'idea di inferno.
D'altra parte il richiamo del fuoco è coerente con l'amputazione degli arti perché il moncherino rimanente doveva essere cauterizzato per evitare infezioni.
Anche il sale poteva essere usato a tale scopo per il suo potere, allora, ritenuto antisettico, ma anche il libro del Levitico prescrive che ogni offerta a Dio non deve essere priva di sale, che rende le carni gustose.
Allo stesso modo anche la fede dei discepoli deve raggiungere la qualità di una fede saporita, gustosa e di conseguenza non priva di sacrifici.
Chiaramente tra questi brani si rileva una certa tensione perché da un lato è richiesto di non ostacolare la fede dei piccoli e dall'altro di curare la qualità della propria fede liberandola dagli ostacoli.
Come sempre il Vangelo non può fare a meno di una seria riflessione personale.
Lettura 67 Mc 10,1-12 E i due saranno una carne sola
Mc 10:1 «Partito di là, si recò nel territorio della Giudea e oltre il Giordano. La folla sumporeuontai / viaggiava insieme (Cei: la folla accorse) di nuovo ed egli l'ammaestrava, come era solito fare. 2 E avvicinatisi dei farisei, per metterlo alla prova, gli domandarono: «È lecito ad un marito ripudiare la propria moglie?». 3 Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha comandato Mosè?». 4 Dissero: «Mosè ha concesso di scrivere un atto di divorzio e di ripudiarla» (Dt 24,1). 5 Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. 6 Ma da principio della creazione Dio li creò maschio e femmina (Gn 1,27); 7 per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola (Gn 2,24). 8 Sicché non sono più due, ma una sola carne. 9 L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto». 10 Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Ed egli disse: 11 «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei; 12 se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio».
Osserviamo che Gesù ha iniziato il cammino verso Gerusalemme seguendo la via della valle del Giordano che dal Mare di Galilea giungeva sino a Gerico (400 m sotto il livello del mare) per poi salire alla città santa (1100 m s.l.). Era una delle vie seguite per i pellegrinaggi al tempio, quindi Gesù e i suoi non sono più soli viaggiano a contatto con altri pellegrini.
Gesù, che abbiamo visto essere il "Pastore escatologico", lettura 46, si sente in dovere di "ammaestrare" questa gente. Ammaestrare è un verbo che dovrebbe lasciarci sorpresi perché si ammaestrano gli animali; agli umani si insegna ed essi imparano. Tuttavia questo verbo evidenzia una cosa importante. Nell'ammaestramento degli animali la responsabilità dell'apprendimento è del domatore non delle bestie. Allora questo verbo vuole significare che Gesù si fa carico della responsabilità dell'apprendimento della folla.
La diatriba con i farisei è tutta giocata su due termini: comandamento e concessione. Gesù chiede quale sia il comandamento di Mosè, cioè il sesto comandamento del Decalogo consegnato da Dio sul Sinai: «Non commettere adulterio» Es 20,14. Ma essi rispondono: "Mosè ha concesso...". Due prescrizioni assolutamente non confrontabili.
La concessione di Mosè aveva lo scopo di evitare l'omicidio della moglie o il semplice abbandono. Una donna abbandonata, priva di risorse, se si univa ad un altro uomo diventava adultera e poteva essere lapidata. Il libello di ripudio è allora una sorta di certificato che consente alla donna di mettersi con una altro uomo senza rischiare la vita: un documento che mira a proteggere la donna stessa.
Dt 24:1 «Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa».
Gesù poi giustifica il comandamento rifacendosi addirittura all'atto creativo di Dio, il quale non ha mai pensato l'uomo come essere solipsistico, ma un essere che vive nella relazione... a immagine di Dio stesso perché Egli prima di tutto è relazione. Sin da prima dell'inizio del tempo ha generato il Figlio e l'amore tra i due è così potente da dare vita alla terza Persona: lo Spirito santo.
Gn 1,27 «Dio creò l'uomo a sua immagine; / a immagine di Dio lo creò; / maschio e femmina li creò».
Pertanto l'unione uomo donna è iscritta nella natura stessa della creazione.
La concessione di Mosè riguardava solo il ripudio da parte dell'uomo mentre la donna non poteva ripudiare il marito, ma l'insegnamento di Gesù, impartito poi ai discepoli, chiarisce che nel caso di divorzio e nuovo matrimonio è adultero tanto la moglie, cosa data per scontata, quanto il marito.
Aspetto rivoluzionario per il mondo giudaico.
Lettura 68 Mc 10,13-16 Diventare come i bambini
Mc 10,13 «Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li sgridavano. 14 Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. 15 Amen (In verità) vi dico: «Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso». 16 E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro li benediceva».
Ancora una volta i discepoli fanno una figuraccia. Si preoccupavano tanto che il Maestro non fosse disturbato da mocciosi che gli giravano intorno senza capire niente, mentre Lui doveva spiegare come entrare nel Regno dei cieli.
E questa volta, cosa molto rara, Gesù si arrabbia di brutto, proprio con i suoi.
Non che i bambini abbiano capito cosa si deve fare per entrare nel Regno di Dio, però essi sono il modello per tutti gli altri. Anzi, la condizione per entrarci è di assumere il loro atteggiamento.
La caratteristica dei bambini è quella di essere assolutamente poveri; dipendono in tutto dai genitori: cibo, vestito, casa, cure... e soprattutto essi si "fidano" dei genitori. Sanno che qualunque loro necessità sarà colmata dalla premurosa presenza del papà e della mamma. Sono si curi come l'oro che dal papà e dalla mamma riceveranno solo cose buone. Esattamente quello che Gesù va predicando dall'inizio a proposito di Dio: quando Dio agisce i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, ecc.
L'atteggiamento contrario, molto diffuso oggi più che allora, è il tentativo dell'autosufficienza: l'uomo duro che si fa da sé... per usare un vecchio slogan. L'uomo moderno ha relegato la sfera del divino fuori dalla comunicazione pubblica perché ormai ha raggiunto l'età adulta e non ha più bisogno di Dio.
Gesù, il Figlio, Dio egli stesso, ha condotto tutta la sua vita all'interno di un legame profondo con il Padre.
Un legame che potremmo tradurre con una parolaccia: "obbedienza".
Quanto di più assurdo in una società "libera" come la nostra, in cui tutti si autorealizzano da sé, anche mettendo i piedi in testa agli altri.
Chi si comporta come quei bambini può essere certo di essere abbracciato e benedetto da Gesù.
Lettura 69 Mc 10,17-22 Se ne andò afflitto perché aveva molti beni
Mc 10, 17 «Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?». 18 Ma Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. 19 Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre»(Es 20,13-16; Dt 5,17-20).
20 Ma quegli gli dichiarò: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 21 Allora Gesù, fissandolo /emblèpsas, lo amò/ ēngàpesen e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». 22 Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni».
Siamo nella sezione in cui Gesù sta cercando con tutte le sue forze istruire, ma abbiamo anche detto "ammaestrare", e di fare comprendere ai discepoli quale sia la forma di Messia che egli incarna. Una forma completamente divergente da quella nutrita dai discepoli, per cui l'incomprensione diventa via via più grande.
Ora, la lettura precedente ruotava intorno all'affermazione, fondamentale in quanto preceduta da "Amen":
10,15 «Amen (In verità) vi dico: «Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso».
Nel presente brano ne troviamo subito l'applicazione... in senso negativo.
Il bambino è colui che non possiede nulla e dipende in tutto dai genitori e in loro ripone tutta la sua la sua fiducia e la sua vita.
Ora questo "un tale"... Marco è molto sottile perché se avesse aggiunto qualche elemento distintivo alcuni ascoltatori o lettori potevano sentirsi "al riparo". Usando "un tale" vuole significare che ci siamo dentro tutti.
Questo tale, oggi lo potremmo chiamare "un bravo ragazzo" perché faceva tutte le cose e tutte le cosine per benino, tant'è che Gesù citandogli il Decalogo secondo Esodo e Deuteronomio, si sente rispondere che lui l'ha sempre rispettato.
Questo "tale" è molto interessante perché si butta ai piedi dell'uomo di Dio, e gli pone una domanda cruciale per la vita attuale e futura. È un uomo in "ricerca". In ricerca della verità per vivere una vita piena.
E Gesù riconosce le sue intenzioni, tanto da fissarlo/ emblèpsas e amarlo/ ēngàpesen; il verbo agapaō indica l'amore donativo, quello che non pretende nulla in cambio, come quello di una madre per il suo piccolino, quindi una immediata attenzione e attesa da parte di Gesù.
Questa scena richiama quelle della chiamata dei discepoli lunga il mare di Galilea (Mc 1,16 ss. Lettura 13) dove Gesù vide/eiden, cioè un semplice vedere, senza fissare e senza alcun movimento di agape. Ma chiamatili essi lasciano le reti e si pongono alla sua sequela.
Questo tale invece ha troppi beni e non riesce a lasciarli. Si tratta di uno degli ostacoli di cui si parlava in 9,42 Lettura 66. Allora si allontana dal Maestro pieno di tristezza.
Potremmo, fare le solite "tirate" circa il non rispondere alla chiamata di Dio e tante cose a proposito di questa tristezza, nata dall'incapacità di seguire il maestro, ma dovremmo fare uno sforzo per coglierne l'aspetto positivo.
Anzitutto vuol dire che non si è allontanato deluso o "infischiandosene", ma "triste e afflitto", dice il testo.
Questo vuol dire che qualcosa di sé, del suo cuore, è rimasto lì con Gesù e i suoi discepoli.
E, tornato a casa, avrà continuato a pensare a quell'incontro, a quello sguardo...
E ci possiamo anche chiedere: cosa avrà pensato qualche settimana dopo quando l'uomo di Dio che tutti indicavano come il Messia è stato appeso alla croce? E più tardi le voci sempre più insistenti che il Crocifisso era risorto?
Nessuno di noi era là a vedere o filmare quegli eventi, ma come ha fatto Marco a raccontare di quello sguardo fisso, intenso e amante, che i due si erano scambiati?
Cosa che nessuno poteva vedere dall'esterno, perché ci sono cose che solo guardandosi profondamente negli occhi gli umani si possono comunicare. E lui di certo l'aveva percepito.
Chi l'ha raccontato a Marco se non proprio quel "tale"?
Lettura 70 Mc 10,17-22 Chi si salva?
Quel "un tale" che se n'è andato molto rattristato perché avendo molti beni è stato incapace di seguire Gesù, lascia il segno nel gruppo dei nostri, tanto che Gesù stesso, quando sono in disparte, riprende l'argomento.
Mc 10,23 «Gesù, guardando intorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto difficilmente quelli che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio!». 24 I discepoli rimasero sbigottiti a queste sue parole; ma Gesù riprese: «Figlioli, com'è difficile entrare nel regno di Dio! 25 È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». 26 Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: «E chi mai si può salvare?». 27 Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: «Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio! Perché tutto è possibile presso Dio» (Gn 18,14; Gb 42,2).
28 Cominciò a dirgli Pietro: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». 29 Gesù gli rispose: «Amen (in verità) vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, 30 che non riceva già al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna. 31 Ora, molti primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi».
Però la ripresa da parte Gesù è tutt'altro che tranquillizzante perché
• nella prima battuta v23 l'accesso al Regno è difficile per coloro che hanno ricchezze,
• in terza v25 abbiamo la nota metafora della cruna dell'ago e del cammello,
• ma al centro l'impossibilità riguarda tutti anche i "figlioli".
Ne segue che nessuno si può salvare con le sue opere e gli stessi discepoli, che hanno mollato tutto, si sentono "fuori anche loro «E chi mai si può salvare?» diventa la domanda cruciale per ogni uomo.
La risposta di Gesù, che cita le antiche scritture (Gn 18,14; Gb 42,2), è categorica: «A Dio tutto è possibile».
Infatti solo Dio è capace di rendere ogni uomo come un bambino: l'essere più povero in assoluto, che interamente dipende da... come abbiamo visto in Mc 10,13-16, Lettura 68... fosse anche all'ultimo momento della tua vita, quando ricchezze, titoli di studio, carriera, onorificenze non valgono più una cicca. È lì che tutti i cammelli transitano tranquillamente per la cruna di qualunque ago. Perché questo è l'impossibile che Dio rende possibile.
Invece, da parte loro, gli uomini di tutte le epoche hanno cercato il modo di fare passare il famoso cammello per la altrettanto famosa cruna dell'ago e anche gli esegeti hanno cercato di correggere il paradosso individuando possibili errori di trascrizione. Il cammello è diventato canapo, gomena, fune, ecc. ma la cruna è sempre risultata impraticabile.
Tanto più che nessuno può tirarsi fuori perché tutti possediamo qualcosa, discepoli compresi.
E risulta inevitabile pensare agli enormi disastri che gli umani hanno commesso tutte le volte che hanno voluto salvarsi o costruire con le loro mani il regno dei cieli sulla terra. Non per altro Gesù, nell'unica preghiera che ci ha insegnato, come seconda domanda rivolta al Padre, ci esorta a chiedere: «Venga il tuo Regno». Ma, appunto il "Tuo", non il nostro. Un Regno che è perennemente "veniente".
Così la salvezza è il dono che dobbiamo sempre chiedere al Padre, ovviamente per mezzo di Gesù.
Come si renderà possibile questa salvezza Gesù lo ripeterà ancora una volta nel brano successivo, quando per la terza volta predirà la sua crocifissione, che i suoi non vogliono neanche sentire nominare.
Però Gesù è sempre attaccato loro, infatti in questo brano riserva ai discepoli gli stessi gesti che poco prima aveva manifestato verso "un tale": li chiama: "Figlioli / tèkna " che è vocabolo della tenerezza e poi: "fissando lo sguardo su di loro": non un semplice vedendoli o guardandoli. Nel fissare lo sguardo c'è un di più che comunica un sentimento profondo che rimanda al momento dell'istituzione dei dodici definita con: «perché fossero con Lui» Mc 3,13, Lettura 29.
A fronte di queste osservazioni i discepoli restano di sasso, ma poi il solito Pietro trova il coraggio di farsi avanti e la risposta di Gesù afferma implicitamente che essa è pertinente.
Osserviamo che la serie di cose lasciate e ritrovate centuplicate, case, fratelli, sorelle, madri e figli, non comprende la moglie perché la conseguenza della moltiplicazione sarebbe imbarazzante.
Viene escluso anche il padre, non perché esso non conti, ma perché nel "lasciare..." essi ritroverebbero l'unico Padre di tutti.
L'ultima battuta v31, richiama ancora una volta il valore del servizio: solo coloro che si metteranno a servizio di tutti potranno essere primi.
Questo dice che anche tra i salvati sarà applicata una forma di giustizia che ribalta la scala sociale.
Lettura 71 Mc 10,32-34 terzo annuncio della passione
Mc 10, 32 «Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti; coloro che venivano dietro erano pieni di timore. Prendendo di nuovo in disparte i Dodici, cominciò a dir loro quello che gli stava per accadere: 33 «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo
sarà consegnato / paradìdōmi ai sommi sacerdoti e agli scribi:
lo condanneranno a morte,
lo consegneranno / paradìdōmi ai pagani,
34 lo scherniranno,
gli sputacchieranno,
lo flagelleranno e
lo uccideranno;
ma dopo tre giorni risusciterà».
I nostri hanno percorso tutta la valle del Giordano dal mare di Galilea fino a Gerico che il punto più basso del loro cammino perché si trova a 300 m sotto il livello del mare.
Gesù adesso si incammina risolutamente verso Gerusalemme che si trova a 800 m sopra il livello del mare, quindi devono percorrere un dislivello di 1100 metri in pieno deserto. Si tratta di un percorso di montagna molto faticoso.
Possiamo immaginare in base alle nostre esperienze di montagna che camminassero in assoluto silenzio perché il "fiato" è appena sufficiente per muovere le gambe e tenere il passo. In queste condizioni la mente pensa intensamente a quello che si è lasciato alle spalle e a quello che si incontrerà nella città. Già c'erano stati degli scontri verbali con i vari personaggi venuti in Galilea da Gerusalemme.
Poi c'erano già stati due annunci della passione.
E adesso cosa accadrà?
Però Gesù è alla testa del gruppo, il che indica che egli conosce esattamente ciò a cui va incontro. È lui che "tira" il gruppo. Forse qualcosa intuiscono anche i discepoli perché "sgomenti e pieni di timore".
In questo contesto ancora una volta chiama in disparte gli Apostoli per istruirli, che è il compito di tutta la sezione che abbiamo chiamato appunto: "Insegnamento sul Messia sofferente".
In questo caso il suo insegnamento è retto da sei verbi che sono le azioni che compiono gli uomini e che Egli subisce. Il verbo consegnare è ripetuto due volte e già da ora veniamo a sapere che se lo rimbalzeranno tra giudei e pagani. Se si deve commettere un'ingiustizia meglio tentare di attribuirne la colpa ad altri.
Il settimo verbo è opera di Dio. Però non viene usata la forma passiva, per cui la risurrezione sarebbe operata da Dio, viene invece usata la forma media che indica un'azione personale di Gesù stesso.
Ma torniamo ai dodici. Quel percorso richiedeva quattro o cinque ore, un lunghissimo tempo per riflettere e ripensare a tutti gli eventi dei giorni precedenti e soprattutto l'angoscia dei giorni a venire dopo un annuncio di tale genere.
Il silenzio diventa pesante e opprimente, anche perché nessuno ancora sa cosa voglia dire "risuscitare".
Lettura 72 Mc 10,35-45 La richiesta di Giacomo e Giovanni
Mc 10,35 «E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo». 36 Egli disse loro: «Cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: 37 «Dacci di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 38 Ma Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che domandate. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati con il battesimo con cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». 39 E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. 40 Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me darlo, ma è per coloro per i quali è stato preparato».
41 All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono contro Giacomo e Giovanni. 42 Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le tiranneggiano, e i loro grandi fanno sentire il potere su di esse. 43 Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, 44 e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti, 45 perché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
La prima cosa che passa per la mente è che la richiesta dei figli di Zebedeo sia una mossa intelligente messa in atto per superare il clima di paura che accompagnava tutto il gruppo nel salire da Gerico a Gerusalemme, aggravato ulteriormente dopo lo sconcertante terzo annuncio della passione da parte di Gesù.
Però non è assolutamente questa l'intenzione di Marco.
Abbiamo già visto come dopo gli altri due annunci della passione la risposta dei discepoli sia sempre stata incoerente.
Dopo il primo annuncio in 8,32 «Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverare Gesù...». La reazione di Gesù è alquanto violenta perché Pietro ragiona secondo gli uomini e non secondo Dio E infatti gli dice: «Va' via dietro me Satana!... (Lettura 59).
Viene così aperta la sezione corrente che abbiamo intitolato: "Insegnamento sul Messia sofferente" che è tutt'uno con il tema della sequela. Infatti proprio all'inizio abbiamo Pietro che invece di "seguire" il Maestro pretenderebbe precederlo.
Durante e dopo il secondo annuncio della passione di 9,32 gli apostoli sono impegnati a discutere che di loro sia il primo, cioè un problema di carriera. La sequela è ancora messa a lato.
Abbiamo anche incontrato l'episodio di "un tale" incapace di attuare la sequela perché possedeva molti beni, 10,17-ss, Lettura 69.
Anche in questo nostro brano la carriera è diventata così importante da diventare oggetto di raccomandazione.
La reazione di Gesù alla domanda dei due ci lascia sorpresi perché Egli non la considera impertinente, ma ne modifica il senso. Quelli pensavano a dei posti privilegiati in un regno terreno, Gesù pensa ad un altro Regno e il privilegio, se così si può chiamare, sarà quello di condividere la sua sorte... ma essi ancora non ne capiscono il senso.
Poi, però, Giacomo sarà il primo apostolo a dare la sua vita per il suo Maestro, come narra il libro di Atti:
At 12:1 «In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa 2 e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni».
Giovanni invece non risulta sia stato martirizzato, ma più volte ha subito varie forme di tortura, di cui quella tradizionalmente più diffusa è l'immersione in una pentola di olio bollente, dalla quale uscì senza danni.
La stessa richiesta del v 35 «che tu ci faccia quello che ti chiederemo» va in direzione esattamente opposta alla seconda domanda del "Padre nostro", l'unica preghiera che Gesù ci ha insegnato: «Sia fatta la Tua volontà». Certo, l'essere umano nella sua debolezza è sempre nel bisogno e Dio viene incontro al bisogno delle sue creature, ma in questo caso si tratta di un bisogno superfluo, un bisogno di fare carriera, appunto. Tanto che gli altri apostoli si arrabbiano e riparte la stessa discussione presente durante e dopo il secondo annuncio della passione. Insomma volere prevalere sugli altri e poterli comandare secondo i propri criteri ha sempre una grande attrattiva. Ieri come oggi.
Così, ancora una volta, per ribaltare la tematica Gesù deve porsi come modello: il Figlio dell'Uomo che serve gli uomini. Il Creatore che serve le sue creature.
In definitiva, il tema della sequela, è il ritornello che ha attraversato tutta la sezione, ma non pare che nessun interlocutore sia stato in grado di coglierlo, apostoli in primis.
Forse Marco ci vuole segnalare che la vera sequela è un obiettivo molto impegnativo da raggiungere.
Lettura 73 Mc 10,46-52 Il cieco di Gerico
Mc 10,46 «E giunsero a Gerico. E mentre usciva da Gerico insieme ai discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, un mendicante cieco sedeva lungo la strada. 47 E udendo che c'era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 48 Molti lo sgridavano perché tacesse, ma egli gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».
49 Allora Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». E chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio! Alzati, ti chiama!». 50 Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 51 Allora Gesù gli disse: «Che vuoi che io ti faccia?». E il cieco a lui: «Rabbunì, che io riabbia la vista!». 52 E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada».
L'istruzione degli apostoli, oggetto di questa sezione non pare abbia avuto grande successo. Essi avrebbero dovuto comprendere come intendesse Gesù l'attualizzazione della sua messianicità, ma le loro precomprensioni e le loro prospettive, hanno sempre avuto il sopravvento. Anche quando Gesù ha definito fino nei dettagli, quale sarebbe stato l'esito finale del suo percorso, non appare alcuno sforzo per cercare di comprendere e di capirlo.
Tra l'altro alcuni di loro erano stati testimoni del risuscitamento della figlia di Giairo (5,21ss) e della Trasfigurazione di Gesù sul monte (9,2) per cui disponevano di elementi aggiuntivi per comprendere meglio l'autorevolezza delle sue previsioni.
Dal punto di vista pratico il problema era quello della sequela e più precisamente, del tipo di sequela. Una sequela destinata ad accogliere il veniente Regno dei cieli che richiede di diventare come bambini (10,13 ss), cioè affidarsi completamente a Gesù.Tutto questo esige di rimuovere tutti gli ostacoli (scandali) che impediscono, ancora una volta, di seguire fino in fondo il Maestro.
Tipica e simbolica, resta la figura di "quel tale" che aveva già tutti i numeri per andare dietro al Maestro, ma all'ultimo ha dovuto tirarsi indietro "perché aveva molti beni" (10,17-ss).
In questo senso tutta la sezione sarebbe contrassegnata dal fallimento se non venisse chiusa dalla figura di Bartimeo, che, tra l'altro, insieme alla figlia di Giairo sono gli unici guariti e "salvati" dei quali viene tramandato il nome.
Nella sua sinteticità anche questa di Bartimeo, è figura simbolica che presenta ancora una volta la forma della "fede che salva".
Allora dobbiamo cercare di scoprire in cosa consiste la fede di questo cieco.
Per quel tempo certe malattie erano conseguenza di gravi peccati commessi magari anche dai genitori (vedi Gv 9), quindi costui era considerato un maledetto da Dio, anche perché non poteva leggere la Scrittura.
v47 È il primo in tutto il Vangelo in cui Gesù è chiamato con il suo nome: «Gesù figlio di David»; prima di lui soltanto i demoni ne proclamavano l'identità.
E bisognerebbe riflettere sull'importanza del nome.
Bartimeo non prega Gesù, ma grida. La Bibbia è piena di preghiere che diventano "grido". Forse perché Dio non ha bisogno di parole per conoscere quello di cui le sue creature hanno bisogno.
Il salmo che si recita nelle liturgie dei defunti inizia con:
Sal 130 «Dal profondo a Te grido JHWH / JHWH ascolta la mia preghiera».
All'inizio del libro di Esodo, il primo libro della Bibbia, che descrive la situazione degli ebrei in Egitto, troviamo questo passaggio:
Es 2,23 «Nel lungo corso di quegli anni, il re d'Egitto morì. Gli Israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio».
Nella rivelazione a Mosè presso il roveto ardente, Dio ad un certo punto gli dice:
Es 3,7 «JHWH disse: "Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e farlo uscire...» (Vedi Esodo, Lettura 13- ss).
In Mc 15, 37 c'è un altro grido, quello del Crocifisso rivolto al Padre, un grido che riassume in sé tutte le grida e tutti i lamenti che gli uomini hanno rivolto al cielo nel corso della storia. È il grido escatologico che troverà la sua risposta il mattino Pasqua.
Tornando al nostro brano: anche Gesù risponde al grido di Bartimeo mandandolo a chiamare. Se il termine non profumasse troppo di incenso, potremmo parlare di "vocazione".
La risposta del cieco è in un gesto che a noi non dice più nulla, ma per quel tempo e quella cultura, ha un significato molto, molto profondo. Troviamo un primo accenno al tema del mantello già in Esodo, quando sul Sinai viene data la Legge a Mosè, ma poi l'argomento è ripreso e approfondito in altri libri biblici, ad esempio Dt 24,12:
Es 22,25 «Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai al tramonto del sole, 26 perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il suo grido, perché io sono pietoso».
Si comprende bene che il mantello è come fosse la "casa" per il povero.
Ora questo nostro mendicante getta via il mantello, cioè la sua casa, la sua sicurezza, l'unico strumento che proteggeva la sua vita e balza in piedi verso Gesù. Per lui la vita di prima o meglio, la vita senza Gesù non ha più senso.
E così Gesù riconosce in lui la "fede che salva".
Una fede così profonda che, mentre prima stava seduto al bordo della strada, ora, in piedi, cammina nel mezzo, dietro a Gesù.
È la sequela senza condizioni.
Tra lui è Gesù non c'è più alcun ostacolo.
La sua vita è interamente affidata a Gesù Nazareno Figlio di David.
Questo cieco è l'unico che ha messo in opera tutti gli insegnamenti impartiti da Gesù in questa sezione circa la sequela.
E i discepoli?
E noi?
Lettura 74 Mc 11,1-13,37 Uno sguardo d'insieme
Con questa lettura inizia una nuova sezione del Vangelo di Marco la quale tratta del breve soggiorno di Gesù a Gerusalemme prima dell'epilogo pasquale.
Gerusalemme è il centro religioso dell'ebraismo che a quei tempi non era confinato all'interno della Palestina, ma si era diffuso nella cosiddetta "diaspora", inizialmente all'interno dell'Impero di Alessandro magno, la Magna Grecia, ma che con il tempo si era propagata anche altrove. Ad esempio, già dal 200 a.C. si era insediata a Roma una comunità ebraica. Per dare un'idea, a livello mondiale si ritiene che la più grande comunità ebraica ai tempi di Gesù non si trovasse a Gerusalemme, ma ad Alessandria d'Egitto.
Ora, Gesù arriva nel più grande centro religioso del tempo che da diversi secoli attendeva l'arrivo del Messia, ma escluso il primo ingresso, non pare abbia trovato un'accoglienza entusiasta.
Dovremo riflettere sull'entrata festosa da parte del popolo 11,1-11, ma subito dopo incontreremo la "cacciata dei profanatori dal tempio" 11,15-19.
Seguiranno poi le "controversie di Gerusalemme" 11,27-12,40 che iniziano da subito con la decisione di ucciderlo, da confrontare con le "controversie galilaiche" 2,1- 3,6.
La sezione si conclude al capitolo 13 con il "discorso escatologico".
Crediamo opportuno cogliere un suggerimento di B. Maggioni, che definisce questo soggiorno nella Città Santa come "incontro di due delusioni".
La delusione di Gesù che non viene accolto dalle autorità religiose che prima di altri avrebbero dovuto intendere il suo messaggio.
La delusione delle autorità politiche e religiose, con il popolo nel suo insieme, che si attendevano l'arrivo di un messia potente in grado di sterminare tutti i nemici politici di Israele, in primis i romani.
Un criterio di suddivisione della sezione potrebbe essere costituito dai tre ingressi mattutini a Gerusalemme, vale a dire, Gesù non dorme in città, ma fuori. Forse perché la città di notte per lui non era sicura, anche se questo il testo non lo dice apertamente.
Mc 11,1 «E quando si avvicinano a Gerusalemme, a Betfage e a Betania, presso il monte degli Ulivi [...] 11 Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio; e dopo aver guardato ogni cosa intorno, essendo già l'ora della sera, uscì verso Betania con i Dodici».
Mc 11,12 «La mattina seguente, mentre uscivano da Betània, ebbe fame. [...] 15 E vengono a Gerusalemme. Ed entrato nel tempio[...] 19 E quando venne sera uscivano fuori della città».
Mc 11,20 «E passando il mattino seguente videro il fico seccato [...] 27 E vengono di nuovo a Gerusalemme».
Marco sottolinea questi tre ingressi di Gesù da Betania (casa dei poveri) e Betfage (casa dei fichi), perché per la gente del suo tempo avevano un significato preciso e lo possiamo ritrovare anche noi se teniamo presente la Bibbia. Ancora una volta ricordiamo che essa deve essere compresa nella sua unità, senza estrapolarne parti e assolutizzarle.
Marco si riferisce ad alcune visioni del profeta Ezechiele, appartenente alla classe sacerdotale e uno dei primi deportati a Babilonia, per cui siamo intorno al 590 -580 a.C.
Occorre fare un premessa. Il tempio era considerata la casa di Dio, ma agli ebrei era chiarissimo che Dio non potesse essere contenuto nel tempio. Viene così usato un "teologumeno" per indicare che nel tempio c'è qualcosa di Dio, ma Dio è anche altrove. Si tratta della Kavod, letteralmente la parte pesante di Dio, tradotto come "Gloria", ciò che di Dio si manifesta come presenza invisibile.
Quindi tutti i pii israeliti sanno benissimo che nel tempio è presente la Gloria di Dio, seduta sui Cherubini, che però non si vede. Perché Dio non si può vedere. Lo sanno tutti!
Ad Ezechiele, però è concessa una visione: la Gloria di Dio esce dalla porta orientale del tempio, si leva in alto, a oriente de tempio, e lì si ferma.
Ez 10,18 «La Gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. 19 I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi; anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del tempio, mentre la Gloria del Dio d'Israele era in alto su di loro».
In un secondo tempo la Gloria esce dalla città e si dirige verso oriente, cioè verso il Monte degli Ulivi.
Ez 11, 22 «I cherubini allora alzarono le ali e le ruote si mossero insieme con loro mentre la Gloria del Dio d'Israele era in alto su di loro. 23 Quindi dal centro della città la Gloria del Signore si alzò e andò a fermarsi sul monte che è ad oriente della città».
Questo consente di dire che Gerusalemme cade nelle mani dei babilonesi perché la Gloria di Dio ha abbandonato la Città Santa, per cui non è la forza dell'esercito nemico ad avere vinto la città, ma l'abbandono da parte di Dio.
Al termine dell'esilio, quando Israele ha scontato tutte le sue infedeltà, la Gloria di Dio può ritornare nel tempio.
Da che parte? Dalla stessa parte da cui si era allontanata: da Oriente, cioè dal Monte degli Ulivi:
Ez 43:1 «Mi condusse allora verso la porta che guarda a oriente 2 ed ecco che la Gloria del Dio d'Israele giungeva dalla via orientale e il suo rumore era come il rumore delle grandi acque e la terra risplendeva della sua Gloria. 3 La visione che io vidi era simile a quella che avevo vista quando andai per distruggere la città e simile a quella che avevo vista presso il canale Chebàr. Io caddi con la faccia a terra. 4 La Gloria del Signore entrò nel tempio per la porta che guarda a oriente».
Quando arriverà il Messia nella Città santa da che parte entrerà? Ovviamente da Oriente, cioè dal Monte degli Ulivi.
E Gesù entra per ben tre volte in Gerusalemme dalla parte del Monte degli Ulivi.
Un'ultima volta sarà quando verrà arrestato nell'orto del Getzemani, il quale si trova sulle pendici del Monte degli Ulivi.
Dal Monte degli Ulivi avverrà anche il distacco di Gesù dai discepoli, cioè l'Ascensione:
Lc 24, 44 «Poi disse: «Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». [...]».
50 Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. 51 Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. 52 Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia; 53 e stavano sempre nel tempio lodando Dio».
Questi dati biblici hanno prodotto delle conseguenze precise.
Quando alla fine dei tempi il Figlio dell'Uomo tornerà nella sua Gloria, da quale parte arriverà? Un'ultima volta, ancora da Oriente, cioè dal Monte degli Ulivi.
Allora dove si seppelliscono coloro che attendono il ritorno del Signore perché sono defunti?
Nella valle del Cedron, quella che sta tra Gerusalemme e il Monte degli Ulivi.
In base a queste indicazioni bibliche anche le nostre chiese un tempo erano "orientate", cioè rivolte ad Oriente.
Così è per il Duomo di Milano che grazie al suo "orientamento", al sorgere del sole le vetrate dell'abside si illuminano in un fantastico arcobaleno di colori. E i fedeli in preghiera sono così rivolti nella direzione in cui il
Signore ritornerà.
E i defunti dove li mettevano? Ovviamente ad Oriente dietro al Duomo, di cui è rimasta una debole traccia: via Camposanto.
Altre chiese invece rivolgono ad Oriente la facciata da cui entrerà il Signore al suo ritorno, come la Basilica di S. Francesco ad Assisi, o la Basilica di S. Pietro a Roma.
Essere "orientati" vuol dire essere rivolti dalla parte da cui arriva il Signore.
L'oriente è anche il luogo citato nella liturgia di Lodi tutte le mattine, quando al termine del Cantico di Zaccaria diciamo:
Lc 1,78 «Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, / per cui verrà a visitarci dall'alto un Oriente /anatolè che sorge..»
Quell'Oriente /anatolè è stato tradotto con "sole".
Traduzione non impertinente perché appunto il sole sorge a oriente.
Queste considerazioni possono sembrare banali, ma dovrebbero richiamarci il più grande mistero del cristianesimo: l'Incarnazione. Gesù era "vero uomo e vero Dio" come dice il dogma di Calcedonia, ma proprio perché vero uomo si era caricato pienamente della nostra umanità, comprese le caratteristiche della terra e della gente tra cui è vissuto.
È nato a Betlemme non a Gallarate o a Londra. Quindi Gesù era ebreo, parlava l'aramaico con l'accento dei galilei, forse conosceva il greco perché in Galilea erano mescolati con altre razze, tanto da esser disprezzato dai puristi della Giudea.
Era circondato da una rete di legami affettivi, la sua mamma, i suoi amici, i suoi compaesani, ecc.
È stato crocifisso a Gerusalemme in luogo preciso e a pochi passi dalla croce l'hanno sepolto.
Queste sono le notizie concrete della vita di un uomo vissuto circa 2000 anni fa.
Per cui l'universalità del cristianesimo non deve fuggire il rischio di ridurlo ad una filosofia disincarnata.
Lettura 75 Mc 11,1-11 Ingresso messianico a Gerusalemme
Mc 11, 1 «Quando si avvicinarono a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli 2 e disse loro: «Andate nel villaggio che sta di fronte, e subito entrando in esso troverete un puledro legato, sul quale nessuno si è mai seduto. Slegatelo e portatelo a me. 3 E se qualcuno vi dicesse: Perché fate questo? rispondete: Il Signore / Kùrios ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». 4 Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. 5 E alcuni dei presenti però dissero loro: «Che cosa fate, che slegate questo puledro?». 6 Ed essi risposero come aveva detto loro Gesù. E li lasciarono fare.
7 E portarono il puledro a Gesù, e vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. 8 E molti stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle fronde, che avevano tagliate dai campi. 9 Quelli poi che andavano innanzi, e quelli che venivano dietro gridavano:
Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! (Sal 118,25-26)
10 Benedetto il regno che viene, del nostro padre Davide! / Osanna nel più alto dei cieli!
11 Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver guardato ogni cosa intorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i Dodici diretto a Betània.»
Gran parte della scena avviene alle porte di Gerusalemme verso il Monte degli Ulivi. Il riferimento va alle profezie di Zaccaria, vissuto a cavallo del 500 a. C. cioè tra la fine dell'esilio babilonese e l'inizio della ricostruzione di Gerusalemme. In Zac 14 troviamo una profezia che ha per oggetto "il giorno del Signore", cioè quando Dio viene a compiere ogni giustizia. Ne riportiamo alcuni brani perché ancora una volta viene coinvolto il Monte degli Ulivi, ma consigliamo di leggere anche le parti omesse.
Zac 14:1 «Ecco, viene un giorno per il Signore [...] ma il resto del popolo non sarà strappato dalla città. 3 Il Signore uscirà e combatterà contro quelle nazioni, come quando combatté nel giorno della battaglia. 4 In quel giorno i suoi piedi si poseranno sopra il monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme verso oriente, e il monte degli Ulivi si fenderà in due, da oriente a occidente, formando una valle molto profonda; una metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra verso mezzogiorno. [...] 6 In quel giorno, non vi sarà né luce né freddo, né gelo: 7 sarà un unico giorno, il Signore lo conosce; non ci sarà né giorno né notte; verso sera risplenderà la luce. 8 In quel giorno acque vive sgorgheranno da Gerusalemme...».
Come si vede lo scenario, ad esclusione delle immagini apocalittiche, è abbastanza simile a quello dell'ingresso di Gesù, per cui dobbiamo tenerlo sullo sfondo. Però, se il tema del brano è l'ingresso messianico a Gerusalemme sorprende che più di metà della pericope sia dedicata al problema dell'asinello. Segno che ci sta sotto qualcosa di significativo.
Dobbiamo però ricordare anzitutto, che la costruzione del tempio avvenuta sotto Salomone attorno al 1000-900 a. C. aveva portato all'unificazione del culto concentrandolo tutto a Gerusalemme. Tutti gli altri santuari anche importanti, sparsi per il paese erano stati soppressi. Nessun sacrificio poteva essere compiuto al di fuori del tempio della Città Santa, e gli israeliti, teoricamente tutti i maschi al di sopra dei 12 anni, dovevano recarsi a Gerusalemme per potere sacrificare al Signore. Questo aveva trasformato la città in un luogo largamente dotato di alberghi e ricoveri per i pellegrini, strutture che non venivano di certo affittate gratuitamente.
Però, Gesù alloggia a Betania / Casa del povero, che si trova a qualche chilometro della città sulle pendici del Monte degli Ulivi e gli scavi archeologici hanno permesso di rilevare antichi sepolcri con nomi prevalentemente galilaici (Pesch). Questo fa pensare che la località fosse una sorta di colonia della Galilea frequentata soprattutto da pellegrini provenienti da quella regione.
Come abbiamo rimarcato nella sezione precedente Gesù è venuto dalla Galilea seguendo la via del Giordano fino a Gerico, per poi salire a Gerusalemme insieme "alle folle". Teniamo presente che siamo in prossimità della Pasqua, quindi in un periodo particolarmente affollato. Lc 2,44 ci segnala che a quei tempi non viaggiavano in modo isolato ma formavano delle carovane. I malintenzionati c'erano anche allora.
Non è da escludere che "i molti" del v8 e "quelli che andavano innanzi" del v9, fossero stati in qualche modo compagni di viaggio, anche se tra di loro potrebbero essersi poi aggiunti abitanti di Gerusalemme.
E questo dovrebbe già farci riflettere circa la differenza tra questo popolo osannante e quello che di lì a qualche giorno griderà a Pilato: "Crocifiggilo"; probabilmente i primi erano galilei i secondi gerosolimitani.
A riguardo dell'asino lo stesso Zaccaria richiama un'antica tradizione che vede l'insediamento regale fatto su di un asino e non su di un cavallo. Gli ebrei hanno sempre nutrito una profonda avversione per i cavalli.
Infatti già dopo il prodigioso attraversamento del Mar Rosso (circa 1225 a. C.) come narra il libro di Esodo, primo libro della Bibbia, alla vista dell'esercito egiziano travolto dalle acque appare questa insofferenza per i cavalli.
Es 15, 1 «Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero:
«Voglio cantare in onore del Signore: / perché ha mirabilmente trionfato,
ha gettato in mare / cavallo e cavaliere».
Anche perché in un ambiente montagnoso come la Palestina il cavallo non può essere utilizzato perché le strade sono praticamente assenti, sostituite da sentieri e mulattiere. Gli stessi muli, incrocio tra un asino e una cavalla cioè, mezzi cavalli, non erano ben visti perché ibridi e sterili.
L'animale usato dalla gente comune era l'asino, paziente e resistente alle fatiche, mentre il cavallo era usato dai ricchi e dai soldati per la guerra. Il primo era considerano un animale di pace il secondo animale per la guerra o per ostentare potere.
Già l'unzione del re Salomone figlio di Davide (siamo poco dopo l'anno 1000 a. C.) vede l'impiego di un asino:
1 Re 1,38 «Scesero il sacerdote Zadòk, il profeta Natan e Benaià figlio di Ioiadà, insieme con i Cretei e con i Peletei; fecero montare Salomone sull'asina del re Davide e lo condussero a Ghicon. 39 Il sacerdote Zadòk prese il corno dell'olio dalla tenda e unse Salomone al suono della tromba. Tutti i presenti gridarono: «Viva il re Salomone!». 40 Risalirono tutti dietro a lui, suonando i flauti e mostrando una grandissima gioia e i luoghi rimbombavano delle loro acclamazioni».
Ma troviamo anche l'uso dei mantelli nel racconto dell'unzione alla dignità regale di Ieu eseguita dal profeta Eliseo:
2 Re 9,11 «Quando Ieu si presentò agli ufficiali del suo padrone, costoro gli domandarono: «Va tutto bene? Perché questo pazzo [Eliseo] è venuto da te?». Egli disse loro: «Voi conoscete l'uomo e le sue chiacchiere». 12 Gli dissero: «Baie! Su, raccontacelo!». Egli disse: «Mi ha parlato così e così, affermando: Dice il Signore: Ti ungo re su Israele». 13 Tutti presero in fretta i propri vestiti e li stesero sotto di lui sugli stessi gradini, suonarono la tromba e gridarono: «Ieu è re».
Ma quelli erano tutti re che miravano ad allargare il loro regno e il modo più naturale e usuale era quello della guerra.
Non è il caso di Gesù perché il suo Regno è altra cosa. Per lui vale un'altra profezia di Zaccaria:
Zac 9,9 «Esulta grandemente figlia di Sion, / giubila, figlia di Gerusalemme!
Ecco, a te viene il tuo re. / Egli è giusto e vittorioso,
umile, cavalca un asino, / un puledro figlio d'asina.
10 Farà sparire i carri da Efraim / e i cavalli da Gerusalemme,
l'arco di guerra sarà spezzato, / annunzierà la pace alle genti,
il suo dominio sarà da mare a mare / e dal fiume ai confini della terra».
In questo modo abbiamo trovato tutti gli elementi presenti nel nostro testo.
Gesù è colui che realizza queste profezie: un re di pace. Un re povero che non possiede neanche un asino per la sua intronizzazione... e deve farselo prestare.
Però c'è un corteo che inneggia al suo ingresso nella città santa. E ci sono anche alcuni che mettono i loro mantelli sulla strada, insieme alle fronde degli ulivi e cantano un salmo delle ascensioni. Sono i salmi che i pellegrini cantavano al termine del pellegrinaggio quando salivano a Gerusalemme per entrare nel tempio.
In questo caso però cantano solo alcuni versetti:
9 «...Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! (Sal 118,25-26)
10 Benedetto il regno che viene, del nostro padre Davide! / Osanna nel più alto dei cieli»
In qualche modo questa gente riconosce Gesù come il Messia, sebbene l'accenno al regno di Davide manifesta l'idea che si tratti di ripristinare l'antico regno nella sua potenza.
Una potenza che anche nell'ultimo versetto del nostro brano si manifesta in modo singolare.
I vangeli riportano più volte il fatto che Gesù si ritirasse in solitudine, nel deserto o su di un monte a pregare, ma in questo caso, nel tempio, Gesù non si dice che abbia pregato, ma soltanto di « aver guardato ogni cosa intorno e poi uscì...».
Ma, se teniamo presente quanto detto nella lettura precedente, possiamo dire che la Kavod / Gloria di Dio è entrata nel tempio... e poi se n'è andata nella "Casa del Povero", cioè Betania...
E contrariamente al testo di Zaccaria, nessuno se n'è accorto!
Forse perché il nostro Dio non ha bisogno di chiasso!
Lettura 76 Mc 11,12-14 Maledizione del fico
Mc 11,12 «E il giorno seguente quando essi uscirono da Betania, ebbe fame. 13 E avendo visto di lontano un albero di fico che aveva foglie, si avvicinò per vedere se mai vi trovasse qualche cosa in esso; ma giuntovi sotto, non trovò altro che foglie. Non era infatti quella la stagione dei fichi. 14 E prendendo la parola gli disse: «Mai più in eterno nessuno mangi frutto da te». E i discepoli l'udirono».
Questo testo in passato ha spesso imbarazzato i commentatori perché non riuscivano a giustificare il fatto che Gesù cercasse dei fichi fuori stagione. Tant'è che Matteo non riporta l'annotazione del v 13 "Non era infatti la stagione dei fichi", quasi a giustificare che la mancanza dei frutti fosse colpa del fico e non la pretesa assurda di trovarne fuori tempo. Ma allora Gesù aveva anche lui delle pretese assurde? Oppure era stato preso da una voglia incontrollabile?
Niente di tutto questo. Gesù si inserisce nella linea dei profeti antichi ed esprime una profezia attraverso un'azione simbolica.
Fino al profeta Geremia, salvo pochi squarci, la figura del profeta, la sua vita, la sua personalità, restano nascoste dietro la Parola di cui egli è vettore. A partire da Geremia appare il genere della "Confessione" in cui il profeta è coinvolto nel messaggio che Dio vuole fare giungere al popolo. In questa linea troviamo anche le "azioni simboliche" che diventeranno frequenti in Ezechiele.
Senza stare a perderci in teorie e definizioni vediamo una azione simbolica molto evidente, che ha vissuto il profeta Osea e siamo tra il 750 e il 725 a. C. nel Regno di Israele (del Nord).
Os 1:1 «Parola di JHWH rivolta a Osea figlio di Beerì, al tempo di Ozia, di Iotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Geroboàmo figlio di Ioas, re d'Israele.
2 Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse:
«Va', prenditi in moglie una prostituta / e abbi figli di prostituzione, poiché il paese non fa che prostituirsi
allontanandosi da JHWH».
3 Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblàim: essa concepì e gli partorì un figlio.
4 E JHWH disse a Osea: / «Chiamalo Izreèl, perché tra poco / vendicherò il sangue di Izreèl sulla casa di Ieue porrò fine al regno della casa d'Israele. / 5 In quel giorno / io spezzerò l'arco d'Israele nella valle di Izreèl».
6 La donna concepì di nuovo e partorì una figlia e il Signore disse a Osea:
«Chiamala Non-amata, / perché non amerò più / la casa d'Israele, / non ne avrò più compassione. [...]
8 Dopo aver divezzato Non-amata, Gomer concepì e partorì un figlio. 9 E il Signore disse a Osea:
«Chiamalo Non-mio-popolo, / perché voi non siete mio popolo / e io non esisto per voi».
Izreèl è la residenza dei re del regno del nord anche se la capitale era Samaria, ma soprattutto una valle piuttosto larga e pianeggiante, luogo molto adatto per fare scontrare gli eserciti; infatti le battaglie che nel corso del tempo lì sono avvenute sono tantissime. In particolare Ieu, uno dei capi dell'esercito, aveva usurpato il potere uccidendo il re d'Israele (nord) e tutta la sua famiglia attraverso una carneficina sconcertante (2 Re 9).
La vendetta cui il testo probabilmente si riferisce è la caduta, nel 722 -721, del Regno del Nord ad opera dell'esercito assiro e la seguente deportazione e dispersione di tutti gli abitanti in diverse regione di quell'impero.
In questo breve testo troviamo:
1- il comando di Dio: v 2 "prenditi in moglie una prostituta"
2- l'esecuzione dell'ordine: v 3 "Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblàim" con la conseguente nascita di tre figli di prostituta.
3- la spiegazione di quella azioni: ai figli viene imposto il nome indicato da Dio: Izreel, Non-amata, Non-mio-popolo, a ciascuno dei quali segue la spiegazione del significato di quel nome.
Tutta questa simbologia intende significare il comportamento negativo del popolo verso il suo Dio.
Per non restare con la bocca amara suggeriamo di leggere tutto il capitolo secondo del libro di Osea in cui troviamo il ribaltamento di questa tragica situazione.
Ora, anche Gesù, cercando dei frutti su di un fico fuori stagione, compie un'azione che ha un significato simbolico, che però né prima né dopo di questo brano venga spiegato.
Allora l'uditore e il lettore allora sono costretti a interrogare il testo per cercare chi o che cosa produca solo foglie, ma non frutti.
Lettura 77 Mc 11,15-19 Cacciata dei profanatori dal tempio
Il primo giorno Gesù era salito a Gerusalemme in modo quasi trionfale. Era entrato nel Tempio "guardando attentamente ogni cosa".
In questo secondo giorno, dopo avere maledetto il fico che non aveva frutti, entra nel tempio e cerca di purificarlo.
Allora è il Tempio e quelli che lo frequentano che non producono frutti?
Mc 11, 15 «Andarono intanto a Gerusalemme. Ed entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e comperavano nel tempio; rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe 16 e non permetteva che qualcuno trasportasse cose attraverso il tempio. 17 Ed insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: La mia casa sarà chiamata / casa di preghiera per tutte le genti? (Is 56,7).
Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri!» (Ger /,11).
18 L'udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano come farlo perire, perché avevano paura di lui, perché tutto il popolo era ammirato del suo insegnamento. 19 Quando venne la sera uscirono dalla città».
Se pensassimo che il tempio di Gerusalemme fosse simile alle nostre chiese saremmo completamente fuori strada e non riusciremmo a capire l'intervento di Gesù.
Esso era formato da una successione cortili o atri scoperti a cui potevano accedere la varie categorie di persone. Il cortile più esterno chiamato dei gentili o dei pagani era quello più ampio ed è quello che interessa il nostro brano.
C'era poi un cortile più interno nel quale erano ammesse le donne, un altro più interno ancora riservato solo ai maschi ebrei e circoncisi. L'edificio più interno era il Santo dei Santi che conteneva il trono sul quale sedeva la Kavod cioè la Presenza, l'arca dell'alleanza con le Tavole della Legge ricevute da Mosè su Sinai. (In internet si possono trovare molte descrizioni).
Il commercio degli animali.
Dobbiamo ricordare che nel mondo antico, l'uccisione degli animali era sempre un rito sacro di competenza dei sacerdoti, per cui la possibilità di mangiare carne era sempre in relazione alla macellazione avvenuta in un tempio.
È il problema che incontra Paolo con i cristiani di Corinto che se volevano mangiare carne dovevano inevitabilmente rivolgersi ai macellai che vendevano esclusivamente carne proveniente da animali sacrificati agli idoli in un tempio, chiamati perciò: "idolotiti" (1 Cor 8 ss.).
Invece in Israele il problema non esisteva. Costruito il tempio di Gerusalemme, Salomone e i suoi successori, riservarono il culto con i sacrifici di animali esclusivamente al Tempio e questo non rese più disponibile carni sacrificate, in altri parti del paese e meno ancora nella diaspora. In questo modo l'uccisione degli animali perde il significato religioso e diventa un gesto profano. Teoricamente, però, ogni anno il pio ebreo deve recarsi a Gerusalemme per compiere un sacrificio di comunione con Dio. Un animale viene offerto al sacerdote che tiene una parte per sé, una donata a Dio attraverso la combustione, un'altra è consegnata agli offerenti che in opportuni luoghi della Città Santa, cenacoli, consumeranno quel pasto di comunione. Come faranno i nostri discepoli con Gesù nell'Ultima Cena.
Però non è che un pellegrino partito dalla Galilea si porta a Gerusalemme il toro, l'agnello, ecc. (si potevano sacrificare solo animali maschi, per un motivo più che banale: i maschi non fanno latte: sono meno produttivi delle femmine) per farlo sacrificare, ma lo compra nei pressi del tempio.
Il nostro brano dice che questo accade nel Cortile dei gentili, quello più grande. Comprendiamo senza difficoltà che il tempio diventa una sorta di macelleria preceduto dal mercato del bestiame. Una roba decisamente poco devota che fa perdere il senso del sacro.
I cambiavalute
Tutti gli ebrei erano tenuti a versare ogni anno una sorta di tassa per la gestione del Tempio. Però a Gerusalemme erano in uso monete di varia provenienza, romane, greche, ecc. e per di più gli ebrei residenti nella diaspora portavano con sé monete coniate nel paese di residenza.
Il primo comandamento del Decalogo, consegnato a Mosè sul Sinai, prescrive tra l'altro:
Es 20,4 «Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra».
Obbedendo al comandamento, le monete ebraiche, a differenza delle altre, da sempre, non recavano immagini di alcun tipo ed erano le uniche accettate per il tesoro del tempio.
Da qui la necessità di cambiavalute che convertissero le varie monete. Ovviamente ieri come oggi, con opportuni guadagni.
Gli attraversamenti del Tempio
Il Tempio occupava una superficie alquanto vasta 450 x 300 m, e si trovava in mezzo alla città. Poiché c'erano porte su tutti i lati, chi voleva risparmiare strada lo attraversava tranquillamente. Il nostro testo parla di carichi e probabilmente si tratta di gente che lo attraversava con asini, carri ecc.
Le prime due erano attività che in qualche modo erano al servizio dei riti del tempio e per certi versi ineliminabili, pertanto gli studiosi si chiedono se con i suoi gesti Gesù intendesse introdurre una riforma o semplicemente eliminare i sacrifici privilegiano esclusivamente la preghiera.
Il dubbio è pertinente perché quando Marco redige questi testi il Tempio e la stessa città erano stati distrutti e i cristiani ritenevano che gli antichi sacrifici fossero stati sostituiti dall'Unico Sacrificio avvenuto una volta per tutte sul Calvario.
Tuttavia il testo suggerisce che Gesù si pone nella linea rigorosa degli antichi profeti e infatti, cita Isaia e Geremia per cui riteniamo sia più attendibile la prima ipotesi.
Certo il brano solleva il tema della qualità della preghiera, non solo di quel tempo, ma anche del nostro e allora appare lecito interrogarci a riguardo dell'uso che facciamo dei nostri luoghi di culto e come vi partecipiamo.
Sconcertante è l'esito della azione di Gesù. Non un ringraziamento per avere richiamato i frequentatori al rispetto della sacralità dell'edificio, ma la decisione di farlo morire, presa proprio da coloro che erano i custodi della religione.
Però il "popolo era ammirato".
Allora chi non produce frutti?
Lettura 78 Mc 11,20 - 26 Forza della fede della preghiera e del perdono
Mc 11,20 «La mattina seguente, passando, videro il fico seccato fin dalle radici. 21 Allora Pietro, ricordatosi, gli disse: «Rabbì, guarda: il fico che hai maledetto si è seccato». 22 Gesù rispondendo disse loro: «Abbiate fede in Dio! 23 Amen vi dico: chiunque dirà a questo monte: Lèvati e gettati nel mare, e non esiterà in cuor suo, ma crede che quanto dice avviene, ciò gli sarà concesso. 24 Per questo vi dico: tutto quello che chiedete nella preghiera, se avete fede di averlo ottenuto, vi sarà accordato. 25 Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe».
Siamo arrivati al terzo giorno. E sempre sulla strada tra Betania e Gerusalemme passano vicino al fico che Gesù ha maledetto il giorno prima perché non aveva frutti, come abbiamo visto due letture fa.
In questo modo il racconto della maledizione del fico, abbraccia la cacciata dei profanatori dal Tempio. Allora il problema è il Tempio, ma ciò che deve finire non è tanto il Tempio in quanto tale, ma la sua gestione: esso deve tornare ad essere «casa di preghiera per tutte le genti» (Mc 11,17; Is 56,7) e non un centro commerciale seppure con finalità religiosa.
Però la constatazione del fico seccato ha molto impressionato il nostro gruppo, anche se parla solo Pietro. Uno strano miracolo perché tutti i precedenti interventi di Gesù erano stati "segni di liberazione dal male" cioè guarigioni di ciechi, di zoppi, di sordi, di lebbrosi, ecc.
Intanto Gesù propone qui uno degli ultimi insegnamenti riservati agli apostoli, come prosecuzione della sezione precedente. Un insegnamento che riguarda l'efficacia della preghiera che se fatta con fede assicura la possibilità di un miracolo ancor più paradossale di un fico seccato in poche ore: addirittura la traslazione di un monte. "Questo monte" è il monte degli Ulivi dalla cui cima si vede il Mar Morto, quello cui allude il testo perché il più vicino.
Per traslare "questo monte" occorrono tre elementi: la fede, la preghiera e il perdono. Sono elementi che partono dal cuore dell'uomo, (che per gli ebrei era la sede delle intenzioni, della coscienza, delle decisioni, funzione che noi attribuiamo al cervello).
Una preghiera senza fede non può essere accolta perché riguarda solo le labbra mentre il cuore, le intenzioni "girano" altrove. In questo caso l'uomo è diviso in se stesso.
A fronte di questo miracolo paradossale, l'attenzione si posa sul tema del perdono. Esso viene accordato da Dio a condizione che tu perdoni l'altro. Che è quanto si chiede nel Padre nostro, assente in Marco: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori» Mt 6,12.
Allora c'è un ribaltamento rispetto alla funzione del Tempio: un perdono di Dio donato, non a fronte dell'uccisione di animali, ma legato a preghiera e perdono dei fratelli.
Forse ci aiuta a comprendere questa novità se teniamo presente che quando Marco redige questi testi, da poco il tempio è ridotto ad un cumulo di rovine, ma c'è un nuovo Tempio: la fraternità di coloro che hanno fede in Gesù assidui nella preghiera (At 1,14) e che perdonano tutti, anche i persecutori.
Lettura 79 Mc 11,27 - 33 Controversia sull'autorità exousia di Gesù
Mc 11,27 «Andarono di nuovo a Gerusalemme. E mentre egli si camminava nel tempio, vennero da lui i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero: 28 «Con quale autorità / exousia fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità / exousia per fare questo?». 29 Ma Gesù disse loro: «Vi farò anch'io una domanda e, se mi rispondete, vi dirò con quale autorità /exousia faccio questo. 30 Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». 31 Ed essi ragionavano tra di loro dicendo: «Se diciamo: "dal cielo", dirà: Perché allora non gli avete creduto? 32 Diciamo dunque "dagli uomini"?». Però temevano la folla, perché tutti consideravano Giovanni un vero profeta. 33 Allora diedero a Gesù questa risposta: «Non lo sappiamo». E Gesù disse loro: «Neanch'io vi dico con quale autorità /exousia faccio queste cose».
Con questo brano iniziamo ad esaminare le cinque controversie di Gerusalemme le quali, come già detto, devono essere considerate in relazione alle controversie galilaiche.
Là era in gioco la libertà di Gesù e dei discepoli nei confronti delle deformazioni nelle applicazioni della Legge avvenute nel corso del tempo; esse erano diventate usanze e tradizioni che avevano reso la vita impossibile e, potremmo dire, che avessero anche deformato l'immagine del legislatore: Dio.
Ricordiamo brevemente quelle controversie:
1- La guarigione del paralitico calato dal tetto a dimostrazione della exousia / autorità di Gesù nel perdonare i peccati: 2,1ss; Lettura 20.
2- La chiamata di Levi e la condivisione della mensa con pubblicani e peccatori: 2,19ss; Lettura 21.
3- La discussione sul digiuno che i discepoli non praticavano: 2,18ss; Lettura 22 e 23.
4- Le spighe strappate di sabato: 2,23ss; Lettura 24.
5- La guarigione della mano rattrappita in giorno di sabato: 3,1ss; Lettura 25
Seguiva poi la Lettura 26 per una valutazione d'insieme di quelle controversie.
Ricordiamo che esse terminavano con la decisione presa da farisei ed erodiani di fare perire il Maestro 3,6.
Qui, a Gerusalemme la decisione di uccidere Gesù era già stata presa da scribi e sommi sacerdoti subito dopo la cacciata dei profanatori dal Tempio, Lettura 77.
Le controversie di Gerusalemme hanno per oggetto non più la Legge e le sue applicazioni, ma il Tempio o la sua gestione in quanto tale.
Anche qui come in Galilea è in gioco l'autorità /exousia di Gesù, tant'è che proprio in questo brano gli viene posta la domanda strategica: «Con quale autorità / exousia fai queste cose?».
A Gerusalemme cambiano gli oppositori: mentre in Galilea erano scribi, farisei e in minima parte erodiani, qui troviamo: sommi sacerdoti, sadducei, anziani, scribi quali rappresentanti del Sinedrio e farisei.
Il Sinedrio era la massima autorità religiosa di Israele. In definitiva tutte le autorità religiose della Città Santa erano contro Gesù in modo perfino articolato e con attacchi studiati a tavolino.
Dobbiamo spendere due parole di confronto tra la figura dei discepoli e quella degli oppositori.
Dei discepoli sappiamo molte cose. Di Pietro, ad esempio, sappiamo che faceva il pescatore, aveva un fratello di nome Andrea, conosciamo il nome del padre; aveva anche una suocera, per cui era sposato; abitava a Cafarnao presso il Mare di Galilea e nel corso della lettura abbiamo compreso che aveva un carattere irruente e voleva vederci chiaro nelle cose con cui veniva in relazione. E questo vale per tutti gli altri che non restano personaggi anonimi.
Degli oppositori invece non sappiamo nulla; non abbiamo nomi, non sappiamo da dove provengano, di cosa vivano. Emergono quasi all'improvviso, senza riferimenti, senza una storia o qualcosa che ne definisca la personalità. Quasi delle voci che vagano ameboidamente nell'aria... ma con grande capacità di ordire intrighi di nascosto.
In questo brano si presentano sommi sacerdoti, scribi, cioè gli esperti delle Scritture e gli anziani che pongono a Gesù la domanda delle domande, cioè la provenienza della sua exousia.
Se abbiamo ben capito, la strategia di Gesù è quella di non rispondere alla domanda del Sinedrio, ma di calare il problema nella antica questione del rapporto tra autorità religiose e profeti o tra la religione dei riti e religione di una vita buona; quest'ultima è sempre stato l'obiettivo perseguito appunto dai profeti. I quali hanno quasi sempre fatto una brutta fine; ultimo della serie Giovanni Battista.
Allora sono poste a confronto o addirittura in conflitto, l'autorità del Sinedrio contro l'autorità di Gesù.
E Gesù, capito subito la loro malizia, evita la risposta spostando la questione sull'autorità con cui profetava Giovanni Battista: proveniva da Dio o da istanze umane?
In questo modo Gesù pone un dilemma ai suoi interlocutori che così non sono in grado di rispondere.
C'è un principio antropologico fondamentale che Gesù conosce molto bene: se vuoi comprendere il senso di un evento, di un avvenimento, di qualcosa che lì si mostra, devi anticipargli un consenso, altrimenti non vedrai mai niente. O meglio: continuerai a vedere quello vuoi vedere tu. La saggezza popolare lo traduce dicendo che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.
Come per talk show televisivi per i quali, quando non vedi quello che vuoi vedere, pigi un tasto e cambi canale.
Lettura 80 Mc 12, 1- 12 Seconda controversia: i vignaioli omicidi
Mc 12:1 E cominciò a parlare loro in parabole:
«Un uomo piantò una vigna, vi pose attorno una siepe, scavò un torchio, costruì una torre (Is 5,1ss), poi la diede in affitto a dei vignaioli e parti per un viaggio. 2 A suo tempo inviò un servo a ritirare da quei vignaioli i frutti della vigna. 3 Ma essi, afferratolo, lo bastonarono e lo rimandarono a mani vuote. 4 Inviò loro di nuovo un altro servo: anche quello lo picchiarono sulla testa e lo coprirono di insulti. 5 Ne inviò ancora un altro, e questo lo uccisero; e di molti altri, che egli ancora mandò, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. 6 Aveva ancora uno, il figlio diletto: lo inviò loro per ultimo, dicendo: Avranno rispetto per mio figlio! 7 Ma quei vignaioli dissero tra di loro: Questi è l'erede; su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. 8 E afferratolo, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. 9 Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. 10 Non avete forse letto questa Scrittura: La pietra che i costruttori hanno scartata / è diventata testata d'angolo;/ 11 dal Signore è stato fatto questo/ ed è mirabile agli occhi nostri?» (Sal 118,22-23).
12 Allora cercarono di catturarlo, ma ebbero paura della folla; avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. E, lasciatolo, se ne andarono.
Questa parabola è in effetti un'allegoria della quale non è difficile individuare gli elementi cui rimanda: la vigna rappresenta il popolo mentre i vignaioli sono la classe dirigente, civile e religiosa, cioè gli interlocutori di Gesù, che ricordiamo, sono membri del sinedrio più dei farisei.
Essa contiene una novità che solo la Rivelazione definitiva, quella portata dal Figlio, poteva annunciare e la possiamo cogliere se la confrontiamo, ad esempio, con quella del profeta Isaia. Teniamo presente che il paragone tra il popolo di Israele e la vigna è un modello usato da diversi profeti. Quello di Isaia è forse il più noto perché ricorre nella liturgia.
Is 5:1 «Canterò per il mio diletto / il mio cantico d'amore per la sua vigna.
Il mio diletto possedeva una vigna / sopra un fertile colle. /
2 Egli l'aveva vangata e sgombrata dai sassi / e vi aveva piantato scelte viti;
vi aveva costruito in mezzo una torre / e scavato anche un tino.
Egli aspettò che producesse uva, / ma essa fece uva selvatica.
3 Or dunque, abitanti di Gerusalemme / e uomini di Giuda, / siate voi giudici fra me e la mia vigna.
4 Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna / che io non abbia fatto?
Perché, mentre attendevo che producesse uva, / essa ha fatto uva selvatica?
5 Ora voglio farvi conoscere / ciò che sto per fare alla mia vigna:
toglierò la sua siepe / e si trasformerà in pascolo; / demolirò il suo muro di cinta / e verrà calpestata.
6 La renderò un deserto, / non sarà potata né vangata
e vi cresceranno rovi e pruni; / alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia.
7 Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti / è la casa di Israele; / gli abitanti di Giuda
la sua piantagione preferita. / Egli si aspettava giustizia / ed ecco spargimento di sangue,
attendeva rettitudine / ed ecco grida di oppressi».
Non vogliamo confrontare tutti gli elementi allegorici che compongono i due testi, ma solo il soggetto trattato e la conclusione.
Nell'antico testo la vigna rappresenta Israele nel suo insieme, che viene distrutto per le sue infedeltà.
Nella parabola di Gesù viene introdotta la differenza tra la vigna / popolo e la classe dirigente: politica e religiosa.
La vigna / popolo è così preziosa che perfino il Figlio viene inviato per raccoglierne i frutti. Solo i vignaioli infedeli saranno sterminati, mentre la vigna / popolo, sarà affidata ad altri agricoltori che le facciano produrre molti frutti. La vigna è il grande tesoro di Dio che Egli vuole salvaguardare ad ogni costo: costi quel che costa: perfino la vita del Figlio vien spesa per la sua salvezza.
Così anche Gesù non ha parole di biasimo per la vigna / popolo con il quale ha condiviso tutta la sua vita e per il quale ha speso giorni e giorni di predicazione. Le sue rampogne sono destinate a coloro che dovrebbero avere cura della vigna / popolo, ma che di esso non si curano; la cosa sarà ancor più evidente in Mc 12,41ss, che esamineremo più avanti.
Ora, questi testi pur nella loro asprezza, sono un ultimo tentativo da parte di Gesù di "convertire" i suoi oppositori, ma la loro ipocrisia fatta di domande tranello, erigono una barriera impenetrabile che porterà inevitabilmente allo scontro finale. Che nel nostro brano è chiaramente annunciato. E potremmo chiamarlo quarto annuncio della passione.
E più che in altri passaggi è altresì evidente l'annuncio della risurrezione:
La pietra che i costruttori hanno scartata / è diventata testata d'angolo;
11 dal Signore è stato fatto questo/ ed è mirabile agli occhi nostri?» (Sl 118,22-23).
Che tuttavia solo ad eventi compiuti, cioè, solo dopo Pasqua, avrebbero potuto essere compresi pienamente.
Ovviamente sempre da parte di chi era disposto a coglierli.
Lettura 81 Mc 12, 13- 17 Terza controversia: l'immagine di Cesare
Mc 12,13 «Gli mandarono però alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. 14 E venuti, quelli gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno; infatti non guardi in faccia /prosōpon agli uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?». 15 Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia / upokrisin, disse: «Perché mi tentate? Portatemi un denaro perché io lo veda/idō ». 16 Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Di chi è questa immagine/eikōn e l'iscrizione?». Gli risposero: «Di Cesare». 17 Gesù disse loro: «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio». E rimasero ammirati di lui».
Se leggiamo questo brano pensando al rapporto tra autorità civile ed autorità religiosa saremmo fuori strada perché si tratta di tematiche che sarebbero sorte secoli dopo. Dobbiamo perciò fare lo sforzo di contestualizzare il testo.
Gli ebrei pensavano e volevano uno stato teocratico esattamente come i romani che, sebbene all'inizio avessero istituito una repubblica, venuti a contatto con i paesi del Vicino Oriente finirono per pensare che anche il loro imperatore fosse divino. Tanto che l'epigrafe scritta sulla moneta di cui parla il nostro brano recitava: TIBERIUS CAESAR DIVI AUGUSTI FILIUS AUGUSTUS, cioè: "Tiberio Cesare figlio del divino Augusto, lui stesso Augusto". Sull'altro lato c'era la scritta: PONTIFEX MAXIMUS: Pontefice Massimo. In altre parole l'Imperatore era assimilato ad un dio e inoltre svolgeva il ruolo di sommo sacerdote della religione romana. Incidentalmente ricordiamo che durante le persecuzioni dei cristiani il segno di lealtà all'Impero era contrassegnato dal gettare un pugno di incenso sul braciere che ardeva davanti all'immagine dell'imperatore. L'incenso era allora l'offerta riservata esclusivamente agli dèi.
Allora lo scontro tra ebrei e romani non era solo politico ma più radicalmente religioso e questo è il retroterra che alimenta la polemica tra coloro che accettano di pagar il tributo a Cesare e quelli che vorrebbero rifiutarlo.
Nel caso in questione dobbiamo ricordare che in Giudea governava un procuratore romano, Ponzio Pilato, mentre in Galilea governava Erode Antipa, figlio di Erode il grande, quello della strage degli innocenti. In realtà Erode Antipa era un re condizionato perché il suo potere gli era stato concesso da Roma, brutalmente, un funzionario romano, quindi gli erodiani, per ovvi motivi politici, sostenevano che si dovesse pagare il tributo a Cesare. Invece i farisei erano decisamente contrari a questa pratica perché di fatto accettava la sottomissione a Roma.
Così vediamo chiaramente che i due gruppi sono disposti a mettersi insieme pur di tendere un tranello a Gesù.
Il nostro testo dice che Gesù riconobbe subito l'ipocrisia dei suoi interlocutori, ma ipokrisin è un termine che possiede diversi significati: recitazione, sostenere una parte, declamazione, istrione, attore.
Allora possiamo dire che questi interlocutori sono ipocriti perché sono "attori" che sostengono la parte che è stata loro assegnata nel conciliabolo con i capi di Gerusalemme.
Il testo richiama anche un altro termine che ha a che fare con il teatro, cioè prosōpon: faccia, aspetto, atteggiamento, figura, maschera, personaggio. Ci interessa "maschera" perché a quel tempo gli attori indossavano sempre una maschera che copriva la faccia.
In definitiva questi interlocutori non si presentano con la loro "faccia", ma sono "attori" che indossano una "maschera".
E Gesù compreso al volo le loro reali intenzioni sposta il discorso dalla faccia / maschera a immagine.
Il tema dell'immagine / eikōn viene da molto lontano perché è ciò che collega l'uomo al suo Creatore, Dio, e infatti lo troviamo nel libro di Genesi, e ci riferiamo al termine usato dalla LXX:
Gn1,27 «Dio creò l'uomo a sua immagine (eikōn) ; / a immagine (eikōn) di Dio lo creò; / maschio e femmina li creò».
L'immagine, non è una fotografia e nemmeno un ritratto, ma molto di più; potremmo dire che è l'insieme di visioni, sentimenti, esperienze, storie, incontri, legami affettivi e molto altro ancora, che con una persona abbiamo condiviso.
Se è così, cos'ha in comune la nostra immagine con l'immagine di Dio?
La teologia ha dato molte risposte: l'amore, la relazione, il fatto di essere anche noi faber, la sete di sapere, il bisogno insaziabile di amore, ecc.
In breve la nostra somiglianza con Dio non può essere definita: Lui è indefinibile, ma anche l'uomo è indefinibile.
E tuttavia la fede ci dice che siamo simili: siamo fatti a Sua immagine.
Per contro l'immagine presente sulla moneta, cosa dice di Cesare? Nulla. Proprio un bel niente. Quella moneta vale solo per le cose che con essa posso comprare.
Quindi un rapporto tra queste due immagini è infinitamente sproporzionato.
E quegli interlocutori, attori, presi in contropiede, se ne vanno con la coda tra le gambe.
Lettura 82 Mc 12, 18- 27 Quarta controversia: la risurrezione dei morti
Mc 12,18 «Vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogarono dicendo: 19 «Maestro, Mosè ha scritto per noi che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello ne prenda la moglie per dare discendenti al fratello (Dt 25,5-6; Gn 38,8). 20 C'erano sette fratelli: il primo prese moglie e morì senza lasciare discendenza; 21 allora la prese il secondo, ma morì senza lasciare discendenza; e il terzo egualmente, 22 e nessuno dei sette lasciò discendenza. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. 23 Nella risurrezione, quando risorgeranno, a di chi di loro sarà moglie? Poiché in sette l'hanno avuta come moglie». 24 Rispose loro Gesù: «Non siete voi forse in errore dal momento che non conoscete le Scritture, né la potenza di Dio? 25 Quando infatti risorgono dai morti, (gli uomini) non sposano né (le donne) sono sposate, ma saranno come angeli nei cieli. 26 A riguardo poi dei morti che risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, a proposito del roveto, cosa Dio gli ha detto: "Io [sono] il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe"?(Es 3,6) 27 Non è un Dio dei morti ma dei viventi! Voi siete in grande errore».
I sadducei erano la classe aristocratica più ricca di Israele, molto legati alle loro proprietà e al tempio, tanto che durante il regno di erode il grande e quello successivo dei procuratori romani erano sempre riusciti ad avere il Sommo sacerdote proveniente dal loro gruppo.
Essi non consideravano canonica tutta la Bibbia, ma solo il Pentateuco cioè i primi cinque libri, che si riteneva, fossero stati scritti da Mosè; tutti gli altri: i Libri Storici, i Profeti e i Libri della Sapienza, non erano oggetto di fede.
Ora, i libri del Pentateuco non trattano il tema della risurrezione, per cui essi, come dice il v18, non credevano nella risurrezione.
Uno dei testi su cui era fondata la loro credenza era tratto dai castighi inflitti da Dio all'uomo dopo il peccato nel Giardino, precisamente: Gn 3,19 «... polvere tu sei e in polvere tornerai!». Quindi secondo loro, dopo la morte non ci sarebbe stato più nulla; il corpo sarebbe marcito e dissolto.
Almeno il mondo greco credeva nell'immortalità dell'anima, della quale il corpo era la prigione e, una volta che questo fosse morto, l'anima, finalmente libera, poteva salire nell'Iperuranio, nel Mondo delle Idee, presso il Sommo Bene.
Però anche noi dobbiamo contestualizzare il testo per tentare di comprendere cosa intendessero in quel tempo per risurrezione. Infatti il concetto di risurrezione che abbiamo fatto nostro, dopo gli eventi della Pasqua di Gesù Cristo e 2000 anni di cristianesimo è ben diverso dalle "idee" che circolavano in quel tempo, perché fondato su di un fatto storico e sugli incontri post-pasquali con il Risorto, cioè su dati di esperienza.
Infatti, se esaminiamo l'Antico Testamento troviamo che Dio promette ad Abramo una numerosa discendenza (Gn 12,1-3), ma non gli parla di risurrezione. Quegli antichi Patriarchi ritenevano che la loro vita proseguisse in qualche modo attraverso i loro discendenti, per cui era di estrema importanza avere molti figli. Da qui la "legge del levirato", Dt 25,5-ss. e Gn 38, cui si riferisce il nostro brano. Comunque essi ritenevano che la loro comunione con Dio non sarebbe stata spezzata dalla morte.
Inoltre nelle culture dell'Antico Vicino Oriente circolava un'idea di risurrezione legata alle divinità degli altri popoli che probabilmente era intesa come un portato idolatrico. Si trattava dell'idea di divinità morte in autunno che risorgevano in primavera come spiegazione del ciclo delle stagioni. Così accadeva per Osiride in Egitto, per Tammuz in Mesopotamia e soprattutto per Baal in Canaan, i più stretti vicini di Israele.
Erano miti collegati alla concezione circolare del tempo: un tempo che si ripete indefinitamente anno dopo anno, senza una progressione. In qualche modo idea condivisa anche dal mondo greco.
Questo contrastava radicalmente con la concezione ebraica del tempo, che era ed è "lineare", cioè un'idea secondo la quale c'è un inizio e una fine e tra questi due limiti si dispiega la storia, tema che abbiamo trattato nella riflessione sul libro di Esodo.
In altre parole, gli ebrei inventano la storia che è una delle radici fondamentali della civiltà occidentale.
Il tema della risurrezione, nella Bibbia, si fa strada più tardi, prima con i profeti e soprattutto con l'esperienza maturata durante le guerre dei Maccabei nel terzo e secondo secolo a. C.
I testi di riferimento sul tema della risurrezione nell'Antico Testamento sono:
- la grandiosa visione delle ossa aride che riprendono vita all'udire la Parola pronunciata dal profeta, Ezechiele c. 37.
- Gb 25, 25 «Io lo so che il mio Vendicatore è vivo / e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!
26 Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, / senza la mia carne, vedrò Dio.
27 Io lo vedrò, io stesso, / e i miei occhi lo contempleranno non da straniero».
- Dn 12,1 «Or in quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stato dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. 2 Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna».
- 2 Mac 7; 2 Mac 12 questi sono testi piuttosto lunghi che non riportiamo, ma che raccomandiamo di leggere.
Di che tipo di risurrezione si trattasse non è specificato; forse gli agiografi pensavano ad una ripresa della vita attuale, ma i testi dei Maccabei e di Daniele alludono ad una vita eterna.
Dobbiamo tenere presente che anche nei Vangeli abbiamo personaggi richiamati in vita, però non possiamo parlare di risurrezione, piuttosto di risuscitamento, perché essi poi sarebbero morti, come ad esempio la figlia di Giairo Mc 5,21ss, oppure Lazzaro Gv 11. La risurrezione non è la rianimazione di un cadavere!
La risurrezione in cui credono i cristiani è l'ingresso in una vita nuova, una vita altra, in completa comunione con Dio, così come si intuisce dai racconti di apparizione del Risorto.
Per venire al nostro brano, Gesù non controbatte riferendosi a testi che parlano apertamente di risurrezione, ma rimane sul Pentateuco, i libri che i suoi interlocutori ritengono validi ed esattamente l'inizio del libro di Esodo.
La citazione dell'episodio del roveto ardente da parte di Gesù porta una significativa modifica rispetto alla Bibbia dei LXX , che era quella più conosciuta, la quale riportava il verbo essere che abbiamo posto tra parentesi quadre, [sono], che Egli omette, per cui l'autopresentazione di Dio diventa «Io il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe...», cioè una presentazione senza verbo, il che significa una relazione che era, è e sarà, cioè una relazione ininterrotta.
Quello che Gesù vuole evidenziare è il fatto che una relazione si può tenere solo con persone viventi, non con i morti.
Quando noi pensiamo di essere in relazione con i nostri cari defunti è perché crediamo che da qualche parte essi continuino a vivere.
Poi Gesù mette in chiaro che la vita dei risorti è ben diversa da quella consueta.
Così nel v 25 dobbiamo evidenziare con una traduzione letterale (perduta dalla CEI) che nel matrimonio l'uomo svolge un ruolo attivo perché "sposa la donna", mentre la donna ha un ruolo passivo perché "è sposata", ovviamente, in conseguenza degli accordi stipulati tra il padre e il futuro marito. Allora la condizione dei risorti, illustrata da Gesù, ristabilisce una pari dignità tra i sessi perché i rapporti sono diventati di grande fraternità.
Per quanto riguarda la controversia è evidente il modo ironico, se non ridicolo o provocatorio, con cui la domanda è posta dai sadducei a Gesù, ma Lui non risponde alla stessa maniera, al contrario fa un serio lavoro di esegesi, che in qualche modo ribalta la lettura corrente del Pentateuco.
Questi sono gli ultimi tentavi che il Maestro compie per cercare di convertire anche i suoi oppositori, Lui che non è venuto per salvare solo i buoni, ma per riportare a casa soprattutto i peccatori; e questi che fanno parte della classe dirigente politica e sacerdotale, hanno bisogno di conversione più di tanti altri.
E Lui si è incarnato e venuto al mondo per salvare anche costoro.
Lettura 83 Mc 12, 28- 34 Quinta controversia: il più grande comandamento
Mc 12,28 «Allora si avvicinò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, vedendo che aveva risposto loro bene, lo interrogò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». 29 Gesù rispose: «Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore nostro Dio è (l') unico Signore; 30 amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e con tutta la tua forza (Dt 6,4-5). 31 E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso (Lv 19,18). Non c'è altro comandamento più grande di questi».
32 Allora lo scriba gli disse: «Bene Maestro! Hai detto secondo verità che è Unico e non v'è altri all'infuori di lui (Dt 4,35); 33 e amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto e con tutta la forza e l'amare il prossimo come se stesso val più di tutti gli olocausti e i sacrifici» (1 Sam 15,22). 34 Gesù, vedendo che egli aveva risposto saggiamente, gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno osava più interrogarlo».
A rigore questa più che una controversia è un approfondimento della Legge sulla quale i due interlocutori hanno una sostanziale convergenza.
Già dall'inizio questo scriba, quindi un esperto delle Scritture, si rivolge a Gesù dopo avere sentito con quale abilità e profonda conoscenza della Torah aveva mostrato gli errori interpretativi dei sadducei, come abbiamo visto nella lettura precedente.
Ora, questo scriba chiede qual è "il primo di tutti i comandamenti", ma Gesù ne proclama due.
Questi due comandamenti non sono una novità, perché erano già noti, ma appartenevano a due libri diversi: il primo al Deuteronomio, il secondo al Levitico. Gesù in più compie due operazioni: unisce i due comandamenti e li fa precedere dallo Shemah.
Il primo comandamento impone di amare il Signore (ricordiamo che la Bibbia usa "Signore" per non pronunciare JHWH) con cuore, anima, mente e forza, però quale fosse il significato di ciascuno di questi termini in quel tempo non riusciamo a raggiungerlo con esattezza; basta sfogliare un dizionario filosofico per rendersi immediatamente conto di come i significati di quelle parole siano cambiate nel corso della storia. È una difficoltà che emerge anche consultando i commenti di diversi esegeti, che mostrano molte differenze.
Seguendo la traccia di R. Pesch possiamo dire che:
=> cuore: nel mondo ebraico era considerato il centro della persona umana e allora si tratta di aderire a Dio venerarlo e temerlo con tutta la propria intimità.
=> anima era il principio vitale e allora si tratterebbe amare Dio con tutta la propria vita sottomettendo a Lui la propria volontà, anche fino al sacrificio estremo.
=> mente indica la dedicazione a Dio di tutte le dimensioni razionali.
=> forza significava amare Dio con tutta la propria esistenza, che comprendeva anche tutti i mezzi a disposizione dell'uomo, cioè tutto quello che possedeva, capacità lavorativa, beni economici, ecc.
In forma sintetica e conclusiva possiamo dire che queste quattro dimensioni comandano di amare Dio con tutto se stesso.
Il secondo comandamento prescrive di amare il prossimo come se stesso.
Se il comandamento avesse detto di amare il prossimo come Dio, l'amore per se stessi sarebbe escluso e invece la misura dell'amore per il prossimo è l'amore che nutro per me stesso. Paradossalmente, se non amo me stesso non sono neanche in grado di amare il prossimo.
Ma perché amare il prossimo?
Tutto dipende dal fatto che Dio è la sorgente di ogni amore e io sono chiamato ad amare tutti quelli che Egli ama, quindi non amo il prossimo perché mi è simpatico o perché la pensa come me e via dicendo, ma sono chiamato ad amarlo perché Dio lo ama come Lui ama me e come anch'io amo Lui.
Da qui si vede come i due comandamenti non possano essere separati, ma sono strettamente collegati tra di loro: si rimandano l'un l'altro.
Ma Gesù ha compiuto una seconda operazione: ha fatto precedere i due comandamenti dallo "Shemah". Questo segna l'inizio delle preghiere che i pii israeliti recitano mattina e sera. «Ascolta / shemah Israele il Signore è il nostro Dio il Signore è UNO». In ebraico sei parole martellanti: «Shemah Israel Adonai Elohenu Adonai ehad».
Con questa premessa Gesù vuole ricordarci che l'azione di Dio, il suo amore, non è destinato ad un uomo che vive per conto suo, ma a uomini e donne che vivono insieme e formano una comunità, un popolo.
Se così, ci sono dentro tutti. Ma proprio tutti.
Compreso quello scriba al quale dice: «Non sei lontano dal regno di Dio».
Però gli manca qualcosa. Ma cosa?
Lettura 84 Mc 12, 35- 37 Il Messia più grande di David
Mc 12,35 Gesù prendendo la parola continuava ad insegnare nel tempio: «Come mai dicono gli scribi che il Cristo / Messia è figlio di David? 36 Davide stesso infatti ha detto, mosso dallo Spirito Santo:
Disse JHWH/ Signore al mio Signore:/ Siedi alla mia destra/ affinché io ponga i tuoi nemici /
come sgabello ai tuoi piedi.
37 Davide stesso lo chiama Signore: come dunque può essere suo figlio?». E la numerosa folla lo ascoltava volentieri.
In questo passaggio Gesù non ha più oppositori, ché se ne sono andati, ma riprende ad insegnare al popolo che lo ascolta volentieri. Egli approfitta dell'attenzione degli ascoltatori per consegnare alcune precisazioni sulla sua figura di Messia / Cristo.
Però dobbiamo chiederci: quali idee potevano nutrire i suoi concittadini a riguardo del Messia atteso?
La monarchia era finita da 500 anni, prima i persiani, poi i greci, infine i romani andavano e venivano facendo quello che volevano. A loro era rimasto solo tempio con i suoi sacerdoti. E tutte le promesse antiche quando si sarebbero realizzate?
Si sapeva che il Messia sarebbe stato della casa di David secondo quanto promesso da Dio in 2 Sam 7 (bisogna leggere tutto il capitolo).
Nelle nostre letture abbiamo trovato la confessione di fede di Pietro nella Lettura 57:
8,29 «Ma Gesù replicò: «E voi chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo»;
e questo, secondo le antiche promesse, implica la discendenza da David.
Anche il cieco di Gerico lo chiama «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» 10,47, Lettura 73.
Un po' più avanti nell'entrare in Gerusalemme dal Monte degli Ulivi la folla grida:
11,10 Benedetto il regno che viene, del nostro padre Davide! / Osanna nel più alto dei cieli!» Lettura 75.
In definitiva tutti si aspettavano un Messia "figlio di David" che avesse le caratteristiche promesse agli antichi padri ma come lo immaginavano?
Riteniamo che il Salmo 110, quello stesso citato e commentato da Gesù, ci possa aiutare a comprendere l'insieme di tutte quelle attese.
Sal 110, 1 «Di David. Salmo. Oracolo di JHWH al mio signore: "Siedi alla mia destra,
/ affinché io ponga i tuoi nemici / a sgabello dei tuoi piedi
2 Lo scettro del tuo potere / stende JHWH da Sion, / domina in mezzo ai tuoi nemici!.
3 Il tuo popolo si impegna volontariamente / nel giorno della tua parata militare, /
negli splendori della santità (divina).
Dal grembo dell'aurora / è a te la rugiada della tua giovinezza ( Cei, LXX: come rugiada ti ho generato. /
4 JHWH ha giurato e non si pente: / "Tu sei sacerdote in eterno al modo di Melchisedek".
5 Il Signore è alla tua destra! / Egli (il re) abbatterà i re nel giorno della sua ira,
6 eseguirà il giudizio tra le nazioni / ammucchierà i cadaveri / abbatterà teste su vasta terra.
7 Lungo il cammino si disseta al torrente, / e solleva alta la testa».
Questo è un salmo di intronizzazione, cioè che viene cantato, o ricorda, il giorno in cui il re viene incoronato.
Il salmo è attribuito a Davide al quale JHWH, il Signore, comunica questo oracolo. Ricordiamo che l'ebraico scrive solo le consonanti delle parole e quando si incontra il nome di JHWH, legge "Adonai" cioè: "Signore" e così le nostre bibbie scrivono direttamente "Signore", ma noi dobbiamo in alcuni casi sottintendere: JHWH.
Nelle culture antiche l'incoronazione dei re era attribuita sempre a una divinità. Nella maggior parte dei popoli vicini il re diventava figlio di uno degli dèi del paese o addirittura egli stesso dio. Anche all'Imperatore di Roma da un certo punto in poi gli viene attribuita la divinità; ne abbiamo trattato alla Lettura 81.
Ovviamente un'idea di questo tipo contrastava radicalmente con la tesi della trascendenza del Dio di Israele, tuttavia anche in questo salmo il v 3, secondo alcuni codici accennerebbe ad una filiazione divina, certo da intendersi in senso simbolico.
D'altra parte Israele in qualche modo viene influenzato dalle culture dei suoi vicini, per cui la caratteristica del nuovo re è quella di sedere alla destra di Dio, anche se alcuni esegeti lo attribuiscono al fatto che il palazzo reale si trovasse alla destra del tempio.
Al v 5 troviamo che è Dio a trovarsi alla destra del re, quindi il re dispone di tutta la potenza divina. Cosa che gli permette anche di avere tutti i nemici come "sgabello dei suoi piedi". Non solo, sarà anche in grado di abbattere le nazioni e fare montagne di cadaveri e mucchi di teste dei suoi nemici.
L'ultimo versetto è alquanto è in tensione con quello che precede perché il re si ferma ad un torrente per bere acqua fresca. Una nota di pace che contrasta radicalmente con i testi dei paesi vicini perché in essi, il nuovo re beveva il sangue dei nemici uccisi. Qualche studioso lo spiega dicendo che il re proviene in corteo dalla valle del Cedron, che sta fra Gerusalemme e il Monte degli Ulivi.
E ancora una volta abbiamo a che fare con il Monte degli Ulivi, quindi ancora un re pacifico.
Tanto più che questo re è anche sacerdote "alla maniera di Melchisedek". Questi è uno strano re, ma altresì sacerdote, che appare all'improvviso dopo che Abramo aveva sconfitto una coalizione di re avversari nella valle del Giordano.
Gn 15, 18 «Intanto Melchisedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo 19 e benedisse Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, / creatore del cielo e della terra,20 e benedetto sia il Dio altissimo,/ che ti ha messo in mano i tuoi nemici». / Abram gli diede la decima di tutto».
Dove Salem sta per pace, ma è anche la finale di Jerusalem, infatti Jer: città e salem: pace da cui Gerusalemme: Città della pace, quindi egli era re di Gerusalemme e il suo nome Melch: re e Sedek: giusto, cioè "re giusto".
Così la figura del Messia è caricata di tutte queste attese.
Nel nostro brano Gesù non fa un corso accelerato sulla sua figura di Messia, ma mette a fuoco solo la sua filiazione da cui risulta che Egli e "Signore" anche di David e quindi ben di più che suo figlio.
Ancora Gesù non si dichiara apertamente "Figlio di Dio", ma abbiamo già trovato due manifestazioni della sua figliolanza divina:
=> al Battesimo nel Giordano 1,9-11, Lettura 9;
=> nell'episodio della Trasfigurazione 9,2-13, Lettura 61.
=> nel racconto del cieco di Gerico, Bartimeo che lo supplica: 10, 47 E udendo che c'era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Lettura 73.
Sarà anche riconosciuto come tale dal centurione che lo aveva crocifisso 15,39.
=> Egli proclamerà chiaramente la sua figliolanza divina solo davanti al Sommo Sacerdote che farà in modo condannarlo alla croce perché sia chiaro a tutti che Egli è il Figlio di Dio crocifisso.
Mc 14, 61 «Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?». 62 Gesù rispose: «Io lo sono! / E vedrete il Figlio dell'uomo
seduto alla destra della Potenza/ e venire con le nubi del cielo».
1- Noi abbiamo fatto una lettura storica del Salmo 110, ora lasciamo al lettore il compito di rileggerlo in chiave cristologica.
2- Abbiamo terminato la lettura precedente chiedendoci cosa mancasse allo scriba al quale Gesù aveva detto: "non sei lontano dal Regno di Dio", chiedendoci ma cosa gli mancava per esserci dentro?
Forse gli mancava di riconoscere che Gesù era figlio di Dio?
3- E allora agli Apostoli cosa pensavano, dato che durante tutte le dispute sono spariti?
Lettura 85 Mc 12, 38- 40 Ipocrisia degli scribi
Mc 12,38 «E molta gente lo ascoltava volentieri. E nel suo insegnare diceva: «Guardatevi dagli scribi, che amano camminare in lunghe vesti (en otolaìs), e ambiscono i saluti nelle piazze, 39 i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 40 Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per ostentazione. Essi riceveranno una condanna più grave».
Gesù continua ad insegnare nel Tempio è molta folla lo ascolta. Anche in questa lettura ritroviamo il tema degli scribi che sono accusati di ipocrisia, cioè cercano di mostrarsi più importanti, santi e pii di quanto non lo siano realmente. Gesù li accusa di sei atteggiamenti falsi.
1- L'abito non ha solo una funzione protettiva dalle condizioni atmosferiche, ma altresì denotativa. Oggi, forse, questo aspetto è meno palese perché si è diffuso il "casual" a tutti i livelli, ma in certi ambienti "l'abito fa il monaco". Le sfilate di moda mostrano abiti che chi li compra certamente non usa i mezzi pubblici e probabilmente li indosserà una sola volta.
Gesù allude al fatto che si stava diffondendo l'uso di indossare particolari abiti, forse usati nei giorni di sabato e di festa, ma sembra di capire che gli scribi ostentassero questi vestiti tutti i giorni. Tuttavia l'esatto significato del termine greco "en otolaìs" non è conosciuto, è comunque chiaro che si tratta di un abbigliamento ostentativo finalizzato a primeggiare.
2- Nelle piazze essere salutati per primi come segno di deferenza o sottomissione.
4- Primi posti nei banchetti sono quelli prossimi all'ospitante, cosa particolarmente significativa se il banchetto avviene alla maniera romana sul triclinio, cioè sdraiati.
Tutte queste accuse evidenziano la brama di guadagnare un primato sociale e politico.
3- Sembra che nelle sinagoghe ci fossero dei posti riservati alle persone di riguardo con sedili su pedane rialzate, muniti di schienale e braccioli, sicché gli utilizzatori erano ben visibili da tutti.
6- L'ultima accusa è molto sottile, perché si tratta di utilizzare la preghiera non per parlare con Dio, ma per acquistare fama di santità e quindi di emergere sopra gli altri.
Queste accuse rivelano l'idea di raggiungere un primato religioso, una fama di santità.
5- Divorare le case della vedove. Gli scribi in greco grammateis, sono gli esperti delle scritture, quindi della Legge, per cui esercitano una funzione simile a quella dei nostri avvocati. E allora può accadere che nelle successioni, l'eredità possa essere sottratta egli eredi più deboli, le vedove, appunto.
Questa accusa segnala l'intenzione di conquistare un primato economico ottenuto anche con mezzi illeciti
Questi comportamenti sono da Gesù considerati gravi tanto da meritare una punizione molto pesante.
Tutto ciò perché essendo gli scribi collocati tra i maestri d'Israele, i loro comportamenti dovrebbero essere di insegnamento e di aiuto per le persone più deboli facendo corrispondere l'insegnamento al comportamento.
In altri parole Gesù sta designando la figura dell'antidiscepolo, se il discepolo, come abbiamo visto, è colui che si pone a servizio degli altri cercando e rimanendo all'ultimo posto al servizio di tutti 9,33-37, Lettura 64; 10,35-45, Lettura 72; proprio come ha fatto e farà Lui, il vero Maestro.
Gesù però non ha parlato di "tutti gli scribi" e ciò significa che non sono condannati in blocco e così abbiamo forse individuato cosa mancava allo scriba al quale aveva detto: «Non sei lontano dal Regno di Dio» 12,34 Lettura 83.
Ma questo non vale anche per tutti i discepoli?
Lettura 86 Mc 12, 41- 44 L'obolo della vedova povera
Mc 12,41 «E sedutosi davanti al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E molti ricchi ne gettavano molte. 42 Ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quadrante. 43 Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «Amen (in verità) vi dico: questa povera vedova ha gettato nel tesoro più di tutti quelli che hanno gettato nel tesoro. 44 Poiché tutti hanno gettato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».
Il testo gioca non casualmente sul verbo gettare / ballō, riportato sette volte; anche l'aggettivo "tutto" riportato quattro volte agisce per contrasto con il poco: "due spiccioli / lepton", la più piccola moneta di rame accettata dal tempio.
Abbiamo giù avuto modo di dire che al Tempio erano accettate solo monete ebraiche, i sicli, in uso anche oggi in Israele con il nome originario di shequel. Tuttavia in Israele circolavano anche altre monete e Marco avverte il bisogno di permettere al lettore di apprezzare il valore di quelle due monetine paragonandolo con una moneta di uso più diffuso, vale a dire il quadrante romano, utilizzato in tutto l'Impero.
Questo brano, se escludiamo il "Discorso Escatologico" del capitolo 13, è l'ultimo insegnamento impartito da Gesù ai suoi discepoli. È un insegnamento contrassegnato da particolare importanza resa da alcune espressioni e atteggiamenti che caratterizzano l'atteggiamento dei rabbi.
Essi sono:
1- "essere seduto"; il maestro insegna da seduto, in posizione elevata, mentre i discepoli sono accovacciati in terra.
2- proskaleō: chiamare a sé i discepoli, usato da Marco solo tre volte in alcuni punti particolarmente importanti:
8,34 « Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua».
Lettura 60: "Condizioni per seguire Gesù".
9,35 « Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti».
Lettura 64: "Il più grande dei discepoli".
10,42 « Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. 43 Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, 44 e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. 45 Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
Lettura 72: "La richiesta di un posto di prestigio di Giacomo e Giovanni ".
Il terzo atteggiamento consiste nel fare precedere l'insegnamento dallo "Amen", che rimanda alla radicale "roccia", tradotto con "In verità".
Ma cosa è successo di così strepitoso? Non erano più importante le discussioni avvenute poco prima con gli scribi, gli anziani, i farisei alla presenza della folla?
Già, ma quelle, tutto sommato, erano solo discussioni, infatti sono note come. "controversie di Gerusalemme", che probabilmente hanno lasciato tutti gli interlocutori nel loro brodo.
Qui invece non è stata pronunciata una sola parola, ma c'è stata una donna, vedova e povera, che ha donato tutto quello che aveva a Dio. Ella ha posto interamente la sua vita nelle mani di Dio. Senza alcun bla, bla, bla. Esattamente come accade con tutte le donne presenti nei vangeli sinottici, perché le donne capiscono al volo ciò che Gesù intende. Così questa vedova diventa la perfetta discepola.
Però ci dobbiamo anche chiedere se non è anche lei "maestra", perché Gesù non fa altro che mettere in evidenza ciò che lei ha fatto.
Questa donna anticipa quello che Gesù farà dopo un paio di giorni, quando consegnerà la sua vita alle autorità, in obbedienza al disegno del Padre.
In questo modo appare dirompente il confronto con i personaggi precedenti:
- quelli che avevano trasformato il Tempio in "una spelonca di ladri" 11,15
- quelli che "divorano le case delle vedove" 12,40
- quelli che si fanno venire l'ulcera per decidere se dare o no la moneta a Cesare 12,13ss.
- quelli che cercano i primi posti 12,39
- quelli che si preoccupano dell'esito dei rapporti matrimoniali nel mondo dei risorti 12,18 ss. anche perché loro sapevano già tutto dell'al di là.
Tante discussioni, tante diatribe, tante controversie che fanno perdere di vista la "pietra angolare" 12,10.
E non si rendevano conto che essa era lì sotto il loro naso.
L'unica che l'aveva colta è stata questa donna nella sua povertà e semplicità.
In verità c'è stato anche un uomo dalle parti di Gerico, cieco, (guarda un po'), che come questa vedova ha buttato tutto quello che aveva, cioè il mantello e poi si è messo a seguirlo, 10,46, Lettura 73.
Due figure che racchiudono queste intense giornate di Gerusalemme e dovrebbero fare arrossire parecchi interlocutori di Gesù... e forse anche qualche discepolo.
Lettura 87 Mc 12, 41- 44 Gesù e il tempio
Mc 13:1 «Mentre usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!». 2 Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su pietra, che non sia distrutta».
Questo brano secondo l'esegesi corrente è posto, giustamente, come inizio del "Discorso escatologico", ma non possiamo omettere il fatto che sia strettamente collegato a questi tre giorni trascorsi da Gesù a Gerusalemme all'interno del Tempio e che pertanto esso non sia anche la conclusione dei racconti che riguardano direttamente il sacro edificio. Cerchiamo di riprendere tutto in forma sintetica.
È ormai la tredicesima lettura che vede Gesù a Gerusalemme e più esattamente nel Tempio o in qualche modo riferito al Tempio. Tutto si svolge nell'arco di tre giorni.
Il primo giorno Gesù e i suoi provengono da Betania situata sulle pendici del Monte degli Ulivi. Entrano a Gerusalemme da Oriente e Gesù viene accolto dalla folla in modo trionfale.
Quindi si reca al Tempio e «dopo avere guardato attentamente ogni cosa, essendo l'ora tarda, uscì con i Dodici diretto a Betania» (11,11). Fermarsi di notte in città era per lui troppo pericoloso.
Stranamente il Maestro che più volte si è ritirato in solitudine nel deserto, o sul monte a pregare, arrivato al Tempio, la casa di Dio, dove stava la Gloria / Kavod... nessuna preghiera!
Il secondo giorno sulla strada da Betania a Gerusalemme, abbiamo l'episodio della maledizione del fico che ha solo foglie e nessun frutto. Ma era fuori stagione. E abbiamo definito questo gesto "azione simbolica", cioè un'azione non fine a se stessa, ma che rimanda ad altro (11,12-14).
Giunto a Gerusalemme si reca ancora al Tempio che trova affollato di cambiavalute, venditori, ecc. che scaccia brutalmente rovesciando i loro tavoli e tutte le loro cose, disperdendoli. «E insegnava loro dicendo: "non sta forse scritto: La mia casa sarà chiamata casa di preghiera e voi ne avete fatta una spelonca di ladri» (11,17).
Sommi sacerdoti e scribi l'osservano da lontano e decidono di farlo fuori, mentre la gente è ammirata dal suo insegnamento.
Anche in questo caso nessuna preghiera nel Tempio.
A sera ritorna a Betania con i discepoli. Sempre per motivi di sicurezza.
Il terzo giorno si recano ancora a Gerusalemme e per strada passano presso il fico maledetto il giorno prima, che in ventiquattrore è seccato fino alle radici. Non viene chiarito il motivo di questa azione simbolica, che resta al lettore identificare, ma troviamo un insegnamento sulla forza della preghiera e della fede per compiere gesti di quel tipo.
Entrati nel Tempio viene posta a Gesù una domanda da parte di sommi sacerdoti, scribi e anziani, in sostanza le massime autorità del Sinedrio, a riguardo dell'origine della sua autorità. Domanda che resta senza risposta (Lettura 79).
Poi Gesù racconta la "parabola dei vignaioli omicidi" apprezzata dalla folla, ma diretta contro le autorità del Tempio, le quali cercano addirittura di catturarlo, tuttavia l'operazione non riesce per paura della folla (Lettura 80).
A questa segue una terza controversia intavolata da farisei ed erodiani, il cui tema riguarda le tasse da pagare a Roma. Anche in questo caso essendo evidente che si tratta di un tranello Gesù risponde in modo tale da mettere nel sacco gli interlocutori (Lettura 81).
A questo punto arrivano i sadducei che con un racconto polemico tentano di deridere il tema della Risurrezione dei morti. Anche in questo caso, facendo un'esegesi nuova dei testi di Mosè, Gesù li costringe ad andarsene sconfitti (Lettura 82).
La quinta controversia riporta la domanda non polemica di uno strano scriba, esperto della Legge, alla quale Gesù risponde in modo pertinente. Il racconto termina con le parole del Maestro: «Non sei lontano dal Regno di Dio» (12,34- Lettura 83).
Poi Gesù si mette ad insegnare senza più interlocutori polemici e la "folla lo ascolta volentieri".
Da ultimo Gesù osserva la folla che getta le monete nel tesoro del tempio ed individua una vedova molto povera, che vi getta tutto quello che possiede: due centesimi. La sua relazione con Dio fa sì che essa venga proposta ai suoi discepoli con "vera discepola", addirittura "maestra" dei discepoli.
Se è così, allora il Tempio, non è tutto da buttare.
Eppure il brano di questa lettura termina con una profezia categorica: «non resterà pietra su pietra».
Profezia che realizzerà puntualmente meno di quarant'anni dopo nel 70 d. C.
Non è che forse con tutti questi passaggi Marco vuole indicarci nel suo linguaggio essenziale, che costringe il lettore a riflettere, quello che Giovanni riporta in modo esplicito nel dialogo tra Gesù e la samaritana?
Gv 4,19 «Gli replicò la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. 20 I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». 21 Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre. 22 Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 23 Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. 24 Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità».
Se è così i veri discepoli non hanno bisogno di alcun tempio.
Lettura 88 Mc 13 Introduzione al discorso escatologico
Una lettura veloce di Mc 13 solitamente lascia perplesso o sconcertato il lettore perché dà l'impressione di non avere né capo né coda.
Gli stessi studiosi sono in disaccordo nel cercare di definirne il genere letterario. Per alcuni si tratta di un discorso d'addio, per altri un testo apocalittico, per altri un discorso escatologico. Vero è che in esso sono contenuti più generi letterari, ma risulta difficile definire quale sia quello dominante.
È altresì vero che esso non riferisce un preciso discorso tenuto da Gesù in quell'ultima settimana, ma si tratta piuttosto di opera redazionale che ha raccolto parole di Gesù pronunciate in situazioni e tempi differenti. Ciò non toglie che alla vigilia della sua passione non abbia lasciato ai suoi discepoli delle raccomandazioni finali, una sorta di discorso di addio.
Però tutte queste considerazioni rientrano nella logica del metodo storico critico che abbiamo utilizzato altre volte per quel tanto che ci è servito per migliorare la comprensione del testo, ma noi abbiamo sempre seguito il metodo sincronico, che legge il testo così come ci è pervenuto.
Resta comunque la difficoltà di comprendere questo capitolo che gli studiosi sono ad ogni modo concordi nel definirlo come il più difficile di Marco.
Per il lettore odierno riteniamo che la difficoltà maggiore risieda nella sua struttura che non segue i nostri canoni.
Dobbiamo tenere presente che per organizzare un'opera letteraria noi disponiamo di capitoli, paragrafi, segni d'interpunzione, parentesi, spazi, ecc. Gli antichi non disponevano di tutti questi strumenti e oltretutto scrivevano le parole tutte attaccate, ma malgrado questi limiti, riuscivano a strutturare gli scritti sistemando in un certo modo gli argomenti.
Mentre noi, in genere, poniamo prima le premesse e alla fine riportiamo la conclusione cioè, l'elemento più importante, essi usavano parole gancio, parole ripetute che costituivano una sorta di filo rosso che guidava il lettore, ripetizioni di argomenti e disponevano in modo particolare gli argomenti tanto da permettere di individuare facilmente la parte più importante.
Quindi se vogliamo comprendere questo capitolo di Marco dobbiamo fare lo sforzo di approcciare il metodo che ha usato il suo autore.
Troviamo anzitutto quattro versetti che hanno solo una funzione di ambientazione. "Solo", si fa per dire, se teniamo presente quanto detto nella lettura precedente.
Mc 13:1 «Mentre usciva dal tempio, un discepolo gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!». 2 Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non rimarrà qui pietra su pietra, che non sia distrutta». 3 Mentre era seduto sul monte degli Ulivi, di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte: 4 «Dicci, quando accadrà questo, e quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per compiersi?».
Se la lettura precedente ha messo in campo la fine di una relazione tra Dio e il suo popolo imperniata nel Tempio, questi versetti ribadiscono che Gesù è uscito dal Tempio e poi si trova seduto sul Monte degli Ulivi. Tanto per cambiare si è diretto verso Oriente.
Il frequentatore della Bibbia non può perdere di vista che si tratta della direzione seguita dalla Gloria /Kavod quando alla vigilia della caduta di Gerusalemme attorno al 580 a. C. abbandona il Tempio e la Città Santa, Ez 10,18ss. Lettura 74
Allora non siamo fuori strada se affermiamo che anche in questo passo si segnala che la Gloria di Dio / Gesù ha abbandonato ancora una volta il Tempio e la Città Santa.
Seduto presso il Monte degli Ulivi viene interrogato da quattro dei suoi discepoli. Tra di essi i soliti Pietro, Giacomo, Giovanni, quelli presenti nei momenti cruciali del vita del Maestro, i momenti rivelativi.
1- sono i primi chiamati a seguirlo mentre stavano facendo il loro mestiere di pescatori presso il Mare di Galilea, 1,13ss; Lettura 13.
2- sono presenti quando viene risuscitata la figlia di Giairo 5,37; Lettura 39.
3- erano presenti sul monte quando è avvenuta la Trasfigurazione 9,2 ss; Lettura 61.
4- saranno presenti nell'orto del Getzemani quando Gesù svolgerà la sua "battaglia" con il Padre 14,33.
Questo ci avverte che il discorso che Gesù sta per fare è particolarmente importante: è un discorso rivelativo.
In greco "rivelazione" si dice: "Apocalypsis".
16 - marzo - 2019
marzo Lettura 89 Mc 13,5-23 Discorso escatologico. La grande tribolazione
Abbiamo detto che il "discorso escatologico" di Marco, che abbonda di citazioni veterotestamentarie, è molto complesso, ma tentiamo di semplificarlo mettendo in evidenza la sua struttura secondo i criteri usati dagli antichi. Così rileviamo che questa prima parte possiede una parola gancio che troviamo all'inizio, al centro e alla fine: blèpete che possiamo tradurre: badate, guardate, che è più di un semplice vedere, per cui va bene: "state attenti".
In questo modo siamo in grado di rilevare tre argomenti disposti in forma concentrica, a chiasmo:
=> il primo e l'ultimo A e A1 parlano di ingannatori
=> il secondo e il quarto B e B1 parlano di disastri
=> al centro C, abbiamo il messaggio più rilevante: la persecuzione scandito tre volte dal verbo consegnare / para-dìdōmi, che per noi potrebbe essere: arrestare e che troveremo moltissime volte nel racconto della Passione.
A => 5 Gesù si mise a dire loro: « State attenti / Blèpete che nessuno vi inganni! 6 Molti verranno in mio nome, dicendo: "Sono io / Egō eimi ", e inganneranno molti.
B => 7 Ora, quando sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre, non allarmatevi; questo deve avvenire (Dn 2,28), ma non è ancora la fine. 8 Si leverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno (Is 19,2); vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie. Questo sarà il principio delle doglie.
C => 9 Ora, state attenti / blèpete per voi stessi: vi consegneranno / para-dìdōmi a sinedri e a sinagoghe, sarete percossi, comparirete davanti a governatori e re a causa mia, a rendere testimonianza per loro. 10 Ma prima è necessario che il vangelo sia proclamato a tutte le genti. 11 E quando vi condurranno via per consegnarvi / para-dìdōmi , non preoccupatevi prima di ciò che dovrete dire, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato: poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo (Gv 14,26). 12 Il fratello consegnerà / para-dìdōmi a morte il fratello, il padre suo figlio e i figli insorgeranno contro i genitori (Mic 7,6) e li metteranno a morte. 13 Voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
B1=> 14 Ora, quando vedrete l'abominio della desolazione (Dn 9,27) stare là dove non deve - chi legge capisca - allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano ai monti; 15 chi si trova sulla terrazza non scenda per entrare a prender qualcosa nella sua casa; 16 chi è nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. 17 Guai alle donne incinte e a quelle che allattano in quei giorni! 18 Pregate che ciò non accada d'inverno; 19 perché quei giorni saranno una tribolazione, quale non è mai stata dall'inizio della creazione, creata da Dio, fino al presente (Dn 12,1) né mai vi sarà. 20 E se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessuna carne si salverebbe. Ma a motivo degli eletti che si è scelto ha abbreviato quei giorni.
A1 => 21 E allora, dunque, se qualcuno vi dicesse: "Ecco, il Cristo è qui! Guarda, è là", non ci credete; 22 perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi (Dt 13,2) per ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti. 23 Voi però state attenti / blèpete! Io vi ho predetto tutto.
A e A1 => Avevamo trovato e spiegato il senso di "Egò eimì" nel racconto della traversata del mare di Galilea quando Gesù raggiunge la barca dei discepoli camminando sulle acque: 6,45ss, Lettura 48. "Egò eimì" è il modo in cui la Bibbia greca LXX traduce il nome di JHWH. Quindi Gesù in quel racconto si è presentato ai suoi come JHWH.
Nei nostri due brani Gesù profetizza che saranno in molti presentarsi come "egò eimì" e avranno anche successo. È la tecnica dell'idolo quella di mascherarsi da Dio. Per questo l'avvertimento imperativo " state attenti / blèpete" ripetuto ben tre volte.
Il v 22 è una citazione del Deuteronomio che invita i fedeli a non fidarsi di coloro che fanno prodigi e anche in questo caso appare la linea comune a tutti Vangeli nell'usare con parsimonia il termine "miracoli". I miracoli vanno bene, ma solo fino ad un certo punto, cioè se sono segni di liberazione dal male, perché la divinità di Gesù si rivela altrove. E sarà un centurione pagano a scoprirla 15,39.
B => Guerre, rumori di guerre, carestie e terremoti non sono il segno della fine, ma eventi che accompagnano da sempre la storia dell'uomo. La novità che qui Gesù rivela è che tutti questi non sono dolori comuni, ma doglie perché è in corso la nascita di un mondo nuovo. E ciò vale per i discepoli di allora e per quelli di oggi.
B1 => L'espressione "abominio della desolazione" è usata per primo dal profeta Daniele, a mo di profezia post eventum, per dire quello che è avvenuto nel tempio di Gerusalemme.
1- La descrizione effettiva di quell'evento la troviamo nel primo libro dei Maccabei:
1 Mac 1, 54 «Nell'anno centoquarantacinque, il quindici di Casleu il re innalzò sull'altare un idolo. Anche nelle città vicine di Giuda eressero altari 55 e bruciarono incenso sulle porte delle case e nelle piazze. 56 Stracciavano i libri della legge che riuscivano a trovare e li gettavano nel fuoco».
In sostanza nel 168 a. C il re Antioco IV si fece erigere una statua all'interno del tempio. I re si ritenevano tutti in qualche modo figli di un dio. Ma per gli ebrei, fin dai tempi di Mosè, era in vigore il divieto di costruire immagini che per essi costituivano un abominio. Figuriamoci poi a piazzarle all'interno del tempio!
2- Però anche l'imperatore Caligola, che mori nel 41 d. C., voleva farsi fare una statua da porre in quel tempio, anche se non è chiaro se vi fosse riuscito.
3- Sappiamo inoltre che prima dell'inizio delle guerre giudaiche vi furono diversi tentativi di rivolta compiuti da gruppi di zeloti che riuscirono più volte a penetrare nel tempo ed occuparlo.
4- La prima guerra giudaica inizia nel 66 e termina nel 70 con la completa distruzione del tempio, probabilmente nel periodo in cui Marco stava finendo di redigere il suo Vangelo.
Tutti questi eventi possono essere considerati "abominio della desolazione".
5- Ma forse c'è da considerare qualcosa di più intrigante, che in parte abbiamo già trattato, che riguarda direttamente Gesù.
Il quale, il primo giorno del suo arrivo a Gerusalemme, entra nel tempio e guarda attentamente ogni cosa.
Il secondo giorno, dopo avere maledetto il fico, scaccia i profanatori dal tempio.
Il terzo giorno, dopo che i discepoli hanno rilevato la morte del fico, seccato in meno di 24 ore, entrato nel tempio subisce una serie di contestazioni proprio da coloro che avrebbero dovuto difendere la santità del luogo: sommi sacerdoti, farisei, sadducei, scribi.
Non è anche questo "abominio della desolazione"?
In definitiva abbiamo cinque eventi che possono essere abominio della desolazione.
Marco al solito vuole fare riflettere il suo lettore e non dice quale esso sia, ma aggiunge «chi legge comprenda».
I versetti successivi sono un invito ai discepoli a tagliare la corda in caso di persecuzione, perché Gesù non vuole eroi, infatti sappiamo che i cristiani di Gerusalemme si rifugiarono a Pella, una città allora molto importante, che attualmente si trova in Giordania.
C => Notiamo subito che appare tre volte il verbo consegnare / para-dìdōmi e questo segnala che è molto importante. E infatti vedremo nelle prossime letture con quale frequenza apparirà nei testi.
Marco rassicura la sua comunità che l'essere "consegnati", perseguitati, non è un incidente di percorso, ma la possibilità di un evento previsto sin dall'inizio.
Tra le righe possiamo intuire che il primo ad essere "consegnato" sarà Gesù ad opera di un apostolo: Giuda che lo consegnerà alle guardie dei sacerdoti, che lo consegneranno a Pilato, che lo consegnerà al centurione romano e al suo drappello che così lo inchioderanno alla croce.
Solo lì, sotto il Crocifisso, quel centurione lo riconoscerà come "Figlio di Dio".
C'è però una "consegna" originaria che ha anticipato tutte queste consegne.
È la consegna del Figlio da parte del Padre agli uomini.
E costituisce Mistero dell'Incarnazione.
Lettura 90 Mc 13, 24-27 Discorso escatologico. La venuta del Figlio dell'Uomo.
Il metodo con cui abbiamo esaminato la prima parte del discorso escatologico ha mostrato che essa aveva una struttura a chiasmo con al centro il messaggio più importante, ma tutto il capitolo deve essere compreso con quel criterio.
In questo modo si realizza una struttura del tipo
A => 5-23 segni dell'arrivo del giorno del Signore: il come.
B => 24-27 il giorno del Signore: la venuta del Figlio dell'Uomo.
A1 => 28-37 segni dell'arrivo del giorno del Signore: il quando.
così scopriamo che il messaggio più importante si trova al centro vv 24-27, mentre il la prima parte 5-23
Mc 13,24 «In quei giorni, dopo quella tribolazione,
"il sole si oscurerà / e la luna non darà più il suo chiarore" (Is 13,10)
25 e "le stelle cadranno da dal cielo / e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte" (Is 34,4).
26 E "allora vedranno il Figlio dell'Uomo venire sulle nubi" (Dn 7,13) con grande potenza e gloria.
27 Allora Egli manderà gli angeli e "radunerà i suoi eletti dai quattro venti" (Zc 2,10), dall'estremità della terra fino "all'estremità dei cieli" (Dt 30,4)».
Questo brano è una raccolta di citazioni provenienti dagli antichi profeti.
Ora, le citazioni non hanno solo lo scopo di dare autorevolezza al testo, ma di fare entrare l'ascoltatore o il lettore all'interno del climax dal quale la citazione è stata tratta. Ancora una volta segnaliamo l'importanza di leggere gli antichi testi, anche perché la Bibbia deve essere compresa in modo unitario nel suo insieme. L'estrapolazione di qualche versetto per sostenere le proprio tesi è opera diabolica; vedi l'abilità di Satana nel racconto delle tentazioni messianiche di Mt 4.
La prima citazione, di Isaia, è un oracolo contro Babilonia per le guerre e tutte le angherie che ha commesso verso Israele. La Parola di Dio promette l'avvento del "Giorno del Signore", quel giorno in cui il Signore verrà per ristabilire la giustizia. Quando il Signore interviene risulta sconvolto anche il cosmo, così come troviamo nel nostro brano.
Qualcosa di molto simile è descritto in Is 34,4, ma in questo caso il paese oggetto della giustizia divina è Edom, un popolo prevalentemente nomade situato a sud di Israele che viveva soprattutto di razzie, quindi perennemente in conflitto con gli ebrei.
Nella lettura 19 abbiamo sviluppato il significato del sintagma "Figlio dell'Uomo", il titolo che Gesù stesso si dà. Suggeriamo vivamente di rileggere quella lettura per contestualizzare il senso di quell'appellativo.
Egli non si dichiarerà mai "Figlio di Dio" se non davanti al Sinedrio quando sarà interrogato e condannato dal Sommo sacerdote, proprio perché si è dichiarato "Figlio di Dio".
Il testo del profeta Zaccaria fa riferimento al ritorno degli esiliati da Babilonia e di tutti i figli di Israele dispersi. "Quattro venti" è un modo per significare i quattro punti cardinali dal quale richiamare tutti i dispersi. Concetto ribadito anche da Dt 30,4.
Ora è necessario chiarire il senso dei fenomeni cosmici citati in questo brano e nella Bibbia in genere.
Mareggiate, eruzioni vulcaniche, tornado, temporali, eclissi solari o lunari, ecc. sono fenomeni che ci atterriscono e nello stesso tempo ci attirano, ci incuriosiscono; ovviamente se siamo in condizioni di sicurezza. Con questi fenomeni siamo di fronte allo scatenarsi delle forze della natura che noi non possiamo dominare e ci fanno sentire piccoli, piccoli: granelli di polvere rispetto a quello che vediamo. In filosofia sono studiati come tema del sublime.
Ora tutte queste manifestazioni sono state usate in tutte le religioni e in tutti le culture come manifestazioni delle divinità. Abbiamo trattato a fondo questo tema nella riflessione sul libro di Esodo.
Però nella religione ebraica e quindi nella Bibbia, l'uso di questi fenomeni per significare la presenza di Dio, se eccettuiamo Es 19, sono praticamente assenti.
Infatti già la teofania di Dio a Mosè raccontata in Es 34,5ss. avviene sulla soglia di una caverna, in un contesto privo di manifestazioni cosmiche se non la Nube.
La teofania in cui è stato protagonista Elia, sempre sul Sinai, nella medesima caverna, chiarisce che Dio non è nel vento gagliardo che spacca le rocce, non è nel terremoto, non è nel fuoco, ma in una "voce di silenzio svuotato" che la CEI traduce: "Mormorio di vento leggero" (1 Re 19,9ss). E lo abbiamo approfondito nel Libretto di Elia alla Lettura 11 e successive.
Allora le manifestazioni cosmiche proclamate dai profeti acquistano un altro significato: l'azzeramento dei corpi celesti che erano idoli per tutti i popoli dell'Antico vicino Oriente, in particolare i babilonesi. Ma non scherzavano neanche gli egiziani che adoravano il sole, la luna, ecc. Gli stessi greci e romani non erano su lunghezze d'onda molto diverse .
Il nostro testo allora vuol dire che tutti questi idoli spariranno e con essi anche la possibilità di computare il tempo, che si usi un calendario lunare o solare e di distinguere il giorno e la notte.
Anche il tema «le stelle cadranno da dal cielo» v 25, non indica un cataclisma cosmico, ma la caduta di coloro che si credevano stelle, cioè i re dall'antico oriente come troviamo in alcuni testi dell'Antico Testamento come Is 14,12-14; Is 24,21 LXX; Dn 8,10 LXX. Possiamo spiegare la "caduta" di queste stelle come conseguenza dell'oscuramento degli astri maggiori: sole e luna dei quali i re /stelle erano sacerdoti o figli. Teniamo presente che le loro conoscenze astronomiche erano ben diverse dalle nostre.
Come tutto questo accadrà? Ce l'aveva anticipato il v10 «Ma prima è necessario che il vangelo sia proclamato a tutte le genti». Vale a dire, la caduta delle stelle e la stessa perdita di luce degli dèi /astri cielo, è la conseguenza della diffusione del Vangelo in tutto il modo. E possiamo aggiungere: "ad opera dei discepoli".
E quando accadrà? Dopo la grande tribolazione, cioè la guerra giudaica, la caduta di Gerusalemme, la distruzione del Tempio e la dispersione dei discepoli al di fuori della Palestina.
Quindi tutto questo non parla di una fine del mondo, ma del compimento del disegno del Padre, attraverso le «doglie» 13,8. Il compimento è spiegato da 13,26 «allora vedranno il Figlio dell'Uomo venire sulle nubi».
Già, ma bisogna indagare cosa si intende per Nube.
Essa fa la sua comparsa nel libro di Esodo la notte in cui gli ebrei fuggono dalla schiavitù d'Egitto.
=> Es 13,21 Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di Nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco per far loro luce, così che potessero viaggiare giorno e notte.
22 Di giorno la colonna di Nube non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco durante la notte.
=> Es 14,19 L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento d'Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di Nube si mosse e dal davanti passò indietro. 20 Venne così a trovarsi tra l'accampamento degli Egiziani e quello d'Israele. Ora la Nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte; così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte.
=>Es 14,24 Ma alla veglia del mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di Nube gettò uno sguardo sul campo degli Egiziani e lo mise in rotta. 25 Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli Egiziani!».
=> Es 16,9 Mosè disse ad Aronne: «dà questo comando a tutta la comunità degli Israeliti: Avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha inteso le vostre mormorazioni!». 10 Ora mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli Israeliti, essi si voltarono verso il deserto: ed ecco la Gloria del Signore apparve nella Nube.
=> Es 19,9 Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per venire verso di te in una densa Nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano sempre anche a te». Mosè riferì al Signore le parole del popolo.
=> Es 19,16 Appunto al terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni, lampi, una Nube densa sul monte e un suono fortissimo di tromba: tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore.
17 Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte.
18 Il monte Sinai era tutto Fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco e il suo Fumo saliva come il Fumo di una fornace: tutto il monte tremava molto. 19 Il suono della tromba diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce di tuono. [Qui la Nube assume la forma di Fumo]
=> Es 20,20 Mosè disse al popolo: «Non abbiate timore: Dio è venuto per mettervi alla prova e perché il suo timore vi sia sempre presente e non pecchiate». 21 Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la Nube oscura, nella quale era Dio.
=> Es 24,15 Mosè salì dunque sul monte e la Nube coprì il monte. 16 La Gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la Nube lo coprì per sei giorni. Al settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla Nube.
17 La Gloria del Signore appariva agli occhi degli Israeliti come fuoco divorante sulla cima della montagna.
18 Mosè entrò dunque in mezzo alla Nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte quaranta giorni e quaranta notti.
=> Es 33,8 Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava in piedi, stando ciascuno all'ingresso della sua tenda: guardavano passare Mosè, finché fosse entrato nella tenda. 9 Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna di Nube e restava all'ingresso della tenda. Allora il Signore parlava con Mosè. 10 Tutto il popolo vedeva la colonna di Nube, che stava all'ingresso della tenda e tutti si alzavano e si prostravano ciascuno all'ingresso della propria tenda. 11 Così il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con un altro. Poi questi tornava nell'accampamento, mentre il suo inserviente, il giovane Giosuè figlio di Num, non si allontanava dall'interno della tenda.
=> Es 34,5 Allora il Signore scese nella Nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. 6 Il Signore passò davanti a lui proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, 7 che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione».
=> Es 40,34 Allora la Nube coprì la tenda del convegno e la Gloria del Signore riempì la Dimora. 35 Mosè non potè entrare nella tenda del convegno, perché la Nube dimorava su di essa e la Gloria del Signore riempiva la Dimora. 36 Ad ogni tappa, quando la Nube s'innalzava e lasciava la Dimora, gli Israeliti levavano l'accampamento. 37 Se la Nube non si innalzava, essi non partivano, finché non si fosse innalzata. 38 Perché la Nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla Dimora e durante la notte vi era in essa un fuoco, visibile a tutta la casa d'Israele, per tutto il tempo del loro viaggio.
Tutti i libri dell'Antico Testamento sono scanditi dalla presenza della Nube che in certi casi assume la forma della Nube d'incenso come nella vocazione di Isaia Is 6.
Allora possiamo dire che la Nube non è elemento meteorologico ma un elemento teologico che rivela e nello stesso tempo nasconde la Presenza di Dio.
La stessa Nube è presente anche nel Nuovo Testamento e dispiega la funzione rivelativa. L'abbiamo trovata nel racconto della Trasfigurazione Lettura 61
Mc 9,2 «Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in disparte, loro soli. E fu trasfigurato davanti a loro 3 e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, quali alcun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. 4 E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. 5 E Pietro prendendo allora la parola disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!». 6 Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. 7 E venne una Nube che li coprì con la sua ombra e venne una voce dalla Nube: «Questi è il mio Figlio, il prediletto; ascoltatelo!» (Sl 2,7; Dt 18,15). 8 E ad un tratto guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro.
La ritroviamo nel processo davanti al Sinedrio
Mc 14,60 Allora il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?». 61 Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?». 62 Gesù rispose: «Io lo sono!
E vedrete il Figlio dell'uomo/ seduto alla destra della Potenza / e venire con le Nubi del cielo».
E ancora all'Ascensione di Gesù sul Monte degli Ulivi
At 1,6 Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: «Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?». 7 Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, 8 ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra». 9 Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una Nube lo sottrasse al loro sguardo. 10 E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n'andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: 11 «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». 12 Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato.
Se il lettore avrà avuto la pazienza di leggere tutti questi passaggi avrà capito che la Nube rivela e nasconde la presenza di Dio.
Allora se tutti «vedranno il Figlio dell'Uomo venire sulle Nubi»
significa che il Figlio dell'Uomo è il Figlio di Dio.
Lettura 91 Mc 13,28-36 Discorso escatologico: parte finale
Richiamiamo la struttura del discorso escatologico:
A => 5-23 segni dell'arrivo del giorno del Signore: il come.
B => 24-27 il giorno del Signore: la venuta del Figlio dell'Uomo.
A1 => 28-37 segni dell'arrivo del giorno del Signore: il quando.
Passiamo quindi all'ultima parte, molto simile alla prima, la cui struttura sintetica risulta essere:
A => 28-29: una parabola con, l'avvertimento: «sappiate».
B => 30: una parola sul tempo, sul quando:«non passerà questa generazione...» il tempo è vicino e certo.
C => 31: un detto di conferma: «le mie parole non passeranno» e questa è l'unica cosa certa.
B1=> 32: ritorna un detto sul tempo: «il tempo e l’ora nessuno lo conosce...».
A1 => 33-36: altre due mini parabole quella del padrone e quella del portiere e dei servi.
A => 28 «Dal fico imparate (CEI: questa) la parabola: quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi sapete che l'estate è vicina; 29 così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che è vicino alle porte.
B => 30 Amen (In verità) vi dico: non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute.
C => 31 Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
B1 => 32 Quanto poi a quel giorno o a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo, e neppure il Figlio, ma solo il Padre.
A1 =>33 State attenti / blèpete, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso.
34 È come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare / grēgorēi.
35 Vigilate / grēgoreite dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino,
36 perché non giunga all'improvviso, trovandovi addormentati. 37 Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate / grēgoreite!».
=> A - Se usassimo il dimostrativo "questa parabola" saremmo portati a pensare che si tratti di imparare la parabola del fico, ma il greco usa l'articolo, cioè "la parabola". Allora si tratta di capire di quale parabola si tratta. Così dobbiamo ripercorrere la giornata, la terza giornata passata da Gesù con i discepoli a Gerusalemme.
Al mattino sulla strada da Betania verso la città rilevano il fico seccato fin dalle radici a seguito della maledizione perché non aveva frutti, ma solo foglie. Entrati nel tempio Gesù subisce una serie di attacchi dalle autorità civili e religiose. In qual frangente egli racconta la parabola dei "vignaioli omicidi" 12,1- 12 (Lettura 80) che non riprendiamo nella sua interezza, ma ne riportiamo la conclusione
Mc 12, 6 «Aveva ancora uno, il figlio diletto: lo inviò loro per ultimo, dicendo: Avranno rispetto per mio figlio! 7 Ma quei vignaioli dissero tra di loro: Questi è l'erede; su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. 8 E afferratolo, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. 9 Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. 10 Non avete forse letto questa Scrittura: La pietra che i costruttori hanno scartata / è diventata testata d'angolo;/ 11 dal Signore è stato fatto questo/ ed è mirabile agli occhi nostri?» (Sal 118,22-23).
Questa è la parabola che la metafora del fico aiuta a comprendere, anche perché non c'è qui una "parabola del fico".
Allora quando il fico mette le foglie - e non ancora i frutti - e le cime dei rami si fanno teneri e lattiginosi allora l'estate è vicina e pertanto accadrà quello che la parabola ha previsto: "la vigna sarà data ad altri vignaioli".
Se non si riferisse a questa parabola la frase finale di v 29, senza soggetto esplicito, resterebbe incomprensibile.
=> B - In questa direzione ci porta anche il versetto successivo con il termine "generazione" che Marco usa quattro volte sempre con significato negativo
Mc 8,11ss.: sono "generazione" i farisei che gli chiedono un segno dal cielo. Lettura 54
Mc 8,38 «Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi». Lettura 60
Mc 9,19 «Egli allora in risposta, disse loro: «O generazione incredula! Fino a quando starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me».
Racconto dell'indemoniato che i discepoli non sono riusciti a guarire. Lettura 62
Se è così, sono proprio i quattro discepoli Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea, che lo interrogano circa gli eventi futuri, mentre sono seduti sul Monte degli Ulivi e guardano Gerusalemme, i quali per primi devono comprendere che la vigna sarà tolta alle autorità d'Israele e sarà concessa a tutti gli altri popoli.
Si tratta di accettare la qualità fondamentale del Suo modo di essere Messia: non colui che ripristina il regno di Davide assoggettando tutti i gli altri popoli, ma colui che porta il Regno di Dio. Cioè, un Messia ben più grande, che apre alla speranza tutti gli uomini nati sotto il sole e non soltanto ad alcuni.
Noi che siamo venuti dopo possiamo dire che questa profezia si è avverata.
Proprio mentre Marco sta scrivendo il suo Evangelo in Palestina si era scatenata la prima guerra giudaica alla fine della quale il tempio sarà ridotto ad un cumulo di macerie.
=> C - 31 «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno».
Questo è il centro del brano che afferma il permanere della Parola del Maestro, Parola, che da una lato abbiamo verificato e dall'altro siamo in attesa del suo compimento.
E non si tratta tanto di un discorso di "fine del mondo" per la quale non sono tanto necessari convulsioni cosmiche, ma un semplice vulcano che sbuffa più del solito (vedi ad esempio: https://it.wikipedia.org/wiki/Anno_senza_estate) o un asteroide una tantino più grande e più veloce (https://it.wikipedia.org/wiki/Estinzione_di_massa_del_Cretaceo-Paleocene), ma piuttosto della "venuta del Signore nella sua gloria".
Potremmo dire che è un ritorno che avviene tutte le volte che uno chiude gli occhi per sempre.
=> B1 - Un evento al quale bisogna essere prepararti come raccomandano gli ultimi versetti.
Una preparazione che non dovrebbe impaurire, perché alla fine ci si ritrova nelle braccia di Colui nel quale abbiamo sperato e confidato per tutta la vita. E questo lo evidenzia il v 32.
32 Quanto poi a quel giorno o a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo, e neppure il Figlio, ma solo il Padre.
Qui non si dice che Dio ha già predisposto tutti i suoi strumenti per decidere quando sarà il giorno fatidico, ma che solo al "Padre" compete questa decisione. Ma quale sarà il criterio dei questa decisione?
Dobbiamo esaminare le ricorrenze del termine "Padre" nel Vangelo di Marco, che sono tre.
Mc 8,38 «Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi».
In questo passaggio Dio è il Padre del Figlio dell'Uomo.
Mc 11,25 «Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati».
Qui Dio è il Padre dei discepoli: "Padre vostro".
Mc 14,36 «E diceva: «Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu».
In questo caso siamo nell'orto del Getsemani e Gesù chiama il Padre con il termine che usano i bambini e potremmo tradurlo con "Papino, Babbino, Papi, ecc".
Quindi Marco usa il termine "Padre" per indicare un rapporto di grande tenerezza da parte di Dio verso le sue creature.
Se è così le ammonizioni alla vigilanza che seguono nei versetti successivi non devono essere intese come una minaccia, ma come un aiuto a mantenere vivo questo legame affettivo.
Si tratta di una vigilanza che, per usare un termine teologico, potremmo chiamare "escatologia presenziale", cioè il principio secondo il quale il tuo eschaton non lo decidi l'ultimo giorno o cinque minuti prima della fine, ma nella decisione di fede che esprimi nel rapporto con i sacramenti che sono i luoghi privilegiati dell'incontro con il Signore Gesù. Oltre al servizio verso i fratelli, purché esso non diventi semplice filantropia.
Allora il richiamo alla vigilanza, detto con linguaggio corrente, non è fatto da Uno che "ti cura" per coglierti in fallo e fartela pagare cara, ma è fatto da un Padre, Abbà, che ce la mette tutta perché la tua vita diventi un capolavoro.
L'ultimo richiamo di Gesù alla vigilanza vuole, forse, ricordare un elemento importante: Dio malgrado tutti i suoi sforzi, non è in grado di salvare te senza di te.
Lettura 92 Mc 14,1-11 L'unzione di Betania
Con questo brano entriamo nella terza sezione della seconda parte e l'abbiamo intitolato "Passione, morte e Risurrezione del Figlio di Dio".
E da subito ci rendiamo conto che Marco ci pone in un clima di intrighi, sospetti che, se già non conoscessimo l'esito finale, potremmo chiamare inizio di un racconto giallo.
Mc 14:1 «Mancavano intanto due giorni alla Pasqua e agli Azzimi e i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di impadronirsi di lui con inganno, per ucciderlo. 2 Dicevano infatti: «Non durante la festa, perché non succeda un tumulto di popolo».
3 Gesù si trovava a Betània nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di nardo genuino molto costoso; infranto il vasetto di alabastro glielo versò sul capo. 4 Ma alcuni si sdegnavano fra di loro: «Perché tutto questo spreco /apōleia di profumo? 5 Si poteva benissimo vendere questo profumo a più di trecento denari e darli ai poveri!». Ed erano infuriati contro di lei.
6 Ma Gesù disse: «Lasciatela stare; perché le procurate molestie? Ella ha compiuto verso di me un'opera buona; 7 i poveri infatti li avete sempre con voi e quando volete potete far loro del bene, ma non sempre avete me. 8 Ella ha fatto ciò che ha potuto: ha profumato in anticipo il mio corpo per la sepoltura. 9 Amen (in verità) vi dico: dovunque, sarà predicato per tutto il mondo, anche ciò che ella ha fatto sarà annunziato in suo ricordo».
10 E Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai sommi sacerdoti, per consegnare loro Gesù. 11 Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava l'occasione opportuna per consegnarlo / paradìdomi».
In questo brano la struttura è più che evidente: abbiamo due scene che alludono alla consegna / paradìdomi
La prima ad opera di sommi sacerdoti e scribi 1-2, che in realtà vogliono impadronirsi, la seconda ad opera di Giuda, il traditore che anche nei momenti delle scene di addio dell'Ultima Cena, sta ancora insieme ai dodici per realizzare puntualmente il suo disegno.
Se stiamo alla cronologia di Marco siamo giunti al quarto giorno che sarebbe mercoledì. Gesù si trova a Betania: "casa del povero", ospite di Simone il lebbroso. Ovvio che questo Simone era stato lebbroso, perché se lo fosse attualmente non potrebbe stare in mezzo alla gente. L'uso dell'articolo determinativo manifesta che gli ascoltatori o lettori della comunità di Marco, conoscevano questo Simone, che così diventa testimone del fatto raccontato.
L'unzione di Betania dovrebbe essere letta nel contesto delle unzioni che riguardavano le più importanti funzioni della classe dirigente.
Veniva unto il re ed è noto il modo in cui viene unto il grande re David, ancora giovinetto, attraverso la rivelazione divina fatta all'anziano giudice Samuele, come raccontato con dovizia di particolare in 1Sam 16ss.
In qualche modo veniva unto un profeta come racconta 1 Re 19,19ss. a riguardo della vocazione di Eliseo.
Erano unti anche i sacerdoti prima di potere iniziare il loro servizio al tempio.
Gesù il cui nome è spesso seguito da "Cristo" termine greco per dire: "Unto" e in ebraico: "Messia", non è mai stato unto da alcun esponente dell'ambito religioso, però ci pensa una donna.
Il fatto che sia una donna ad ungere l'"Unto" dovrebbe portarci a riflettere sui rapporti che nel vangelo si stabiliscono tra Gesù e le donne, a partire dalla suocera di Pietro e via via tutte le altre, senza perdere di vista la Madre, che in Marco è una figura sicuramente presente, ma tanto discreta da apparire quasi invisibile.
Ora, l'unzione di Betania è importante perché anticipa l'unzione del corpo di Gesù che non potrà essere eseguita. Infatti quando il mattino di Pasqua le donne si recheranno al sepolcro per imbalsamare il corpo del maestro deposto nel sepolcro da tre giorni, troveranno la "Tomba vuota".
La radicale di spreco /apōleia si trova solo in un altro luogo del Vangelo di Marco, cioè nel racconto che segue il primo annuncio della passione, quando Gesù esprime le condizioni per seguirlo:
Mc 8,34 «E chiamata a sé la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 35 Perché chi vorrà salvare la propria vita / psuchē (Cei: anima), la perderà / apōleia, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà. (Lettura 60).
In quel caso sarebbe difficile tradurre con "sprecare la vita", perché nella nostra cultura avrebbe un significato estremamente negativo: significherebbe mettersi sulla via dell'alcool, della droga, e in generale dei vizi.
Nel caso illustrato dai nostri brani però si parla di uno "spreco" che ha la sua ragione nell'amore. Allora possiamo pensare allo spreco di una madre che perde la sua vita per salvare quella del figlio che ha nel grembo, o quella di chi la dedica interamente alla cura di un infermo, o dei barboni, degli emarginati comunque della figure che si trovano in condizioni di estrema esclusione.
Questo spreco, proprio perché dettato dall'amore, fa riferimento a quello che avviene di qui a qualche giorno sulla croce. Un evento che non ha assolutamente economizzato sul dolore subito dal Messia perché il suo dono potesse essere colto anche dagli spiriti più refrattari.
Ai piedi della Croce dovremmo riuscire a comprendere l'immensità dello "spreco" operata del Figlio di Dio.
E i poveri dei quali si preoccupavano alcuni dei commensali?
Ne abbiamo trattato nella Lettura 60 e ora possiamo aggiungere, che se verso il povero non attuerai lo "spreco" di tutte le tue ricchezze, avrai solo creato un rapporto di dipendenza.
Lettura 93 Mc 14,12-16 Preparazione dell'Ultima Cena
Mc 14, 12 «Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?». 13 Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; seguitelo 14 e là dove entrerà dite al padrone di casa: Il Maestro dice: Dov'è la mia sala, perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? 15 Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i divani, già pronta; là preparate per noi». 16 I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua».
Il parallelo tra il reperimento del puledro d'asina usato per l'ingresso trionfale a Gerusalemme e della sala in cui consumare l'Ultima Cena, rivelano che c'era un piano già stabilito. Non si tratterebbe di fatti casuali.
Nel nostro caso non possiamo sapere se ci fosse stato un accordo precedente tra Gesù è il padrone della "sala al piano superiore", perché potrebbe anche trattarsi di prescienza di Gesù, tuttavia il tema è alquanto complesso.
In questo brano colpisce l'uomo che porta una brocca piena d'acqua, cosa molto strana, perché l'attingere acqua era un compito riservato alle donne, che si recavano al pozzo o alla fonte al mattino e alla sera. È solo la samaritana di Gv 4, che ci va a mezzogiorno. Ora quest'uomo che porta l'acqua appartiene ad un gruppo etnico o religioso che non beve vino.
Potrebbe essere un Recabita, come molto probabilmente erano i pastori di Betlemme che l'angelo invita a recarsi nella stalla dove è nato il Cristo Signore (Lc 2). Strani questi pastori perché anziché mettere le pecore al sicuro in un ovile, le tengono all'aperto e loro stessi vivono in tende. Sono appunto i Recabiti, che praticano il nomadismo perché lo ritengono più adeguato alla Legge di Mosè. Se il periodo ideale del rapporto di Israele con Dio è stato quello del deserto, allora il modello proposto dalla civiltà cananea nel suo insieme, deve essere rifiutato. Colui che vuole essere fedele a ciò che è avvenuto durante l'Esodo deve continuare quel tipo di vita e vivere nel deserto. Ovviamente se continui a girare alla ricerca di pascoli per i tuoi animali, non puoi coltivare la vite dalla quale ottenere il vino, per cui i Recabiti sono astemi.
Ora, Luca in due punti fondamentali della vicenda di Gesù, la Nascita e la Passione, pone delle persone sicuramente fedeli alla Legge.
Anche nel Vangelo di Marco, in cui manca il racconto della nascita, all'inizio della Passione, come in Luca, troviamo un fedelissimo all'antica Legge, appunto; e possiamo aggiungere: come figura di contrasto con le autorità religiose del Tempio.
La vita del deserto non era tenuta in grande considerazione solo dai Recabiti, ma anche dagli Esseni. Essi erano un movimento alquanto complesso da definire per la scarsità di informazioni che la storia ci ha tramandato, ma dovevano avere raggiunto un numero molto grande di aderenti. È un movimento che nasce in epoca maccabaica, nel secondo secolo a. C. e si struttura in comunità che vivono prevalentemente nel deserto. I rotoli scoperti nel 1947 a Qumran, in prossimità del Mar Morto, appartenevano ad una di queste comunità. Non si deve escludere che Giovanni Battista e lo stesso Gesù durante la loro giovinezza, alla ricerca di Dio, non abbiano attraversato qualcuna di queste comunità. Il film "I giardini dell'Eden" di A. D'Alatri, pur se romanzato, da questo punto di vista è alquanto intrigante. Ad ogni modo anche in questo nostro caso abbiamo a che fare con persone che cercano con tutto il loro essere di praticare la religione in modo fedele alle tradizioni dei Padri. Anch'essi in qualche modo separate dalle autorità del Tempio.
Studi recenti ritengono che a Gerusalemme vi fosse un quartiere verso il Monte degli Ulivi, abitato da esseni, allora è probabile che il "padrone" di cui si parla in questo brano fosse di estrazione essena (E. Mazza, Il Nuovo Testamento e la Cena del Signore, EDB) .
Però già il nostro testo ci fornisce delle indicazioni inopinabili. Questo padrone di casa al quale sono arrivati i discepoli guidati dall'uomo con la brocca d'acqua, conosce Gesù come "il Maestro" e Gesù chiede a lui "la mia sala"; questo significa che anch'egli è un discepolo evidentemente sconosciuto ai dodici.
Ora, la preparazione della cena pasquale richiedeva di approvvigionare un agnello, portarlo al Tempio per sacrificarlo e bruciate le parti interne come offerta a Dio, venisse portato a casa per essere arrostito, ma è molto strano che Marco di tutto questo "traffico" non spenda una sola parola.
Potremmo dire che si rivolge ad interlocutori che conoscevano perfettamente le usanze ebraiche, oppure che il testo vuole segnalare ancora una volta una presa di distanza dall'ambiente del Tempio divenuto ormai una "Spelonca di ladri" (11,17 Lettura 77).
Questo silenzio può essere spiegato anche per il fatto che il rito dell'agnello pasquale era parte integrante della religione ebraica e faceva memoria della notte di Pasqua in cui gli ebrei furono liberati dalla schiavitù dell'Egitto dopo avere celebrato il rito dell'agnello, come descritto in Es 12. Ma nel cristianesimo il rito dell'agnello pasquale non c'è più. Esso è stato sostituito dall'immolazione dell'"Unico Agnello" in grado di liberare l'uomo dalla schiavitù della morte: Gesù Cristo. Quindi non c'è più alcun rito religioso che prescriva di mangiare un agnello il giorno di Pasqua perché solo Lui è l'Agnello che dà salvezza. Il nuovo rito è la celebrazione Eucaristica.
Un altro argomento può spiegare questo "silenzio" e la presa di distanza dal Tempio è l'accenno alla "sala al piano superiore".
"Piano superiore" non indica una condizione spaziale, ma uno spazio teologico: il Nuovo Tempio dove viene celebrata una nuova liturgia, la liturgia Eucaristica. Esso assumerà il nome di Cenacolo.
Quello spazio diventerà il luogo in cui si ritrova, dopo gli eventi pasquali, l'embrione della prima Chiesa.
Lì si troveranno gli Apostoli, frastornati, a raccogliere i racconti di coloro che hanno incontrato il Risorto, il Quale, poi, apparirà a loro stessi.
Lì riceveranno lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste e da lì partiranno per evangelizzare tutte le genti.
Lettura 94 Mc 14,17-21 Ultima cena - La presenza di traditore
L'ultima cena è racchiusa in una cornice che riflette perfettamente la situazione in cui si svolge l'ultimo giorno della vita terrena di Gesù.
Mc 14, 17- 21: rivelazione di un tradimento: "uno di voi mi tradirà"
Mc 14, 22-26: la cena e l'istituzione dell'Eucaristia.
Mc 14, 27-31: rivelazione di un rinnegamento: "prima che il gallo canti mi rinnegherai tre volte".
Mc 14,17 «Venuta la sera, egli giunse con i Dodici. 18 E mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: «Amen / In verità vi dico, uno di voi mi consegnerà / paradìdomi (Cei: tradirà), colui che mangia con me, mi tradirà / paradìdomi » (Sl 41,10). 19 Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse io?». 20 Ed egli disse loro: «Uno dei Dodici, che intinge con me nel piatto. 21 Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo è consegnato! Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato!».
A Marco preme sottolineare la cronologia. "venuta la sera" significa che è arrivato il giorno nuovo, cioè il sesto da quando sono arrivati a Gerusalemme. E si tratta di venerdì. Questo può sorprenderci perché siamo abituati a collocare l'Ultima Cena il giovedì, ma nella realtà epocale si tratta delle prime ore del venerdì perché gli ebrei fissavano l'inizio del giorno al tramonto del sole.
La denuncia della presenza di un traditore tra i Dodici in questo contesto del Vangelo di Marco evita accuratamente di dare anche la minima indicazione circa l'identità di colui che consegna il Maestro alle autorità del tempio.
Noi sappiamo che si tratta di Giuda perché in 14,10-11 viene detto che egli si è recato dai sommi sacerdoti per consegnarlo loro, ma gli altri Apostoli nulla sano di questo affare. E allora possiamo comprendere il loro sgomento: nessuno si fida più dei suoi vicini e in ciascuno nasce il dubbio che durante lo scontro che sta per approssimarsi potrebbe cedere alla forza delle autorità. Su questa cena cala l'ombra del sospetto.
Il fatto che intingessero in piatto comune rivela due cose che smentiscono le nostre iconografie: non mangiano attorno ad un tavolo, ma sdraiati su dei divani (14,15), dei triclini, disposte in cerchio e un piccolo tavolo al centro. Nelle nostre tavolate è difficile per coloro che sono agli estremi del tavolo parlarsi, mentre una disposizione a cerchio come quella descritta facilita a tutti i convitati di guardarsi in faccia e parlarsi.
A parte le osservazioni circa l'igiene, questa sistemazione offre l'idea di una grande intimità, che viene profondamente ferita dalla notizia rivelata da Gesù. Mentre gli altri vangeli nominano il traditore, Marco ne tace il nome, il che significa che ciascuno di essi potrebbe essere l'interessato. Questo tema rapportato alla chiesa di Marco costringe ogni fedele a valutare la saldezza della propria fede, visto che la possibilità del tradimento dei confratelli o del rinnegamento della fede è possibile, tenuto conto che le persecuzioni sono all'ordine del giorno.
In questo modo la cena pasquale, che dovrebbe essere un momento di grande festa perché ricorda la miracolosa liberazione dalla schiavitù d'Egitto, assume un carattere del tutto diverso; l'atmosfera si fa pesante sotto la nube del tradimento. Infatti il testo dice "cominciarono a rattristarsi".
L'istituzione dell'Eucaristia avviene con questa premessa.
Se è così accostarsi al Sacramento della Pane e del Vino è una cosa seria. molto seria!
Lettura 95 Mc 14,22 - 26a Ultima cena - Istituzione dell'Eucaristia
Mc 14,22 «E mentre essi mangiavano prese del pane e, detta la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». 23 E preso un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 24 E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'Alleanza (Es 24,8; Zc 9,11) che è versato per molti (Is 53). 25 Amen / in verità vi dico che io non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». 26 E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi».
Abbiamo visto nella lettura precedente che questo rito pasquale è dominato dalla nube del tradimento e della "consegna", ma Gesù non fa nulla per evitarla. Giunta la sera o anche dopo la Cena, avrebbe potuto rientrare a Betania che era un luogo molto più sicuro che Gerusalemme, però egli non fa nulla per sfuggire alla "consegna" perché essa non costituisce un incidente di percorso, ma un disegno lungamente perseguito. E lo specifica chiaramente e consapevolmente al v 25. È vero che la veglia di Pasqua doveva essere vissuta nella città santa o nelle sue adiacenze, ma un lieve strappo alla regola quando era in gioco la vita stessa avrebbe potuto essere tollerato.
La sua Missione era stata sin dall'inizio quella di mostrare agli uomini il vero volto di Dio, il Suo amore nella forma della incondizionata dedizione indisponibile ad ogni aspetto di mitigazione. Per chiarire ai suoi questa intenzione Egli anticipa nella forma "simbolica" (identità nella differenza, secondo la comprensione degli antichi) ciò che avverrà di lì a poco nel corso della giornata e questo è il senso più profondo dell'istituzione dell'Eucaristia.
Il corpo separato dal sangue indica chiaramente una morte violenta.
Questo "sangue dell'Alleanza versato per molti" ha un retroterra molto importante e significativo perché rimanda alla celebrazione della'Alleanza compiuta da Mosè ai piedi del Sinai dopo avere ricevuto le tavole della legge da JHWH e averle lette al popolo. Qui viene compiuto il sacrificio di parecchi animali in parte bruciati, quindi destinati a Dio e in parte mangiati, rito che viene chiamato "sacrificio di comunione" perché le vittime sono destinate a Dio e al popolo. Il sangue però, che per la cultura del tempo era considerata la vita, viene messo a parte.
Es 24, 6 «Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare.
7 Quindi prese il libro dell'Alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo!». 8 Allora Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell'Alleanza, che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!».
Successivamente, con il passare del tempo, Israele non è capace di restare fedele all'Alleanza per cui essa deve essere rinnovata. Così il rito che ricordava l'Alleanza diventa una liturgia di espiazione dei peccati. Ovviamente chi espia sono gli animali uccisi, in genere agnelli.
Quindi il rito pasquale che inizialmente doveva fare memoria della liberazione dalla schiavitù d'Egitto, e dell'Alleanza sinaitica, diventa un rito di liberazione dalle conseguenze dei peccati commessi.
Da questo punto di vista anche Gesù diventa la vittima che espia tutti i peccati commessi dall'uomo prima e dopo di Lui. Questo diventa uno dei fondamenti della teologia di San Paolo, ma troviamo qualcosa di più facile approccio nell'ultimo canto del Servo di JHWH in Is 53, che troviamo più volte nelle liturgie della Settimana Santa. Non possiamo riportarlo, ma raccomandiamo vivamente di leggerlo, perché sembra che il redattore di quel testo, vissuto quattrocento anni prima di Cristo, fosse anche lui lì a Gerusalemme a seguire i fatti che stanno per accadere.
Così, se è Gesù la vera e unica vittima capace di espiare i peccati di tutti, allora comprendiamo come nelle narrazioni evangeliche della Ultima Cena non c'è alcuna menzione dell'agnello: il vero Agnello è un altro il cui sacrificio ha valore definitivo, una volta per sempre.
Il lettore attento si sarà accorto che la consacrazione del vino avviene dopo che gli Apostoli hanno bevuto.
Questo ci suggerisce un aspetto molto importante, il fatto che la consacrazione avviene nell'insieme del rito, cioè attraverso la partecipazione integrale al sacro banchetto.
A riguardo del calice, noi siamo abituati a sentire "prese il calice... lo diede loro... ne bevvero tutti" e pensiamo che si trattasse dell'usanza di quei tempi bere tutti dallo stesso boccale, ma le cose non stanno così. Nei banchetti ogni commensale aveva la sua coppa, ma poteva accadere che il padrone o il personaggio più importante, offrisse ad un ospite di riguardo di bere dalla sua coppa in segno di amicizia. Se è così il gesto compiuto da Gesù vuole sottolineare, ancora una volta, la profonda amicizia che nutre per i suoi discepoli... tra i quali c'è anche Giuda... Forse un ultimo, vano, tentativo di farlo riflettere su quello che stava per fare.
Ma c'è molto più che amicizia, perché se nella comprensione della cultura di quel mondo il sangue era la vita stessa della persona, allora ricevere il sangue del Maestro permette ai discepoli di vivere la Sua stessa vita.
Questo è il grande dono che Gesù lascia ai suoi; e se ci pensiamo bene, anche utilizzando la sottolineatura del versetto 25, questa è un cena di addio e di genere letterario "testamentario", cioè quando uno lascia ai suoi le sue ultime volontà.
Allora, anche se ci ripetiamo, dobbiamo dire che l'Eucaristia è una cosa seria, molto seria.
Lettura 96 Mc 14,26 - 31 Predizione del rinnegamento di Pietro.
Mc 14, 26 «E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 27 Gesù disse loro: «Tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse (Zac 13,7).
28 Ma, dopo che io sarò risuscitato, vi precederò in Galilea». 29 Allora Pietro gli dichiarò: «Anche se tutti si scandalizzeranno, io non lo sarò». 30 E Gesù gli disse: «Amen /in verità ti dico: proprio tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte». 31 Ma egli, con grande insistenza, diceva: «Se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò». Ora, come lui, dicevano anche tutti gli altri».
Che si trattasse di un bacchetto sacro lo dice chiaramente anche la conclusione "cantato l'inno". Il testo non dice quale fosse l'inno perché tutti sapevano cosa si cantava alla fine della cena di Pasqua.
Non dovremmo perdere di vista che la cena pasquale o, se vogliamo, la cena di apertura del giorno festivo, non si svolgesse al tempio o in una sinagoga, ma in ambito famigliare. Un aspetto che agli inizi del cristianesimo valeva anche per la cena eucaristica, come risulta anche dalla testimonianza di Paolo 1 Cor,11,17ss.
Tre sono le profezie che Gesù annuncia ai suoi:
1- tutti rimarrete scandalizzati;
2- dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea;
3- il rinnegamento, apostasia di Pietro con tre determinazioni temporali: 1- oggi; 2- questa notte; 3- prima che il gallo canti.
Nel suo insieme brano fa risaltare la cornice nella quale è inserita l'istituzione dell'Eucaristia: essa inizia con l'annuncio della presenza alla cena di un traditore e si chiude con la profezia della fuga dei discepoli e del rinnegamento di Pietro.
Gli Apostoli, colgono soltanto la prima parte della predizione di Gesù: il loro scandalizzarsi, ma pèrdono di vista la seconda parte che è più importante: "Vi precederò in Galilea", vale a dire: lo scandalizzare o scandalizzarsi che, come abbiamo visto nella Lettura 66 vuol dire: "inciampare", non significa per Gesù una rottura della relazione benché si tratti di un peccato di infedeltà, perché ciò che conta nel rapporto con Dio non è la fedeltà dell'uomo bensì quella di Dio. E Dio è sempre fedele.
Allora l'elemento cruciale è la capacità di accettare il perdono che ripristina l'integrità della relazione.
Esattamente quello che Giuda non è stato capace di perseguire, perché una volta compreso il suo peccato, il suo tradimento del Maestro, ha voluto fare giustizia da sé; e si è giustiziato appendendosi ad un albero .
Il perdono che Gesù offre ai suoi si evidenzia chiaramente nel Vangelo di Giovanni nei racconti di incontro con il Risorto. Quando dopo Pasqua Gesù si rende presente agli apostoli che avevano tutti tagliato la corda, non dice loro: "adesso, facciamo i conti", bensì: «Pace a voi» per ben due volte (Gv 20,19).
Il «Tutti rimarrete scandalizzati» che Gesù pronuncia non è un rimprovero, ma il richiamo alla realtà prossima; tant'è che segue l'"appuntamento" in Galilea.
In Galilea perché là tutto era iniziato, con la chiamata dei pescatori a diventare discepoli «perché stessero con Lui» (3,14), e dalla Galilea partirà un nuovo inizio, dopo che, finalmente, i discepoli avranno capito quale tipo di liberazione ha portato il Messia: non la liberazione dal giogo romano, ma la liberazione dalla schiavitù della morte. Proprio per sconfiggere la morte il Messia ha dovuto morire e poi risuscitare, ma questo loro non potevano capirlo prima che gli eventi pasquali si manifestassero. Quindi solo dopo, ad eventi compiuti, gli Apostoli hanno potuto comprendere le predizioni sulla Sua condanna da parte delle autorità e la morte per crocifissione (8,31; 9,31; 10,33).
Questo ci dice che la fede non ti viene addosso come l'influenza, ma è frutto di un percorso di intuizioni e ricerca.
Lettura 97 Mc 14,32 - 42 La solitudine del Getzemani.
Mc 14,32 «E giungono in un podere chiamato Getzemani (del torchio), e dice ai suoi discepoli: «Sedetevi qui, mentre io prego». 33 E prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e incominciò a sentire paura e smarrimento. 34 e dice loro: «L'anima mia è triste fino alla morte (Sal 42,6.12), rimanete qui e vegliate». 35 E andato un poco più in là, si prostrava per terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora, 36 e diceva: «Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu».
37 E viene e li trova addormentati e dice a Pietro: «Simone, dormi? Non ha avuto la forza di vegliare neppure un'ora. 38 Vegliate e pregate per non soccombere nella prova. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole».
39 E allontanatosi di nuovo, pregò dicendo le medesime parole. 40 E di nuovo tornato li trovò che dormivano, perché: i loro occhi, infatti, erano appesantiti, e non sapevano che cosa rispondergli.
41 E viene per la terza volta e dice loro: «Ancora dormite e riposate! Finito. L'ora è giunta: ecco, il Figlio dell'uomo viene è consegnato / paradìdomi nelle mani dei peccatori. 42 Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce/ paradìdomi è vicino».
Osservando attentamente la scena notiamo che Gesù è sostanzialmente l'unico attore: si muove avanti e indietro cercando il sostegno dei discepoli, ne sceglie tre che gli sono stati più vicino, prega intensamente, si agita, è angosciato, mentre gli altri stanno sullo sfondo: non parlano, non pregano, dormono; più che comparse sembrano ombre. Ma Gesù avrebbe bisogno, anzi implora, la loro vicinanza, ma il sonno è più forte.
L'angoscia che attanaglia Gesù è sicuramente dovuta a ciò che dovrà affrontare di lì a poche ore, ma ancora più pesante gli appare l'esito della sua missione. Israele non è stato riunificato anzi, è più diviso di prima. Se poi guarda agli undici apostoli rimasti che a definirli "scalcinati", si farebbe loro un complimento, anche perché di lì a poco taglieranno gloriosamente la corda: e questi dovrebbero essere coloro che portano avanti tutta la "baracca"?
La preghiera di Gesù
A Gesù non resta che rivolgersi a Dio. La sua preghiera può essere scandita in quattro parti.
L'invocazione: "Abba, Padre";
la manifestazione della fede: "tutto è possibile a te";
la supplica: "allontana da me questo calice";
l'affidamento alla volontà di Dio: "però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu".
Le prime tre parti sono comuni alle preghiere che si trovano in tutto l'Antico Testamento, ma la quarta è tipicamente neotestamentaria; infatti sentiamo in essa l'eco della terza domanda del Padre Nostro.
Riteniamo tuttavia sorprendente il modo in cui Gesù chiama il Padre, cioè: "Abbà", che costituisce una novità così radicale che perfino l'Evangelo ha conservato il termine ebraico: "Abbà" che tradotto con "Padre" non rende conto della dimensione di tenerezza che il termine originale contiene. Per intuirlo dovremmo pensare al modo in cui un bambinetto di due o tre anni chiama suo padre e allora potremmo renderlo con: babbo, papà, papi, ecc. Purtroppo l'accostamento alla filosofia greca che, meglio di altre, ha saputo interpretare il cristianesimo, non ci ha permesso di cogliere la profondità di questi sentimenti che anche il semplice credente dovrebbe nutrire verso il Dio Abbà.
D'altra parte se pensi al Motore Immobile di Aristotele hai posto tra te e Lui un fossato invalicabile.
Il sonno dei discepoli
La spiegazione più banale suggerisce che avendo appena terminato il banchetto pasquale e magari avendo alzato il gomito più del solito fossero proprio "andati".
Non è questa però l'intenzione di Marco. Egli piuttosto ci vuole suggerire l'indifferenza degli apostoli verso il Maestro che aveva chiesto la loro vicinanza perché "si sentiva triste da morire".
È infatti il momento più tagico dell'esistenza di Gesù perché avrebbe potuto facilmente evitare ciò che stava per accadere: sarebbe bastato un miracolino piccolo, piccolo. Ma questa era l'"ora" per la quale era venuto e non poteva scansarla.
Il v 41: « L'ora è giunta: ecco, il Figlio dell'uomo viene è consegnato / paradìdomi nelle mani dei peccatori», essendo priva di soggetto, intende il passivo divino. Questa consegna fa parte del disegno del Padre che il Figlio ha lungamente perseguito.
Il v 42 al contrario indica il disegno degli uomini, e di uno in particolare:«Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce / paradìdomi è vicino».
E comunque di fronte a questo dramma di Gesù i suoi dormono tranquillamente, ma una piccola annotazione ci suggerisce altro: "infatti i loro occhi si erano appesantiti" v40. Ancora un passivo divino?
Teniamo presente che sono proprio questi tre apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni ad essere presenti durante altre scene rivelazione: il risuscitamento della figlia di Giairo 5,21-43, Lettura 39 e la Trasfigurazione 9,2-13, Lettura 61.
Allora anche nel Getzemani è accaduta una scena di rivelazione?
Marco non lo dice perché i testimoni dormivano, ma forse, ce lo lascia intuire perché nella Bibbia troviamo almeno altri due casi importanti in cui si parla del sonno dei protagonisti.
Il primo riguarda la creazione di Eva
Gn 2,20 «Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. 21 Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. 22 Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. 23 Allora l'uomo disse:
«Questa volta essa / è carne dalla mia carne / e osso dalle mie ossa.
La si chiamerà donna (ishah) /perché dall'uomo (ish) è stata tratta».
Il secondo riguarda la stipulazione dell'Alleanza di JHWH con Abramo.
Gn 15,11 «Gli uccelli rapaci calavano su quei cadaveri, ma Abram li scacciava. 12 Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco un oscuro terrore lo assalì. 13 Allora il Signore disse ad Abram: «Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in un paese non loro; saranno fatti schiavi e saranno oppressi per quattrocento anni. 14 Ma la nazione che essi avranno servito, la giudicherò io: dopo, essi usciranno con grandi ricchezze. 15 Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri; sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. 16 Alla quarta generazione torneranno qui, perché l'iniquità degli Amorrei non ha ancora raggiunto il colmo».
17 Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un forno fumante e una fiaccola ardente passarono in mezzo agli animali divisi. 18 In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram:
«Alla tua discendenza / io do questo paese / dal fiume d'Egitto / al grande fiume, il fiume Eufrate;
19 il paese dove abitano i Keniti, i Kenizziti, i Kadmoniti, 20 gli Hittiti, i Perizziti, i Refaim, 21 gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei».
In entrambi questi casi quando Dio agisce l'uomo dorme: Dio agisce sempre senza fare chiasso!
Questo può spiegare lo sgomento che attanaglia Gesù all'inizio di questo brano e la serenità finale che lo rende capace di affrontare risolutamente la consegna /paradìdomi.
Forse il Padre gli ha parlato e allora non si sente più solo.
Se è così, allora egli è sicuro come l'oro che la sua vita e la sua "baracca" sono saldamente nella mani del Padre Abbà.
Lettura 98 Mc 14,43 - 52 L'arresto di Gesù.
Mc 14,43 «E subito, mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici, e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. 44 Chi lo tradiva / paradìdomi aveva dato loro questo segno: «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta». 45 E venuto subito gli si accostò dicendo: «Rabbì» e lo baciò. 46 Ma essi gli misero addosso le mani e lo presero. 47 Ma uno dei presenti, sfoderata la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio. 48 Allora Gesù disse loro: «Come contro un brigante, con spade e bastoni siete venuti a prendermi. 49 Ogni giorno ero in mezzo a voi a insegnare nel tempio, e non mi avete preso. Ma questo è avvenuto perché si adempissero le Scritture!».
50 E avendolo abbandonato, tutti fuggirono.
51 Un giovanetto, avvolto in un lenzuolo sul corpo nudo, lo seguiva e lo arrestarono. 52 Ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo».
Non è il corpo di polizia del Tempio che viene ad arrestare Gesù, ma una folla armata alla bell'e meglio perché si parla si spade e bastoni. I mandanti sono le autorità del Tempio: sommi sacerdoti, scribi, anziani, cioè il sinedrio. Sono mandanti che stanno in penombra, altrimenti non avrebbero inviato della gente raccogliticcia, ma le loro guardie. Troveremo questa "folla" anche nel processo davanti a Pilato; è una folla anonima, con tutto ciò che di negativo può contenere questo aggettivo.
Una folla diversa da quella incontrata nel Tempio (12,37, Lettura 84) che "lo ascoltava volentieri", la quale nel caso in esame lo avrebbe riconosciuto e pertanto non avrebbe avuto bisogno del segno praticato da Giuda per indicare chi fosse quello da consegnare.
È altresì diversa dalla folla che lo aveva accolto trionfalmente quand'era entrato in Gerusalemme (11,1-11 Lettura 75).
Notiamo che Giuda si avvicina a Gesù e lo bacia, il che implica che Gesù si è lasciato baciare. Avrebbe potuto allontanarlo evitando l'accostamento, ma forse è stato l'ultimo tentativo di ricuperare il suo Apostolo.
Uno dei suoi sfodera una spada. Un piccolo segnale il quale rivela senza dubbio, che tra i suoi c'era qualcuno disposto a menare le mani. Quindi l'idea dello scontro finale in qualche modo animava anche i Dodici e abbiamo visto più volte come la loro idea di Messia accoglieva contenuti radicalmente opposti a quelli che Gesù cercava di fare loro comprendere. Certo, loro erano sicuri che al momento buono avrebbe scatenato la sua potenza come aveva mostrato di saper fare quando scacciava i demoni, guariva i lebbrosi, ecc. Insomma, il profeta potente in parole ed opere non si sarebbe lasciato mettere le mani addosso da quella gentaglia.
Ma Lui non fa nulla, proprio nulla, per evitare di essere consegnato /paradìdomi, perché questo faceva parte del disegno del Padre Abbà: il calice che avrebbe dovuto bere fino in fondo, come abbiamo visto nella lettura precedente (14,36), nell'Ultima Cena (14,22 ss) e nella richiesta di Giacomo e Giovanni (10,35 ss - Lettura 72).
Ecco: i fatti che qui accadono hanno una loro ragione molto remota. Gesù la spiega rimandandone il senso alle Scritture: "perché si adempiano le Scritture".
Gli ultimi due versetti sono stati e sono tutt'ora oggetto di infinite discussioni tra gli esperti. Non riteniamo utile riportare tutte le versioni di queste dispute. Qui ci limitiamo ad indicarne alcune.
In prima battuta segnaliamo che un particolare "storico" di questo tipo potrebbe essere raccontato solo da chi lo ha vissuto, così si è giunti ad affermare che quel giovinetto fosse lo stesso Marco. Egli sarebbe stato nei pressi del Getzemani in una tenda per passare la notte di Pasqua. Svegliato dal trambusto è andato a vedere e così ha subito un tentativo di arresto, poi evitato lasciando in mano alla turba soltanto il lenzuolo.
Però si dice anche che questo ragazzo "lo seguiva", allora finisce per essere una figura di contrasto rispetto ai Dodici i quali alle prime avvisaglie avevano tutti gloriosamente tagliato la corda. Questo giovanetto invece insiste nel seguire Gesù. Resta un dubbio: si trattava di sequela o curiosità?
Un'altra versione più complessa porta l'attenzione sul lenzuolo, in greco "syndòna" italianizzato in sindone. Ora il Vangelo di Marco, senza l'aggiunta canonica, non riporta incontri con il Risorto, ma si limita ad indicare la tomba vuota e un giovinetto (angelo) vestito di una veste bianca (lenzuolo?), che spiega alle donne cos'è accaduto. Se è così, allora Marco ha voluto segnalare ai suoi lettori che tutti gli eventi della Passione che stavano per svilupparsi avrebbero avuto un esito completamente diverso da quello atteso dalle autorità.
Più convincente il tema del lenzuolo se incrociamo Marco con Giovanni perché a proposito della risurrezione Gv 20,5-7 si dice che il sudario e panni di lino sono giacenti per terra. Allora chi lascia il lenzuolo, panni, sudario e se ne va, è Gesù Risorto
Quale la versione più attendibile? Preferiamo rispondere citando un passaggio di P. De Benedetti:
«Ogni versetto della Bibbia ha settanta interpretazioni, la settantunesima è la tua».
Lettura 99 Mc 14,53 - 65 Il processo religioso.
Mc 14,53 «E condussero via Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. 54 Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote; e se ne stava seduto a sedere insieme con le guardi e si scaldava presso il fuoco. 55 Intanto i gran sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. 56 Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e così le loro testimonianze non erano concordi. 57 Ma alcuni si alzarono per testimoniare il falso contro di lui, dicendo: 58 «Noi lo abbiamo udito dire: "Io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d'uomo». 59 Ma nemmeno su questo punto la loro testimonianza era concorde. 60 E, levatosi il sommo sacerdote nel mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?». 61 Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?». 62 Gesù rispose: «IO SONO / EGO' EIMI!
E vedrete il Figlio dell'Uomo/ seduto alla destra della Potenza (Sal 110,1) che viene con le nubi del cielo» (Dn 7,13)
63 Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? 64 Avete udito la bestemmia; che ve ne pare?». Ora, tutti sentenziarono che era reo di morte.
65 Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a velargli la faccia, a colpirlo e a dirgli: «Indovina, fai il profeta». I servi intanto lo prendevano a schiaffi».
Il brano ha come cornice quello che fa Pietro. All'inizio si mescola tra la folla e cerca di capire cosa sta succedendo nel Sinedrio, alla fine avremo il suo triplice rinnegamento che vedremo nella prossima lettura.
Ciò che appare da subito è che la decisione di farlo morire era già stata decisa e che quindi si è trattato di un processo farsa.
Infatti già alla fine delle controversie galilaiche avevamo trovato:
3,6 «E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire» (Lettura 25).
Ricordiamo che farisei ed erodiani non andavano assolutamente d'accordo perché ai secondi la religione non interessava, ma in Galilea era re, fantoccio di Roma, Erode Antipa che aveva il potere di mettere a morte i malfattori.
La decisione viene ribadita a Gerusalemme dopo che Gesù aveva scacciato i mercanti dal tempio:
11,18 «L'udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano come farlo perire, perché avevano paura di lui, perché tutto il popolo era ammirato del suo insegnamento» (lettura 77).
In questo caso però bisognava superare un problema giuridico perché le autorità del tempio non avevano il potere di mettere a morte chicchessia, per cui la loro decisione doveva poi passare al tribunale del procuratore romano, nel caso, Ponzio Pilato. Ben sapendo che la giurisprudenza romana non era incline ad eseguire sentenze di morte per motivi religiosi.
La decisine di metterlo a morte in questo brano raggiunge il suo approdo perché in risposta alla domanda del sommo sacerdote, Gesù afferma in modo inequivocabile la sua origine divina. Le parole che egli usa "IO SONO" che nell'originale greco diventano "EGO' EIMI" sono chiarissime perché è il modo in cui la Bibbia greca dei LXX traduce il nome di Dio "JHWH". In questo modo Gesù afferma di essere JHWH*.
In verità questa affermazione era già stata da lui fatta nell'episodio della tempesta sedata 6,45-56, Lettura 48 di cui riportiamo alcuni versetti:
6,49 «Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: «È un fantasma», e gridarono forte, 50 perché tutti lo avevano visto ed erano rimasti turbati. Ma egli subito rivolse loro la parola e disse: «Coraggio, IO SONO / Egò eimì, non temete!». 51 Quindi salì con loro nella barca e il vento cessò. Ed erano grandemente fuori di sé, 52 perché non avevano compreso il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito».
Però in quella occasione i discepoli non ne avevano afferrato il senso. Marco con un po' di compassione dice: "il loro cuore era indurito", ma non è che poi, nel corso del tempo la loro comprensione si fosse allargata.
Comprensione che il sommo sacerdote afferra al volo e infatti lo accusa di bestemmia.
D'altra parte Gesù non poteva oscurare la sua identità perché il suo venire tra gli uomini aveva esattamente lo scopo di mostrare la assoluta incondizionata dedizione di Dio verso le sue creature. Allora manifesta chiaramente che l'uso dell'espressione "Figlio dell'Uomo" voleva significare proprio:"Figlio di Dio".
Spesso noi usiamo dire "figlio di Dio" per dire che tutti gli uomini sono "figli di Dio", ma si tratta un'espressione simbolica che richiede qualche chiarimento.
Gesù è "Figlio di Dio" perché da Dio è stato generato. Infatti nel credo a riguardo di Gesù proclamiamo: "... Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre...".
Gli uomini in vece sono stati creati, non generati, come dice il libro di Genesi
Gn1,26 «E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 27 Dio creò l'uomo a sua immagine; / a immagine di Dio lo creò; / maschio e femmina li creò.
Allora quando si dice che gli uomini sono "figli di Dio" si vuole semplicemente affermare che tutti gli uomini provengono da Dio, perché tutti sono da Lui pensati ed amati.
Con un ulteriore doverosa precisazione. I cristiani mediate il sacramento del battesimo sono incorporati a Gesù, fanno parte del corpo di Gesù. Il Catechismo della Chiesa Cattolica art. 1243 afferma:
«Il nuovo battezzato è ora figlio di Dio nel figlio Unigenito. Può dire la preghiera dei figli di Dio: il Padre nostro».
Se è così il neo-battezzato vive una nuova realtà, una nuova vita.
Tornando al nostro brano la cosiddetta "bestemmia" di Gesù viene precisata dalla citazione di Daniele 7,13, ribaltata rispetto all'originale, nel quale Il Figlio dell'Uomo sale verso il cielo, mentre Gesù dice che scende dal cielo sulle nubi; nubi che indicano la presenza di Dio. In definitiva, Egli scende dal cielo come giudice escatologico, una funzione riservata esclusivamente a Dio.
A questo punto le false testimonianze non sono più necessarie e la sentenza di morte è inevitabile.
È così "il profeta potente in parole ed opere", il Messia, il Cristo, il Figlio dell'Uomo, Il Figlio di Dio viene consegnato alla marmaglia perché si diverta con botte e scherni.
* Il lettore si sarà accorto che non scriviamo mai il nome di Jahwè con le vocali ma riportando solo le consonanti per ricordare il nome di Dio non viene pronunciato ma sostituito da: Adonai (ebraico), Kyrios (greco) o Signore.
Lettura 100 Mc 14,54; 66 -72 Il rinnegamento di Pietro.
Abbiamo detto che il processo di Gesù davanti al sinedrio è incorniciato da due riferimenti a Pietro ed ora cerchiamo di rifletterci unitariamente.
Mc 54 «Pietro lo aveva seguito / akolouthēō da lontano, fin dentro l'atrio del sommo sacerdote; e se ne stava a sedere insieme con le guardie e si scaldava presso il fuoco. [...]
66 Mentre Pietro era giù nel cortile, viene una delle serve del sommo sacerdote 67 e, vedendo Pietro che si scaldava, dopo averlo fissato gli dice: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». 68 Ma egli negò: «Non so e non capisco quello che dici». Uscì quindi fuori verso l'atrio. [E un gallo cantò].
69 E la serva, avendolo visto, cominciò a dire ai presenti: «Costui è di quelli». 70 Ma egli di nuovo negava.
E dopo un po' di tempo i presenti dicevano a Pietro: «Tu sei certo di quelli, infatti sei Galileo». 71 Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo di cui parlate». 72 E subito per la seconda volta un gallo cantò e si ricordò Pietro della parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre volte». E scoppiò a piangere».
Il verbo akolouthēō è molto importante perché è il verbo tecnico per indicare una sequela convinta.
Una prima volto lo troviamo alla chiamata dei primi discepoli in riva al lago di Galilea.
1,16 «Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 17 Gesù disse loro: «Venite con me, vi farò diventare pescatori di uomini». 18 E subito, lasciate le reti, lo seguirono / akolouthēō»
Un'altra volta lo troviamo dopo la confessione di Pietro a Cesarea di Filippo e la prima predizione della Passione, un passaggio in cui Pietro si trova coinvolto in prima persona, perché rimprovera il Maestro per quelle parole così dimesse e rinunciatarie. Sicuramente egli sente queste successive parole rivolte in primis a sé:
8,34 «E chiamata a sé la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua / akolouthēō». (Lettura 60)
Quando nel Getzemani hanno arrestato Gesù, Marco racconta l'episodio del giovinetto:
Mc 14,51 «Un giovanetto, avvolto in un lenzuolo sul corpo nudo, lo seguiva / akolouthēō e lo arrestarono. 52 Ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo».
Anche nel nostro brano il verbo akolouthēō / seguire viene applicato a Pietro.
Allora all'arresto di Gesù tutti tagliano la corda tranne il giovinetto avvolto nel lenzuolo e Pietro.
Il ragazzo scappa via quando cercano di afferrarlo, Pietro invece prosegue perché agisce con prudenza.
Infatti lo segue "da lontano". Certo, "da lontano" però Pietro non molla il suo Maestro.
Lasciamo al lettore il compito di approfondire quale sia il legame che spinge Pietro a seguire Gesù fin dentro la casa del Sommo sacerdote.
Che comunque è un rischio non da poco! Compreso quello di essere inchiodato ad una croce insieme al Maestro.
Dapprima, nel cortile, Pietro viene riconosciuto da una serva e abbiamo la sua prima reazione. Poi la stessa donna denuncia Pietro agli altri, quelli con i quali condivideva il calore della fiamma e abbiamo la seconda reazione.
Infine sono gli stessi soldati e servi a riconoscerlo, non dalla sua immagine, ma dalla sua parlata.
Quindi il processo di riconoscimento via via si precisa e si allarga, passando da una donna a tutti i presenti.
Corrispondentemente anche la reazione di Pietro diventa sempre più puntigliosa.
1 - «Non capisco cosa dici».
2- «Ma egli di nuovo negava».
3- «Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo di cui parlate».
Giurare significa chiamare Dio a testimonianza della verità che si afferma. Pietro giura il falso. Pietro diventa un falso testimone. Azione condannata dalla Legge di Mosè:
Es 20,16 «Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo».
Quindi Pietro oltre ad avere rinnegato Gesù ha giurato il falso.
Ma precisamente cosa ha rinnegato?
Egli aveva maturato in sé due immagini del suo maestro, quella che a partire dalla Galilea fino a Gerusalemme aveva mostrato di essere un profeta potente in parole ed opere. Aveva guarito infermi, sanato lebbrosi, scacciato demoni, aveva dibattuto coraggiosamente con scribi, farisei, erodiani e sacerdoti, quindi un profeta come mai ce n'erano stati. Allora era proprio il Messia promesso agli antichi padri. Quello che avrebbe messo tutti in riga.
Ma adesso, in quel palazzo, Egli si presenta, umile, dimesso, picchiato dai soldati, sbeffeggiato dai servi e deriso da tutti i presenti. Non un gesto per difendersi, non un miracolino piccolo piccolo come gli aveva visto fare durante questi in tre anni.
Allora si era sbagliato di grosso, aveva preso una solenne cantonata.
Lui non poteva ancora capire che il suo Maestro stava per morire per lui, Pietro. Il suo Maestro doveva accettare una morte terribile perché potesse dimostrare, una volta per tutte, il vero volto di Dio. Un Dio Abbà che pur di non fare altri crocifissi è disposto a prendersi Lui la croce.
Però ancora una volta il Maestro gli viene in aiuto:
72 «E subito per la seconda volta un gallo cantò e si ricordò Pietro della parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre volte».
Pietro allora si rende conto di non essere stato "mollato".
È accaduto quel miracolino che ha cambiato la sua, di Pietro, situazione, il suo cuore.
Se è così, allora il suo "pianto dirotto" si commenta da solo.
Lettura 101 Mc 15,1-20 Il processo davanti a Pilato
All'inizio abbiamo un versetto di transizione che consente la connessione tra il processo davanti al sinedrio e quello davanti a Pilato. Gesù viene incatenato non tanto perché si tema una fuga, ma per umiliarlo mentre è costretto a passare tra due ali di folla.
Mc 15:1 «E subito, il mattino i gran sacerdoti, fatto un consiglio, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver incatenato Gesù, lo condussero e lo consegnarono / paradìdomi a Pilato».
Il resto del brano che stiamo per esaminare intreccia diversi elementi e dobbiamo strutturarlo secondo la concezione degli antichi per stabilire un ordine di importanza.
A => 2 - 5 La regalità derisa
B => 6 - 11 Gesù e Barabba
C => 12 - 14 crocifiggilo => questa parte non essendo ripetuta è il messaggio più importante del brano
b => 15 Gesù e Barabba
a => 16 - 20 Regalità derisa
=> A => 2 «E Pilato lo interrogò: «Sei tu il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». 3 E i sommi sacerdoti lo accusavano di molte cose. 4 Ora, Pilato lo interrogava di nuovo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano!».
5 Ma Gesù non rispose più nulla, sicché Pilato ne restò meravigliato.=> B => 6 Ora, in occasione di ogni festa egli rilasciava loro un carcerato, quello che richiedevano. 7 Ora, c'era uno, detto Barabba, incatenato con i rivoltosi, che nella rivolta avevano commesso un omicidio. 8 E la folla, salita su, cominciò a chiedere ciò che sempre egli le concedeva. 9 Allora Pilato rispose loro: «Volete che vi rilasci il re dei Giudei?». 10 Sapeva infatti che i sommi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. 11 Ma i gran sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro piuttosto Barabba.
=> C =>12 Pilato replicò: «Che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei Giudei?». 13 Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». 14 Ora Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Allora essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!».
=> b => 15 E Pilato, volendo accontentare la folla, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò / paradìdomi perché fosse crocifisso.
=> a => 16-20 Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la coorte. 17 Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. 18 Cominciarono poi a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». 19 E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui. 20 Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo».
1- Regalità derisa A 2- 5
Comprendiamo subito che i gran sacerdoti di fronte a Pilato hanno modificato l'imputazione. Non più "bestemmia" perché si era dichiarato "figlio di Dio" (14, 61, Lettura precedente), argomento che per un tribunale romano non avrebbe avuto alcun interesse, ma "re dei giudei", quindi un'accusa con un chiaro risvolto politico che minaccerebbe il potere dell'imperatore.
Al di là di ogni altra considerazione, in questo processo, la famosa giustizia romana, nota ancora oggi per la sua giurisprudenza, ne esce con le ossa rotte. Anche in questo caso Gesù è sottoposto ad un processo farsa e Pilato fa la figura di chi non è in grado di prendere una decisione, per cui è conosciuto ancora oggi.
Abbiamo conservato i verbi all'imperfetto che nell'originale greco, significano un'azione continuata nel tempo. Ad esempio «Ora, Pilato lo interrogava di nuovo», quel "interrogava" dovrebbe essere inteso come: "continuava ad interrogarlo" o "insisteva nell'interrogarlo".
Questo ci segnala che Pilato è convinto dell'innocenza di Gesù ed è alla ricerca di elementi che gli permettano di salvarlo, ma ha contro di sé i gran sacerdoti e tutta la folla, da essi istruita, che accusano Gesù di fomentare la rivolta contro Roma. E così Pilato, come si racconta in altri evangeli, se ne lava le mani.
Dante, nel terzo canto dell'inferno colloca gli ignavi, da lui talmente disprezzati che nessuno di loro è nominato, ma il famose versetto “Vidi e conobbi l’ombra di colui / che fece per viltade il gran rifiuto” è molto probabilmente riferito proprio Ponzio Pilato.
Ora, la domanda di Pilato: «Sei tu il Re dei Giudei», ottiene la risposta: «Tu lo dici» che risulta ambigua perché non si capisce se sia una conferma o una smentita. Però essa è formulata quattro volte in questo brano, il che significa è una affermazione molto importante.
2 - Gesù e Barabba => 6-11
Pilato fa un primo tentativo di salvare l'innocente Gesù incaricando la folla di scegliere tra il Nazareno e Barabba. Curioso il fatto che il significato del nome Barabba deriva da "bar - abbà": figlio di suo padre, cioè figlio di padre ignoto, che così viene messo a confronto con il "Figlio di Dio Abbà".
3- crocifiggilo => 12-14
In questa struttura pensata da Marco, il messaggio più importante sta al centro; cioè i versetti corrispondenti a
C => 12 - 14, il che significa che il "suo" popolo, il popolo di Gesù, pretende che egli venga crocifisso. In altre parole che il Messia atteso, l'Unto, il Cristo, regni dalla croce. Il trono del Figlio di Dio è la croce. Allora il Regno di Dio è una realtà ben diversa da tutti i regni conosciuti.
Inconsapevolmente questa folla, ben diversa da quella presente qualche giorno prima durante l'ingresso trionfale a Gerusalemme, realizza il disegno del Dio Abbà.
4- la regalità derisa => 16-20
In tutta questa vicenda Pilato concede a Gesù un sorta di grazia: la flagellazione, un mezzo per abbreviare la durata della crocifissione nella quale il condannato poteva restare lì appeso ai chiodi che trapassavano mani e piedi, feriti e dolenti, anche per quattro o cinque giorni.
La flagellazione nelle province romane era eseguita con fruste fatte di strisce di cuoio cui erano fissati frammenti di osso appuntiti, scaglie di metallo che entravano nella pelle del condannato fino strappare pezzi di carne. Il condannato legato ad una colonna o sdraiato a terra, veniva colpito da uno o più torturatori finché essi erano stanchi. Giuseppe Flavio nel suo "Guerra giudaica" racconta di una flagellazione proseguita fino a che si videro le ossa. Raramente un flagellato riusciva a sopravvivere più di qualche giorno dopo tale trattamento.
Senza volerlo Pilato realizza la profezia fatta da Gesù nel terzo annunzio della passione:
10,33 «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi: lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, 34 lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno; ma dopo tre giorni risusciterà».
A questo trattamento estremamente doloroso si aggiungono anche gli scherni per il divertimento dei soldati, proprio come avevano fatto durante la notte i servi e le guardie dei gran sacerdoti del sinedrio.
Durante tutto questo episodio Gesù dice solo due parole e poi fanno di lui tutto quello che a loro pare; lui è del tutto solo, isolato pur in mezzo a tanta gente. L'unico che ha un po' di compassione per lui, ma non ha il coraggio di essere conseguente, per via della sua paura, è paradossalmente proprio Ponzio Pilato. Il cui nome è richiamato sette volte.
Raramente Marco è così preciso nel raccontare i fatti come questi che riguardano la passione di Gesù.
Forse la sua intenzione è quella di evidenziare ai suoi lettori la fatica fatta dal Figlio di Dio per salvarci.
Lettura 102 Mc 15,20-24 Verso la crocifissione: Simone di Cirene
Mc 15,20«Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo conducono fuori per crocifiggerlo.
21 E costringono un passante, un certo Simone di Cirene che tornava dalla campagna, il padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. 22 E lo conducono / ferousin alla località Gòlgota, che tradotto significa: Luogo del Cranio, 23 e gli volevano dare vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese.
24 E lo crocifiggono e si spartiscono le sue vesti tirandole a sorte (Sal 22,19) quale ciascuno dovesse prendere».
Appena usciti dal pretorio le guardie applicano il diritto di angaria costringendo uno che stava passando a portare la croce. Segno evidente che le botte che erano state inflitte durante la notte dai servi del sinedrio, quelle ricevute dai soldati romani in prima mattina e soprattutto la flagellazione avevano ridotto Gesù in una condizione tale da non riuscire più neanche a portare la croce. Dobbiamo chiarire che il condannato non portava tutta la croce, ma solo il palo traverso, il patibulum, mentre il palo verticale era permanentemente infisso nel terreno nel luogo fuori dalla mura destinato a quei supplizi.
Le condizioni fisiche di Gesù sono anche suggerite nel versetto 22 in cui si dice che Gesù "viene condotto" ma l'originale greco "ferousin" significa "portato". Certo il verbo "portare" può anche significare "condurre", ma il dubbio in un lettore attento rimane. Il rischio per i soldati era di arrivare al luogo della crocifissione con un cadavere, per questo prendono il primo che passa e gli mettono sulle spalle la croce.
Il passante caricato della croce di Gesù è "Simone, il padre di Alessandro e Rufo" e questo è un particolare il quale suggerisce che fosse una persona conosciuta dalla prima comunità di cristiana di Gerusalemme, così come sembra siano ben conosciuti anche i figli dei quali, il primo porta un nome greco, il secondo un nome romano e il padre è di Cirene quindi uno straniero. Si sa che nella Città Santa esisteva una numerosa comunità della Cirenaica costituita da giudeo- ellenisti o proseliti.
Ora Simone è anche il nome originario di Pietro, ma il Simone Apostolo non è lì ad aiutare il Maestro, perché dopo averlo rinnegato è andato a nascondersi. C'è invece capitato questo "straniero" aperto sia al mondo ellenistico che a quello romano se stiamo al nome dato ai suoi figli.
Simone di Cirene torna dai campi e questo crea qualche problema perché non si torna dal lavoro dei campi prima delle nove del mattino e per giunta, siamo in un giorno di festa o di vigilia della festa di Pasqua e in entrambi i casi, in rispetto al terzo Comandamento, non si può lavorare né percorre distanze superiori a un paio di chilometri. Questo non toglie che Simone sia semplicemente andato nel suo orto. Ad ogni modo resta il fatto che semplicemente passando di lì ha collaborato fattivamente e più di altri con il Messia. E lui neanche lo sapeva.
Il percorso fatto da Gesù e Simone non era una passeggiata perché dovevano passare tra due ali di folla che li insultava, all'interno di un corteo che comprendeva i tre condannati e i soldati che non lesinavano bastonate e frustate.
Il Golgota (aramaico) o Calvario (latino) o Luogo del Cranio in realtà non è una montagna sulla cima della quale si vedono le tre croci come solitamente vediamo nelle raffigurazioni, ma era una cava forse solo un po' più rialzata rispetto all'intorno. In realtà non possiamo darne una descrizione attendibile perché dopo la distruzione di Gerusalemme del 70 d. C. e l'ulteriore distruzione avvenuta nel 130 d. C. e l'edificazione della nuova città con un nome che non aveva alcun legame con il passato, cioè "Aelia Capitolina", ad opera dell'Imperatore Adriano, quella zona è stata completamente spianata. Inoltre duecento anni dopo, l'Imperatore Costantino ha fato costruire la basilica del Santo Sepolcro che ingloba sia il luogo della crocifissione che quello della sepoltura. In definitiva l'ambiente esistente al tempo di Gesù è stato radicalmente trasformato e la sua immagine perduta.
Prima di crocifiggerlo gli danno da bere vino con mirra, una bevanda che stordisce e attenua il dolore. L'uso dell'imperfetto ci dice che l'azione è stata insistente. Non è detto chi fosse l'autore di questo gesto, soldato o qualcuno mosso a pietà, è certo che Gesù lo rifiuta e lo possiamo attribuire a due motivi: restare perfettamente lucido di mente e mantenere ciò che aveva affermato durante l'Ultima Cena:
25 «Amen, vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio».
Ma questo segnala un altro elemento da non sottovalutare. In una situazione in cui la sua persona è legata e messa alla mercé dei soldati, Egli conserva uno spazio, seppur limitato, alla sua volontà: la libertà di dire di no.
Sembra paradossale, ma Gesù viene crocifisso da uomo libero.
Lettura 103 Mc 15, 24-32 La crocifissione e le derisioni
Mc 15,24 «E lo crocifiggono e si spartiscono le sue vesti tirandole a sorte (Sal 22,19) quale ciascuno dovesse prendere.
25 Ed era l'ora terza (nove del mattino) quando lo crocifissero. 26 E l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: Il re dei Giudei. 27 E con lui crocifiggono due banditi, uno alla sua destra e uno alla sinistra. 28 [E si compì la Scrittura che dice: Fu annoverato tra gli iniqui *] 29 I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo (Sal 22,8), dicendo: «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni, 30 salva te stesso scendendo dalla croce!».
31 Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri, non è capace di salvare se stesso! 32 Il Cristo, il re d'Israele! Scenda ora dalla croce, affinché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano crocifissi con lui lo insultavano».
La crocifissione avveniva stendendo il condannato a terra con le mani distese sopra il palo trasversale, patibulum, e legandolo o inchiodandolo ad esso. Quindi veniva issato lungo il palo verticale già infisso nel terreno facendolo giungere ad un incavo al quale rimaneva fissato. Quindi si procedeva a legare o inchiodare i piedi. L'abilità del crocifissore nel caso dei chiodi, era di non rompere arterie sanguigni importanti altrimenti il condannato sarebbe morto in breve tempo per dissanguamento. I romani avevano trovato dove fossero questi punti che erano all'altezza del polso per gli arti superiori e nel calcagno per quelli inferiori. Per prolungare il supplizio ponevano sul palo verticale, all'altezza adeguata, uno spuntone che passava tra le gambe sul quale il condannato si sedeva. La morte infatti avveniva per soffocamento quando il peso del corpo, finito sulle mani e con i muscoli stremati, non consentiva più alla muscolatura del torace di dilatare e comprimere i polmoni.
Noi restiamo sorpresi come Marco non dica nulla di tutto questo. Si ritiene per due motivi: una forma di rispetto verso il Maestro ed evitare una descrizione inutile visto che tutti sapevano benissimo come avvenivano le crocifissioni perché erano eseguite in luogo pubblico, in quanto dovevano servire come forma di ammonizione alla gente. Per questo sulla croce veniva posto un cartello illustrante il motivo della condanna.
Marco non dice nemmeno quale tecnica avessero usato, ma sappiamo solo dal Vangelo di Giovanni che Gesù venne inchiodato.
Giocarsi a carte le vesti del condannato vuol dire che questi era stato spogliato. Il condannato era inchiodato completamente nudo sulla croce per evidenziare al massimo grado la sua povertà o nullità. Infatti l'abito non ha solo una funzione protettiva, ma anche denotativa. L'abito dice chi tu sei. Soprattutto nei secoli passati, quando ognuno doveva vestirsi secondo quello che prescriveva la corporazione di appartenenza. Per strada, si poteva distinguere un medico da un fabbro, un falegname da un contadino, un giudice da un insegnante e via dicendo. Questo a maggior ragione succedeva nei tempi antichi. Nei romanzi russi di epoca zarista si legge che giudici e poliziotti interrogavano gli imputati tenendoli completamente nudi.
La nudità è la massima espressione della povertà di una persona.
Così a Gesù, oltre a tutta la sofferenza inflittagli per effetto della crocifissone, dovette subire anche l'umiliazione della completa nudità. Che si aggiunge a tutte le altre derisioni. Derisioni e scherni che sono rette da verbi all'imperfetto il che significa che sono state insistenti e prolungate.
Coloro che scherniscono o insultano Gesù sono raggruppati in tre categorie:
I passanti che usano alcuni aspetti della sua predicazione con la chiara intenzione di mostrarla falsa: "se non scendi dalla croce sei un falso profeta".
Poi ci sono sommi sacerdoti e scribi che, finalmente, possono avere la loro rivincita dopo tutte le sconfitte verbali subite, prima in Galilea e poi nel tempio di Gerusalemme.
Infine ci sono i due banditi. In realtà, siccome Roma non condannava a morte i ladri, ma li vendeva come schiavi o li condannava ai lavori forzati, gli esperti ritengono che questi fossero due sediziosi, due ribelli come Barabba e in tal caso anche Gesù viene annoverato tra i ribelli. Tanto più che era accusato di essersi dichiarato: "Re dei Giudei". Si tratta di una "compagnia" particolarmente umiliante per Gesù perché la sua colpa agli occhi del popolo, non sarebbe apparsa come religiosa, ma una insubordinazione all'autorità, una semplice trasgressione alle leggi di Roma.
Questa umiliazione non si manifesta solo al momento della crocifissione, ma era iniziata già quando si era formato il corteo dei tre condannati che portandosi sulle spalle il loro patibulum, dovettero sfilare per Gerusalemme tra due ali di folla ostile e denigrante.
Ecco, anche questi due "ladroni" come li chiama la tradizione, se la prendono con Gesù perché con tutti i miracoli che aveva fatto poteva farne uno in più e tirarli giù dalla croce.
In verità sarebbero altri due i personaggi, Giacomo e Giovanni, che avevano chiesto: 10,37 «Dacci di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra», ma qui nel momento della manifestazione della gloria del Figlio dell'Uomo, loro sono altrove.
l significato implicito in tutte le derisioni riguarda il tipo di messia che gli ebrei si attendevano: un messia potente che avrebbe sgominato tutti i suoi nemici e avrebbe ribadito la verità di Dio. Se fosse sceso dalla croce, li avrebbe avuti tutti ai suoi piedi.
Ma in effetti Gesù stava attuando pienamente la verità di Dio che propriamente è la verità dell'amore. Un amore che dona tutto se stesso perché l'amato abbia vita in abbondanza.
In ogni religione è conosciuto il martirio di chi vuole affermare la propria fede, anche in quella di Israele, ma nel caso del Messia questa possibilità non è neanche pensabile.
Così Gesù muore in quel modo per affermare la verità di Dio, donando tutto se stesso.
* Questo versetto è presente solo in alcuni codici e non riportato dalla CEI.
Lettura 104 Mc 15,33-41 La crocifissione. Le tenebre.
Mc 15,33 « E venuta l'ora sesta (mezzogiorno), si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona (le 15). 34 E all'ora nona Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? (Sal 22,2) 35 E alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Vedi! Chiama Elia!». 36 Ora, un tale corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere,(Sal 69,22) dicendo: «Lasciate! Vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce». 37 Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.
38 Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso.
39 Ora, il centurione presente di fronte a lui, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!» (Sap 2,18).
40 Ora, c'erano anche delle donne, che osservavano da lontano, tra le quali anche Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo il minore e di Giosè, e Salome 41 le quali, quando era in Galilea lo seguivano e lo servivano, e molte altre, che erano salite con lui a Gerusalemme».
Una nuova liturgia. Marco insiste nell'evidenziare le ore.
15:1 «Presto al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo condussero e lo consegnarono a Pilato». Questo corrispondeva all'ora prima, le nostre sei.
15, 25 «Ed era l'ora terza (nove del mattino) quando lo crocifissero».
15,33 «E venuta l'ora sesta (mezzogiorno)...»
15, 34 «E all'ora nona Gesù gridò (tre del pomeriggio)...»
15,42 «Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la Parascève, cioè la vigilia del sabato...»
In questo modo Marco mette in evidenza le ore in cui si svolgeva la preghiera nel tempio. Ma qui non siamo al tempio, ma sul Calvario. Marco vuole suggerire che qui inizia una nuova Liturgia che supera quella del tempio perché è celebrata / vissuta dallo stesso Figlio di Dio, crocifisso.
Ricordiamo che ancora qualche decennio fa la liturgia delle ore aveva conservato la scansione originaria: prima, terza, sesta, nona, vespero, compieta. Forse, dovremmo ricordare quando recitiamo le "ore" stiamo facendo memoria della crocifissione di Gesù.
Le tenebre 33 « E venuta l'ora sesta (mezzogiorno), si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona (le 15)».
Questo buio che inizia a mezzogiorno e termina alle quindici costituisce un problema per gli esegeti.
Vi sono quelli che hanno cercato una giustificazione geofisica, come, ad esempio, un eclisse solare, cosa impossibile a Pasqua perché essa è celebrata nel giorno della prima luna piena di primavera. "Luna piena" significa che la terra sta in mezzo tra il sole e la luna e al più potrebbe esserci un eclissi di luna, ma non di sole. Si è pensato ad un temporale particolarmente forte e con nubi molto spesse, oppure al vento del deserto che sollevando enormi quantità di polvere e sabbia oscura il cielo, però non vi sono elementi che possano dare conferme.
Più verosimilmente Marco ha voluto accennare ad alcuni eventi biblici. Ne prendiamo in considerazione due.
Un fenomeno simile è la nona piaga della famose dieci piaghe d'Egitto.
Es 10,21 «Poi JHWH disse a Mosè: «Stendi la mano verso il cielo: verranno tenebre sul paese di Egitto, tali che si potranno palpare!». 22 Mosè stese la mano verso il cielo: vennero dense tenebre su tutto il paese d'Egitto, per tre giorni. 23 Non si vedevano più l'un l'altro e per tre giorni nessuno si potè muovere dal suo posto. Ma per tutti gli Israeliti vi era luce là dove abitavano».
Questo evento fa parte delle dieci piaghe che hanno portato alla liberazione del popolo d'Israele dalla schiavitù dell'Egitto. Allora, tenebre come "evento di liberazione".
Lo stesso fenomeno delle tenebre durante il giorno lo troviamo nella tradizione profetica a partire da Amos quando parla del "Giorno del Signore". Lo spieghiamo brevemente.
Dopo la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, Dio ha stabilito con Israele l'Alleanza, ma Egli non ha potuto che constatare, come in molte occasioni, la Sua Alleanza (mai "nostra") si stata tradita. I molti richiami fatti mediante i Giudici prima, i Profeti poi, sono sempre caduti nel vuoto. Israele è un popolo duro di orecchi, di "dura cervice", che continua ad andare avanti per la sua strada: adora gli dèi dei popoli vicini, non rispetta i Comandamenti, trasgredisce la Torah, non si prende cura degli orfani e delle vedove, la categoria più fragile in quei tempi. Il suo popolo gli sfugge continuamente.
A JHWH resta un solo modo per incontrare, finalmente, il suo popolo: venire di persona e compiere ogni giustizia discriminando buoni e cattivi. Quando il Signore, finalmente, viene, quello è "Il giorno del Signore". Ecco come lo descrive il profeta Amos; e raccomandiamo di leggere gli interi capitoli 5 e 8.
Am 8,9 «In quel giorno - oracolo del Signore Dio - / farò tramontare il sole a mezzodì
e oscurerò la terra in pieno giorno! / 10 Cambierò le vostre feste in lutto /e tutti i vostri canti in lamento:
farò vestire ad ogni fianco il sacco, / renderò calva ogni testa:
ne farò come un lutto per un figlio unico / e la sua fine sarà come un giorno d'amarezza...»
Am 5,18 «Guai a coloro che attendono il giorno del Signore!
Che sarà per voi il giorno del Signore? / Sarà tenebre e non luce.
19 Come quando uno fugge davanti al leone / e s'imbatte in un orso;
entra in casa, appoggia la mano sul muro / e un serpente lo morde.
20 Non sarà forse tenebra e non luce / il giorno del Signore...»
Ancora più esplicito il profeta Gioele:
Gl 3,4 «Il sole si cambierà in tenebre / e la luna in sangue, / prima che venga il giorno del Signore,
grande e terribile. / 5 Chiunque invocherà il nome del Signore / sarà salvato,
poiché sul monte Sion e in Gerusalemme / vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore,
anche per i superstiti che il Signore avrà chiamati».
Allora nel "Giorno del Signore" tutti i miseri, gli orfani e le vedove, tutti quelli che invocano il suo nome e a Lui si affidano otterranno finalmente giustizia e salvezza (Vedi anche Gl 4,5; Is 13,10; 24,23).
Se effettivamente questo è il pensiero di Marco, allora le tenebre, che avvolgono Gesù sulla croce, indicano che lì si stava proprio manifestando "il Giorno del Signore" con un capovolgimento rispetto alla tradizione profetica: quella croce non è tanto segno della malvagità dell'uomo, che pure è presente, né della collera di Dio, ma soprattutto di un amore divino senza misura (B. Maggioni).
Così queste tenebre diventano segno escatologico.
Lì si sta mostrando una novità definitiva che cambia radicalmente il procedere della storia.
Lettura 105 Mc 15,33-39 La crocifissione: le morte e la confessione del centurione.
Mc 15,33 « E venuta l'ora sesta (mezzogiorno), si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona (le 15). 34 E all'ora nona Gesù gridò / boàō a gran voce: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? (Sal 22,2) 35 E alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Vedi! Chiama Elia!». 36 Ora, un tale corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere,(Sal 69,22) dicendo: «Lasciate! Vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce». 37 Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.
38 Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso.
39 Ora, il centurione tra i presenti di fronte a lui, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!» (Sap 2,18).
40 Ora, c'erano anche delle donne, che osservavano da lontano, tra le quali anche Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo il minore e di Giosè, e Salome 41 le quali, quando era in Galilea lo seguivano e lo servivano, e molte altre, che erano salite con lui a Gerusalemme».
La preghiera di Gesù. L'ultima sua preghiera, mostra tutta la drammaticità di quel momento.
Gesù non chiede a Dio: "Non abbandonarmi", ma « ...perché mi ha abbandonato». Gesù si sente abbandonato dal Dio Abbà. Se è così, sulla croce si sta svolgendo un dramma Trinitario perché per la prima volta la relazione eterna, da sempre esistente fra le Tre Persone viene ad interrompersi.
Potremmo riflettere sulle conseguenze di questa frattura se smettessimo di pensare il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè e di Gesù Cristo come se fosse l'impassibile Motore Immobile aristotelico.
Il Figlio di Dio muore come un uomo qualunque. E come tanti figli d'Israele, prima di lui, invoca JHWH con le parole del salmo 22: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato»?
Il senso di essere abbandonato, sperimentato da Gesù, è rafforzato anche da un altro argomento, quello del fallimento. Questa preghiera è specificata come " gridò / boàō a gran voce". Il verbo boàō è usato solo all'inizio del Vangelo di Marco riferito a Giovanni Battista:
Mc 1,2 Come è scritto nel profeta Isaia:
Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada.
3 Voce di uno che grida/ boàō nel deserto: preparate la strada del Signore, / raddrizzate i suoi sentieri,
Quel gridò / boàō aveva come fine: "raddrizzare i sentieri, preparare la strada per il Signore", bene, il Signore è arrivato, ha girato per tre anni dentro e fuori di Israele, ha fatto una fatica tremenda per istruire i suoi discepoli, ma adesso è lì inchiodato: il Dio Abbà non interviene, i suoi discepoli hanno gloriosamente tagliato la corda, si sono scandalizzati, il loro capo lo ha addirittura rinnegato... Più fallimento di così!?! Forse si sente anche in colpa per questo. Gli resta solo un gancio cui aggrapparsi: «Dio mio, Dio mio...»
Infatti, se in questa preghiera è presente il tema del sentirsi abbandonato, non dobbiamo trascurare la doppia invocazione «Dio mio, Dio mio». Gesù si sente abbandonato, ma nutre ancora fiducia e spera nel Dio Abbà.
Eppure da parte del Dio Abbà, che aveva parlato durante il battesimo 1,10-11 e alla Trasfigurazione 9,7, non viene nessun segnale, nessuna Parola; solo un tremendo e assoluto silenzio.
E soprattutto, estremamente importante, Gesù non chiede al Dio Abbà di farlo scendere dalla croce, ma di non farlo sentire solo e abbandonato. Anche in quella situazione sconvolgente, Gesù è un uomo libero che insiste a perseguire il disegno del Padre. Così, Gesù è obbediente fino all'ultimo respiro.
Ma forse questa non è l'ultima preghiera.
L'ultima preghiera è il forte grido che precede la morte. Un grido che non può essere non ascoltato dal Dio Abbà, ché come dice il salmo: «Il povero che grida Dio lo sente / e da tutte le sue angosce lo salva» (Sal 71).
L'ultima derisione. C'è un tale che gli dà da bere mediante una spugna. Questo ci fa capire che la croce di Gesù era del tipo "alto", in modo che tutti vedessero da lontano come vengono trattati i ribelli. Per questo occorre una canna. Si spiega la sete perché la forte perdita di sangue deve essere compensata dall'assunzione di acqua. L'aceto aggiunto all'acqua aiuta a smorzare la sete; era usato anche dai nostri contadini quando dovevano lavorare a lungo nei campi.
Questo che sembra un gesto di pietà, si trasforma subito in una derisone. L'ultima! Segno che quel tale, probabilmente un soldato, non conosceva l'ebraico e quindi non ha riconosciuto che «Eloì, Eloì» fosse un invocazione verso Dio e non verso Elia.
Breve annotazione. Elia era vissuto nel nono secolo a. C., non era morto, ma era stato rapito in cielo, però si riteneva che sarebbe ritorno per preparare l'arrivo del Messia. Ma Elia non arrivava mai, per cui si era diffusa l'usanza di dire: "Viene Elia a..." per significare una cosa che non sarebbe mai accaduta.
Lo squarcio del velo. Nel tempio originariamente era depositata l'Arca dell'Alleanza che conteneva le tavole della Legge. Sull'arca stavano i cherubini. Dopo la caduta di Gerusalemme ad opera dei babilonesi nel 587 a. C. quegli oggetti sacri furono irrimediabilmente perduti. Al tempo di Gesù questo atrio del tempio era completamente vuoto, a differenza dei templi pagani che contenevano la statua del dio. Infatti, lo sanno tutti, il Dio di Israele non si può vedere né rappresentare con immagini perché è puro spirito. Però questo spazio ospitava la Kavod, la Gloria di Dio, la quale, in quanto di Dio, non si vede. Questo atrio che costituiva la parte più importante del tempio, il Santo dei Santi, era protetto da un velo. Vi poteva entrare solo una volta l'anno il Sommo Sacerdote nel giorno dello Yom Kippur, riempiendo tutto l'atrio con il fumo dell'incenso.
Nessuno poteva vedere l'interno del Santo dei Santi perché era protetto da un velo.
Nel nostro testo lo squarcio di questo velo dall'alto in basso è descritto nella forma impersonale e ciò vuol dire che esso è stato opera di Dio; è l'impersonale divino. Adesso si può dire che là dentro non c'è più nulla da vedere: la Gloria di Dio, la Kavod se n'è andata squarciando il velo, appunto, ed ora è lì sulla croce con il Crocifisso. Adesso la Kavod, Dio stesso, si può vedere nella forma del Figlio Crocifisso. Una conseguenza del Mistero dell'Incarnazione.
Il centurione
Ora Marco ci lascia a bocca aperta raccontandoci la reazione del centurione, l'ufficiale che aveva guidato il corteo con i suoi soldati e aveva provveduto ad inchiodare i tre ribelli. E intanto sotto le croci aspettava che morissero.
Lui è lì insieme agli altri "presenti", l'unico che non ha deriso il «Re dei giudei». Gli altri "presenti" i derisori applicavano il testo di Sap 2,18 ss in senso restrittivo: avrebbero visto l'intervento di Dio se il "Re dei Giudei" si fosse schiodato dalla croce
Sap 2,18 «Se il giusto è figlio di Dio, egli l'assisterà, / e lo libererà dalle mani dei suoi avversari.
19 Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti, / per conoscere la mitezza del suo carattere
e saggiare la sua rassegnazione.
20 Condanniamolo a una morte infame, / perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà».
Ma è proprio il centurione , il crocifissore, l'unico dei presenti che non l'ha deriso a scorgere nel Suo restare lì inchiodato il "Dito di Dio" e a riconoscere la vera identità del Messia:
«Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!»
E come fa a dirlo? Neanche Pietro era arrivato a tanto perché nella confessione di Cesarea 8,29 si era limitato a dire:
«Tu sei il Cristo» e gli era trotterellato dietro da un bel po'; aveva visto guarigioni, cacciate di demoni, ecc. mentre per questo soldato pagano non ci sono stati miracoli, segni particolari, ma soltanto un: «avendolo visto a spirare in quel modo».
Certo, questo centurione chissà quante crocifissioni aveva eseguito, ma non aveva mai incontrato un condannato che stesse in silenzio, non inveisse contro i soldati, non maledicesse quelli che gli conficcavano i chiodi nelle mani e nei piedi. Con questo «Re dei giudei», i fatti si sono svolti in una maniera del tutto imprevedibile. Addirittura secondo Luca perdonò chi lo crocifiggeva: Lc 23,34 «Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno».
In definitiva per Marco, sembra di capire, che per giungere alla fede non occorre attendere la Risurrezione, basta, o è necessario, guardare al Crocifisso.
Quasi di sfuggita Marco accenna che sul Calvario non c'è nessuno dei suoi, ci sono solo alcune donne che guardano "da lontano". Queste donne svolgeranno un ruolo molto importante.
Un ultima osservazione. Siamo proprio sicuri che il Dio Abbà non abbia parlato?
Se fosse proprio così, lo squarcio nel velo del tempio e la fede "improvvisa" del centurione, da dove provengono?
Lettura 106 Mc 15,42-47 La sepoltura di Gesù.
Mc 15,42 «Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la Parascève, cioè la vigilia del sabato, 43 Giuseppe d'Arimatèa, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. 44 Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo. 45 Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. 46 Questi allora, comprato un lenzuolo / sindòna, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo / sindòna, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra contro l'entrata del sepolcro. 47 Intanto Maria di Màgdala e Maria madre di Ioses stavano ad osservare dove veniva deposto».
Come premessa dobbiamo ricordare che il supplizio della croce, se i crocifissori operavano bene, poteva durare anche diversi giorni prima che il condannato morisse. Roma poi aveva diverse modalità nel trattare il corpo dei crocifissi defunti a secondo delle provincie e di periodi storici. Potevano essere gettati in una fossa comune o lasciati appesi alla mercé di corvi o insetti fino alla putrefazione dei cadaveri. Era un metodo che serviva ad ammonire chi non intendesse rispettare le leggi.
In Israele era necessario osservare, almeno fino ad un certo punto, le leggi e le tradizioni locali per evitare insurrezioni. Tuttavia non è che neanche gli ebrei fossero molto teneri da questo punto di vista. 2 Sam 21 racconta come una discendete di Saul restò a lungo, giorno e notte, a protegge sette tra figli e parenti impiccati per impedire che uccelli rapaci e animali dilaniassero i loro corpi.
Tuttavia il libro del Deuteronomio, redatto intorno al 600 a. C, prescrive:
Dt 21, 22 «Se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte e tu l'avrai messo a morte e appeso a un albero, 23 il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché l'appeso è una maledizione di Dio e tu non contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità».
Ora, il protagonista del nostro brano è Giuseppe d'Arimatèa, il quale si preoccupa di adempiere alla Legge e quindi togliere la salma di Gesù dalla croce. Risulta altresì chiaro che anche i due ladroni crocifissi non possono rimanere esposti durante la notte e infatti Gv 19,32 dice che ai due ladroni crocifissi con Gesù spezzarono le gambe per affrettarne la morte.
Il gesto di Giuseppe d'Arimatèa membro del sinedrio evidenzia due aspetti.
1- La condanna inflitta a Gesù dal sinedrio (14,53ss) ci porta a ritenere che in quel consesso non ci fosse unanimità o che essa fosse solo formale.
2- Giuseppe d'Arimatèa compie un gesto coraggioso, perché andare da Pilato a chiedere il corpo di un ribelle, "Re dei Giudei" era la motivazione della condanna, era come confessare di essere uno di quelli. Pensando poi alla venalità dei procuratori e governatori romani nelle provincie, non è azzardato ritenere che la salma fosse concessa dietro lauto compenso.
Però Pilato concede il corpo del Messia solo dopo essersi accertato che fosse effettivamente morto.
La meraviglia di Pilato ci suggerisce che la flagellazione subita da Gesù è stata talmente dura da farlo morire prima del tempo.
Per il resto del brano osserviamo che Giuseppe esegue tutta l'operazione da solo e questo ci rimanda a ciò che è stato narrato a proposito del martirio di Giovanni Battista 6,14-29 Lettura 44 in cui si dice:
6,29 «I discepoli di Giovanni, saputa la cosa, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro»,
mentre i discepoli di Gesù dall'arresto nel Getzemani in poi, scandalizzati, si sono resi irreperibili.
Il brano termina con una osservazione, messa lì quasi di sfuggita, come quella ai piedi dalla croce:
47 «Intanto Maria di Màgdala e Maria madre di Ioses stavano ad osservare dove veniva deposto».
Ancora una volta le donne sono testimoni e fanno da figura di contrasto rispetto ai discepoli!
Lettura 107 Mc 16,1-8 Le donne al sepolcro
Mc 16:1 «E passato il sabato, Maria la Maddalena, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. 2 E al mattino presto, il giorno uno dal sabato [Cei: primo giorno dopo il sabato], vennero al sepolcro al sorgere del sole. 3 E dicevano tra loro: «Chi ci rotolerà via la pietra dall'entrata del sepolcro?». 4 E, guardando, videro che la pietra era stata rotolata via, benché fosse molto grande. 5 Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, rivestito d'una veste bianca, e rimasero impietrite dallo stupore. 6 Ma quello disse loro: «Non state lì impietrite! Voi cercate Gesù Nazareno, il Crocifisso. È risorto, non è qui. 7 Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». 8 E uscite fuori, fuggirono via dal sepolcro. Erano infatti spaventate e fuori si sé. E non dissero niente a nessuno, perché avevano paura».
1- Nel nostro testo troviamo una prima precisazione temporale « passato il sabato» e poi una seconda tradotta solitamente con «primo giorno della settimana o primo giorno dopo il sabato» ritenendo che l'originale greco: «giorno uno » sia un semitismo.
Però Marco, essendo un buon conoscitore del greco, usa il numero cardinale con una intenzione precisa: rimandare il lettore alla numerazione dei sette giorni della Creazione di Gen 1che, appunto, in ebraico usa la numerazione cardinale. Così al termine del primo giorno della creazione, nel testo ebraico, troviamo:
Gn 1,5 «...e Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: giorno uno[CEI: primo giorno] ».
Se è così Marco vuole fare intendere che è iniziata una nuova creazione, ultima e definitiva, nella quale la morte non ha più luogo perché è stata sconfitta. Questo nuovo giorno è il giorno definitivo in cui non ci sarà più tramonto.
2- L'unzione delle salme dei defunti con aromi non era usata in Israele, per la gente comune, ma era riservata solo ai re. Allora queste donne, che avevano seguito Gesù dalla Galilea e avevano assistito "da lontano" alla crocifissione 15,40-41e più tardi alla sepoltura 15,47 pensano di ungere il cadavere come se fosse un re, più esattamente come se fosse quel Messia che avevano seguito e che, tradito, aveva fallito la sua missione. La loro idea di messianità era quella tradizionale che avevano appreso sin bambine. E adesso, purtroppo, devono constatare che era andata male.
Il loro problema è la grossa pietra posta all'ingresso del sepolcro che a loro non sarebbe stato possibile rimuovere, ma con loro grande sorpresa trovano la pietra già rimossa «benché fosse molto grande» e pesante. L'uso del verbo nella forma impersonale di questa frase suggerisce l'impersonale divino, cioè la pietra è stata rimossa grazie ad un intervento di Dio. Ovvio che non siamo in grado di stabilire se ciò sia avvenuto ad opera del Dio Abbà o di Gesù stesso perche testimoni della risurrezione non ce ne sono, né in Marco né negli altri evangeli. Gli evangeli riportano solo di racconti di incontro con il Crocifisso Risorto.
L'intenzione delle donne di ungere il cadavere, ci dice che queste donne, come gli apostoli e gli altri discepoli, non avevano compreso le profezie di Gesù a proposito della sua condanna, crocifissione e risurrezione che aveva ribadito per ben tre volte:
8,31 «E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare».
9,31 «Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo sta per esser consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risusciterà».
33 «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi: lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, 34 lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno; ma dopo tre giorni risusciterà».
3 - Marco, a differenza degli altri evangelisti, non racconta una teofania, ci presenta un giovane, non un angelo, che in poche parole, ma molto dense fa intendere alle donne che la loro ricerca è sbagliata. Gesù non deve essere cercato in un sepolcro tra i morti.
L'uso intenzionale di "Nazareno" rimanda alle tre volte in cui Gesù è stato chiamato con questo nome, sempre in ambito, diremmo, politico, rivendicativo perché i galilei erano noti per le loro rivendicazioni politiche, dato che la Galilea era passata sotto dominio straniero già dall'ottavo secolo a. C. con la caduta di Samaria capitale del Regno del Nord. Quindi anche questo giovinetto vuol fare intendere che Gesù non è venuto per attuare un disegno politico, ma di più ampio respiro. L'unzione del suo cadavere sarebbe fuori luogo anche perché la sua unzione è stata anticipata a Betania durante un banchetto (14,1-11, Lettura 92).
Ora dobbiamo riflettere sulla figura del "giovane" che le donne trovano nel sepolcro. Esso rimanda chiaramente al giovinetto incontrato in 14,51-52 che aveva tentato di seguire Gesù appena arrestato e quando i soldati cercano di afferrarlo, era scappato via nudo lasciando il lenzuolo.
Qui nel sepolcro troviamo un giovane seduto, tranquillo, sicuro di sé, non con un lenzuolo, ma con una veste candida.
Il primo è fuggito per non seguire Gesù nella sua vicenda, questo invece mostra di essere coinvolto nella risurrezione del Maestro.
Se il primo anticipava la fuga dei discepoli e il rinnegamento di Pietro, questo ricorda l'appuntamento che Gesù aveva preso con i suoi durante l'ultima cena: 14,32 «ma dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea». In sostanza le parole di questo giovane comunicano che i discepoli sono stati reintegrati nella loro funzione.
Si tratta di una bella notizia, un evangelo, appunto: Gesù è risorto e vi aspetta in Galilea dove tutto è iniziato e dove si deve ricominciare.
Ma le donne sono impaurite, terrorizzate a tal punto che fuggono di corsa e non dicono nulla a nessuno.
Resta la tomba vuota con quel giovane il quale conosce che Gesù è risorto.
E se le donne non dicono nulla di ciò che hanno visto, chi può raccontare, con coraggio, perché ci vuole coraggio, la lieta notizia della morte della morte?
Marco non risponde, perché il suo Vangelo termina qui. I versetti successivi 16,9-20 sono presi qua e là dagli altri evangeli da qualche redattore successivo e peraltro assenti in molti codici.
Allora chi diffonde la lieta notizia?
Sei tu caro lettore.
E lo puoi essere, se hai fatto esperienza dell'amore che Gesù ha nutrito per te, per me, per noi. E lo puoi essere se la tua fede è cresciuta come quella del centurione. Allora tu, mentre la vita ti sposta qua e là, devi con grande coraggio proclamare la tua fede ai quattro venti.
Lettura 108 TEMA DEI DISCEPOLI PRIMA FASE
Premessa
Nel corso delle nostre letture può essere nata l'impressione di avere fatto delle riflessioni alquanto pesanti nei confronti degli Apostoli e dei primi discepoli, ma è il testo che li presenta effettivamente in luce negativa. La colpa non deve essere attribuita a Marco ma dipende dagli stessi Apostoli. Marco si ritiene fosse una sorta di segretario di Pietro che non poteva fare altro che scrivere ciò che il capo degli Apostoli raccontava e predicava.
Quindi questi testi nascono ad opera degli stessi primi discepoli quando essi sono ormai le "colonne" della Chiesa, con l'intenzione di rimuovere un'idea che nutrivano i loro ascoltatori. Un'idea del tipo: «se noi fossimo stati lì ad ascoltare, vedere e toccare Gesù, la nostra fede sarebbe dura come la roccia».
La risposta dei primi discepoli cerca di frantumare questa idea dicendo: «noi c'eravamo, Gli abbiamo trotterellato dietro per tre anni e, a nostra vergogna, non l'abbiamo capito. Lui ha dovuto sottoporsi al giudizio dei capi del popolo, essere crocifisso, morire e poi risorgere perché i nostri occhi si aprissero».
Da qui nasce uno dei primi kerygma: «Morto per i nostri peccati», in cui il peccato è quello dell'incredulità. Allora riprendiamo in forma sintetica e schematica il processo che, da un lato, ha portato i primi discepoli alla fede e, dall'altro l'immane fatica che ha dovuto fare il Figlio di Dio perché i loro occhi si aprissero.
Nel vangelo di Marco cogliamo tre fasi di sviluppo della vicenda dei discepoli attraverso la quale noi riusciamo anche a capire che cosa Marco vuole comunicare alla sua chiesa.
PRIMA FASE - Entusiasmo della sequela
Innanzitutto abbiamo nei primi sei capitoli una triplice sequenza di scene che sono strettamente legate fra di loro e conducono ad un climax. Esse sono poste all'inizio di ogni sezione:
a- la chiamata dei primi quattro discepoli 1,16-20
1,16 «Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 17 Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini». 18 E subito, lasciate le reti, lo seguirono. 19 Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano le reti. 20 Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca con i garzoni, lo seguirono».
b- la chiamata dei dodici 3,13-19
3,13 «Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. 14 Ne costituì Dodici che stessero con lui 15 e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demòni».
c- la missione dei dodici 6,7 -13
6,7 «Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. 8 E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa; 9 ma, calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche. 10 E diceva loro: «Entrati in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo».
In questi capitoli, attraverso queste tre scene, Marco presenta i dodici in una luce positiva e il lettore tende ad identificarsi con essi.
La prima scena, la chiamata dei quattro, ha al suo centro la parola imperativa di Gesù che invita a seguirlo. Questa parola: "seguitemi" diventerà la norma fondamentale sulla base della quale il lettore potrà giudicare successivamente il comportamento, dei discepoli.
Questa parola normativa svela che in questo momento la risposta dei discepoli è positiva.
La seconda scena. In 3,13-19 veniamo a sapere che Gesù ha chiamato i suoi discepoli per un più stretto e particolare rapporto con lui e per un peculiare compito che li attende.
Il racconto sottolinea che la loro posizione accanto a Gesù è frutto di una libera elezione d'amore da parte di Gesù. Questa nuova posizione in cui l'elezione li colloca, comprende due aspetti: 1- l'essere con lui e 2 - la prospettiva di una missione, cioè proclamare e scacciare i demoni. Ciò che prima era presentato come compito specifico di Gesù ora viene reso possibile anche ai suoi discepoli.
Nella terza scena la missione è presentata come realizzata con successo. Una prospettiva positiva dunque, per i discepoli che sono 1- scelti da Gesù, 2- sono chiamati a stare con lui 3- e attuano il compito per il quale li ha chiamati.
Quindi queste tre scene collocano i dodici in una luce positiva nel loro rapporto con Gesù e nella somiglianza del loro ruolo missionario con quello di Gesù. Questa positività viene rafforzata da altri testi che si incontrano all'interno di questi primi sei capitoli. Qui il metodo per dare risalto al senso, è quello della somiglianza / contrasto, cioè vedere dove l'evangelista colloca i discepoli. Troviamo questa tecnica in tre scene:
a - In Mc 2,14-28, all'interno del capitolo delle dispute, non solo viene attaccato Gesù, ma anche i suoi discepoli. Quindi nel contesto del contrasto tra Gesù e gli scribi anche i discepoli sono posti sotto accusa, e Gesù mentre difende il suo comportamento, difende anche quello dei suoi discepoli.
Quindi essi appaiono in sintonia con Gesù ed in contrasto con i suoi nemici.
c - In Mc 4,10-12 quelli intorno a Gesù insieme ai dodici sono contrapposti a «quelli fuori». A quelli intorno a Gesù è affidato il mistero del regno, mentre per quelli di fuori tutto avviene in parabole.
Da questa visione positiva dei dodici, sintetizzata in queste tre scene inducono nel lettore grandi attese che, però, se non si realizzeranno lo lasceranno colpito e deluso, inducendolo a rivedere ancor più criticamente la figura dei discepoli. Possiamo dire dunque che in questa
• L'espressione autoritativa di Gesù in 4,11-12: «a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio, a quelli di fuori tutto invece viene esposto in parabole» servirà da norma sulla cui base l'autore misurerà la fedeltà dei discepoli. È quindi posto un principio che mette in guardia il lettore e la comunità di Marco.
• Già in questo capitolo 4, dopo vv 11-12, attraverso la parabola del seminatore, viene posto il problema dell'ascolto della parola e l'ammonimento che non sempre la parola cade sul terreno buono.
E infatti subito dopo Gesù si esprime in forma critica verso i discepoli in 4,13 ove dice: «se non conoscete questa parabola come potrete conoscere tutte le altre», cioè state attenti perché questa incomprensione può avere ulteriori sviluppi.
4, 38 «Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t'importa che moriamo?». 39 Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. 40 Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?».
Lettura 109 TEMA DEI DISCEPOLI SECONDA FASE
SECONDA FASE - La sequela diventa problematica
Nella seconda fase di sviluppo del tema dei discepoli la tecnica della triplice narrazione ci permette di evidenziare come effettivamente dagli ammonimenti del c 4, la vicenda si sviluppi in negativo fino ad un culmine che è costituito da Mc 8,14-21.
Ritroviamo detta triplice composizione riemerge nelle scene della barca sul lago:
1- La tempesta sedata 4,35-41
4,36 «E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. [...] 37 Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. 38 Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t'importa che moriamo?». 39 Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. 40 Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?». 41 E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?».
2- Gesù che cammina sulle acque 6,45-52
6,47 «Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli solo a terra. 48 Vedendoli però tutti affaticati nel remare, poiché avevano il vento contrario, già verso l'ultima parte della notte andò verso di loro camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. 49 Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: «È un fantasma», e cominciarono a gridare, 50 perché tutti lo avevano visto ed erano rimasti turbati. Ma egli subito rivolse loro la parola e disse: «Coraggio, sono io, non temete!». 51 Quindi salì con loro sulla barca e il vento cessò. Ed erano enormemente stupiti in se stessi, 52 perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito».
3- Gesù che sulla barca ammonisce i suoi discepoli 8,14-21
8,14 «Ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un pane solo. 15 Allora egli li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!». 16 E quelli dicevano fra loro: «Non abbiamo pane». 17 Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non intendete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? 18 Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E non vi ricordate, 19 quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici». 20 «E quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Sette». 21 E disse loro: «Non capite ancora?».
Queste tre scene vanno viste in progressione e sono legate da alcuni elementi comuni:
a- i discepoli soli con Gesù sulla barca e lontani dalla folla
b- le prime due scene sono legate anche dal motivo della difficoltà che i discepoli hanno con l'acqua
c- la loro paura da un lato e la manifestazione di potenza di Gesù dall'altro
d- tutte e tre le scene mostrano una incapacità di comprendere da parte dei discepoli
e- la seconda e la terza scena sono tra loro legate dal motivo della moltiplicazione dei pani
Ambedue le moltiplicazioni sono precedute da un dialogo di Gesù con i discepoli.
Nella prima sono i discepoli a fare presente a Gesù i bisogni delle, folle
6,35 «Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: «Questo luogo è solitario ed è ormai tardi; 36 congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, possano comprarsi da mangiare».
Gesù tenta di coinvolgerli nel dono del pane, ma essi rispondono negativamente.
Segue la scena di Gesù che cammina sulle acque che si conclude con l'annotazione della paura dei discepoli 6,52 «perché non avevano compreso il segno dei pani e il loro cuore era indurito».
Quindi la seconda moltiplicazione dei pani al c 8 preceduta da un breve dialogo in cui Gesù è presentato come "Pastore escatologico" che ha compassione della folla e fa presente ai discepoli il bisogno della gente. I discepoli non sono più neppure coloro che stimolano Gesù, ma egli stesso prova compassione per le folle. E di nuovo i discepoli fanno obiezione.
La conclusione di questo ulteriore sviluppo avviene nella terza scena sulla barca dove viene fortemente sottolineata la cecità, la sordità e 1'incomprensione dei discepoli.
7,14 «Ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un pane solo. 15 Allora egli li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!». 16 E quelli dicevano fra loro: «Non abbiamo pane». 17 Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non intendete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? 18 Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E non vi ricordate, 19 quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici». 20 «E quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Sette». 21 E disse loro: «Non capite ancora?».
L'incomprensione, che all'inizio era solo una possibilità, la troviamo qui realizzata dai discepoli.
Quegli stessi verbi attribuiti in 4,12 a "quelli di fuori", sono ora usati da Gesù contro i dodici: «non udite, non vedete, non comprendete, avete il cuore indurito».
La loro non disponibilità e incomprensione li ha portati ad essere simili a quelli di fuori. Non sono più la sua famiglia a differenza del c3:
3, 34 «Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 35 Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre».
Qui nel vertice di queste tre scene, i discepoli sono posti nella luce più negativa: sono su posizioni che assomigliano a quelle dei nemici di Gesù.
In questo modo la chiesa di Marco è avvertita: la sua iniziale vita cristiana può svilupparsi negativamente.
Perciò Marco stimola la sua comunità a sviluppare questa comprensione e questo ascolto che è mancato ai discepoli.
Si crea così nel lettore una forte tensione poiché prima si è identificato nei discepoli, ed ora se ne distacca poiché la loro vicenda può essere anche la sua e della sua comunità.
Ultima annotazione: sembra essere una tecnica di Marco quella per cui man mano che si assiste al venir meno dei discepoli sorgono figure e scene di contrasto.
In questa sezione ne incontriamo due:
1- la guarigione del sordomuto della Decapoli in 7,31-37 che guarito da Gesù diventa il tredicesimo apostolo, un cripto discepolo perché : «20 Egli se ne andò e si mise a proclamare / kērussō per la Decàpoli ciò che Gesù gli aveva fatto, e tutti ne erano meravigliati»
2- e del cieco di Betsaida in 8,22-21 che dopo l'imposizione delle mani da parte di Gesù «... e eneblepsen / vedeva dentro ogni cosa distintamente».
Il progressivo allontanamento dei discepoli da Gesù sembra momentaneamente risolversi con la confessione di fede di Pietro che era stata preparata da due altri interrogativi sull'identità di Gesù in 4,41 e 6,14.
4,39 «Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. 40 Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?». 41 E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?».
6, 14 «Il re Erode sentì parlare di Gesù, poiché intanto il suo nome era diventato famoso. Si diceva: «Giovanni il Battista è risuscitato dai morti e per questo il potere dei miracoli opera in lui». 15 Altri invece dicevano: «È Elia»; altri dicevano ancora: «È un profeta, come uno dei profeti». 16 Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risuscitato!».
8,29 «Ma egli replicò: «E voi chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». 30 E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno».
Ora la chiesa di Marco può identificarsi con la professione di Pietro di 8,29 perché anche lei riconosce che Gesù è il Cristo.
Lettura 110 TEMA DEI DISCEPOLI TERZA FASE
TERZA FASE - La sequela diventa scandalo: rinnegamento e abbandono
Proprio mentre il lettore è aiutato tramite la professione di fede di Pietro ad identificarsi con i discepoli, subito è ammonito da Gesù ed è messo in questione: «cominciò ad insegnare apertamente che il Figlio dell'Uomo doveva soffrire molto...». Questo nuovo sviluppo è interessante anche per capire alcune condizioni della chiesa di Marco.
Da 8,31 alla fine di c.10 c'è un triplice schema costituito da: 1- predizione, 2 - incomprensione, 3 - insegnamento, con un climax, un'enfasi accentuata sempre sulla terza parte. Nella struttura dei tre elementi il culmine spetta agli insegnamenti.
In 8,34-35 e 10,45 Gesù è presentato come modello. Questo insegnamento che presenta Gesù come modello lega il motivo della imminente morte pronunciata nelle predizioni con due problemi che, presumibilmente, erano quelli della comunità marciana:
1- la possibilità della persecuzione e del martirio 8,34-38
8,34 «Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 35 Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà. 36 Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima? 37 E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? 38 Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi».
2- la discussione o problema sui ranghi primaziali all'interno della comunità 9,33-37:
9,33 «Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo lungo la via?». 34 Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. 35 Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti». 36 E, preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro:
37 «Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me; chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».
Attraverso questi due temi Marco mette a fuoco due problematiche aperte nella sua comunità a proposito dei quali vuol dare un insegnamento a partire dal modello di Gesù che sta andando verso la croce. Quindi attraverso il climax cogliamo le possibili situazioni della comunità a cui Marco si rivolge.
Mentre Marco invita alla sequela sulla strada della croce accettando la possibilità della persecuzione fino al martirio e accettando di essere i primi facendo gli ultimi e i servi di tutti, dall'altra parte sottolinea l'incomprensione da parte dei discepoli.
Se nella prima parte l'incomprensione è data dall'apprensione per se stessi e il proprio ruolo, nella seconda invece è data dalla preoccupazione e dalla paura di fronte alla sofferenza e di fronte al ministero della diaconia.
Forse per l'autore era importante il tema dell'autorità nella comunità, dato che è ripreso due volte nella seconda e terza istruzione.
Anche il tema del martirio e della sofferenza deve essere stato importante poiché è presente anche nella scena-istruzione della Trasfigurazione in 9,7 dove alla prospettiva teofanica si aggiunge anche l'imperativo "ascoltatelo"; cioè servitelo sulla strada della croce:
9,7 «Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!». 8 E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù»
A questi inviti di Gesù non fa seguito alcuna risposta positiva da parte dei discepoli. Non presentando alcuna risposta positiva l'autore lascia intendere che, a questo appello esigente di Gesù vi può essere una risposta molteplice. Chiaramente questi appelli sono rivolti anche ai lettori, e lo si capisce perché queste esortazioni hanno forma di carattere generale.
Vi sono anche problematiche minori che si evidenziano sul tema dei discepoli. Ne esaminiamo alcune
• In 9,14-29 i discepoli non sono capaci di scacciare un demonio perciò si dimostrano incapaci di assolvere la missione affidata loro da Gesù.
9,14 «E giunti presso i discepoli, li videro circondati da molta folla e da scribi che discutevano con loro. 15 Tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. 16 Ed egli li interrogò: «Di che cosa discutete con loro?». 17 Gli rispose uno della folla: «Maestro, ho portato da te mio figlio, posseduto da uno spirito muto. 18 Quando lo afferra, lo getta al suolo ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti».
• In 9,38-40 i discepoli si contrappongono ad un comando imperativo di Gesù perché impediscono ad uno che non è della loro cerchia di compiere esorcismi. Eppure cacciare i demoni faceva parte della missione del regno.
9,38 «Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demòni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato, perché non era dei nostri». 39 Ma Gesù disse: «Non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. 40 Chi non è contro di noi è per noi».
• In 10,13-16 i discepoli sono mostrati in luce negativa perché scacciano i piccoli dimostrando così di non accogliere l'insegnamento di Gesù sui piccoli e sugli ultimi.
10,13 «Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. 14 Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. 15 In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso». 16 E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro li benediceva».
• In 10,23-31 dopo l'episodio del giovane ricco, e il detto: "È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago...» c'è un dialogo sulla ricchezza e c'è la promessa finale di Gesù del centuplo in ricchezze e persecuzioni.
10,28 «Pietro allora gli disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». 29 Gesù gli rispose: «In verità vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, 30 che non riceva già al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna. 31 E molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi».
In questi brani il redattore, mostrando i discepoli in contrasto con il mandato e l'insegnamento di Gesù, invita i suoi lettori a scegliere: o per Gesù o per i discepoli.
Questa incomprensione preannuncia anche ciò che accadrà dal cap.14 in poi, quando Gesù percorrerà la strada della croce si attuerà il fallimento della sequela da parte dei dodici.
Mentre fra Gesù e i discepoli aumenta il divario e la tensione, appare una figura di contrasto: il cieco Bartimeo. Egli una volta guarito, segue Gesù sulla strada verso Gerusalemme.
10,46 «E giunsero a Gerico [...] E mentre partiva [...]il figlio di Timèo, Bartimèo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. 47 Costui, al sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». [...] 49 Allora Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». E chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio! Alzati, ti chiama!». 50 Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 51 Allora Gesù gli disse: «Che vuoi che io ti faccia?». E il cieco a lui: «Rabbunì, che io riabbia la vista!». 52 E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada».
• Nei capp.11 e 12 i discepoli scompaiono; Gesù a Gerusalemme è nel contesto delle ultime dispute che preludono al contrasto definitivo e quindi alla passione. Si tratta delle "Controversie di Gerusalemme" che evidenzieranno gli oppositori che vedremo a parte.
I discepoli invece ritornano al c.13 dove quattro di essi sono destinatari del grande discorso escatologico-apocalittico. Questo c. 13 contiene alcuni ammonimenti che saranno validi anche dopo la Pasqua, ma posti qui, prima della passione servono anche come predizioni sulle quali misurare poi l'atteggiamento che i discepoli terranno durante la passione. Ad esempio:
In 13,9-13 Gesù annuncia che i discepoli dovranno subire persecuzioni e morte ma dovranno rimanere saldi sino alla fine: richiesta puntualmente smentita dall'abbandono dei discepoli nel cap. 14.
13,9 «Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti a governatori e re a causa mia, per render testimonianza davanti a loro. 10 Ma prima è necessario che il vangelo sia proclamato a tutte le genti. 11 E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi di ciò che dovrete dire, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato: poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. 12 Il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre il figlio e i figli insorgeranno contro i genitori e li metteranno a morte. 13 Voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato».
In 13,33-36 Gesù esorta ad essere svegli e a non lasciarsi trovare addormentati dal ritorno del figlio dell'uomo. Quest'ammonimento è già metro di giudizio per l'atteggiamento che i discepoli terranno nel Getsemani.
13,33 «State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso. 34 È come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. 35 Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, 36 perché non giunga all'improvviso, trovandovi addormentati. 37 Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!».
• Ultimo quadro: la narrazione della passione dal cap.14 in poi.
È significativo che i tre aspetti più negativi nell'atteggiamento dei discepoli, cioè il significato del tradimento di Giuda, l'abbandono di tutti i discepoli ed il rinnegamento di Pietro siano tutti e tre predetti da Gesù.
Questa è la tecnica del coinvolgimento del lettore che resta in attesa della tragedia che sta per avvenire. E di fatto il lettore verificherà che ciò che gli è stato preannunciato, accadrà anche in forma più accentuata del previsto.
• Il tradimento di Giuda verrà appesantito da due azioni simboliche: dal fatto che egli è colui che ha intinto il pane nel piatto di Gesù, cioè da colui che ha avuto comunione di mensa con Gesù in 14,18-21 e dal fatto che il tradimento si consumerà con l'azione simbolica del bacio nel Getzemani in 14,44-45.
• Il rinnegamento dei discepoli predetto da Gesù è appesantito dal fatto che essi sostengono che non potrà mai accadere.
• Nel Getsemani 14,32-42 Gesù torna tre volte dai suoi discepoli e li trova addormentati.
In 14,50 viene sottolineato che la fuga dei discepoli, predetta da Gesù, è vergognosa poiché è seguita dalla scena della fuga del giovinetto nudo, il quale abbandona la "sindone" che secondo Marco potrebbe essere il simbolo del martirio e della morte che i discepoli sono chiamati ad accogliere e che invece sfuggono.
• Il triplice rinnegamento di Pietro è preceduto dall'annotazione che Pietro lo seguiva "da lontano", da timoroso, che contrasta chiaramente con l'autoproclamazione che Gesù fa di sé di fronte al sommo sacerdote.
Quindi il misconoscere Gesù è contrasto con il fatto che Gesù, ormai di fronte alla morte, si autoproclama nella sua identità profonda di Cristo Figlio dell'Altissimo, in faccia al sommo sacerdote.
Allora questi tre elementi, tradimento di Giuda, fuga dei discepoli e rinnegamento di Pietro, si attuano nella forma più catastrofica.
Mentre i discepoli sembrano venir meno alla sequela, il lettore è invitato a prendere le distanze e riprendere il rapporto con il Signore risorto.
• Le parole di 14,28 e 16,7: «Ma io vi precederò in Galilea, là mi vedrete", detti durante la cena e riaffermati dal giovinetto nel racconto del sepolcro vuoto, dicono che l'incontro con il Risorto può sempre rimettere in moto la sequela che era stata tradita.
L'incontro e la ripresa non sono però descritti perché non sono qualcosa di inevitabile, ma solo una possibilità offerta al credente.
• Mentre si accentua la distanza tra Gesù e i discepoli, aumentano le figure di contrasto:
- Bartimeo
- la donna che unge il corpo di Gesù a Betania e si dimostra la "discepola" che ha già compreso il mistero della morte e risurrezione di Gesù
- Simone di Cirene che porta la croce di Gesù: Mc impiega lo stesso verbo usato in 8,34: «chi vuole seguirmi rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua».
- il centurione che rimane sotto la croce e riconosce il Figlio di Dio crocifisso
- le donne che seguivano Gesù da lontano, fin dalla Galilea, e da lontano guardano la sua croce
- Giuseppe d'Arimatea che seppellisce Gesù e in un certo senso, secondo alcuni autori, si manifesta discepolo di Gesù: Mc aveva evidenziato che Giovanni il Battista, profeta martire e anticipatore della Passione di Gesù, era stato seppellito dai suoi discepoli. Mentre i nostri non hanno nemmeno avuto il coraggio di stare a vedere.
Lettura 111 IL TEMA DEGLI OPPOSITORI
Riprendiamo ora in forma sintetica la figura degli oppositori di Gesù che abbiamo incontrato più volte nelle nostre riflessioni. Per certi versi gli oppositori stanno dalla parte opposta a quella dei discepoli, ma ci sono dei "ma", che indagheremo nella prossima lettura.
Gli oppositori appartengano a gruppi diversi: scribi, anziani, sacerdoti, farisei, i parenti, gli abitanti di Nazareth, etc, le denominazioni sono diverse, ma è interessante osservare che lo schema, la logica che li guida in fondo è identica. In gruppi o singolarmente sono presenti lungo tutto il Vangelo, però si condensano in particolari agglomerati come:
• le controversie di Galilea 2,1-3,6 dove emerge la figura dell’oppositore e il perché dell'opposizione. In questo gruppo potremmo includere anche il successivo dibattito con gli scribi 3,22-30 in cui Gesù è accusato di cacciare i demoni con l'aiuto del principe dei demoni.
Abbiamo trovato poi la polemica circa l'osservanza puramente esteriore della legge 7,1-13;
• E infine: le controversie a Gerusalemme c 11-12.
• Ci sono oppositori anche durante la passione e sotto la croce.
La figura dell'oppositore non ha una storia, mentre il discepolo ha una sua storia con un suo sviluppo. Mentre dei discepoli principali conosciamo il luogo di provenienza, il mestiere che facevano, qual era la famiglia di appartenenza ecc., degli oppositori non veniamo a saper nulla. Pietro faceva il pescatore, Andrea era suo fratello e conosciamo anche il nome del padre. L'oppositore appare come un lampo: è presente solo per la durata di una polemica e poi sparisce senza sapere di lui alcunché.
Elemento particolarmente importante per la cultura epocale è la mancanza del nome; non c'è un solo oppositore che appaia con il suo nome.
Ne deriva una nozione interessante: l'incredulità non ha storia, appare e resta così com'è. Il venire alla fede invece richiede un percorso più o meno complicato come abbiamo visto nelle letture precedenti e pertanto traccia una storia.
Le controversie in Galilea: Mc 2,1-3,6
• La prima controversia riguarda la guarigione del paralitico calato dal tetto e gli oppositori sono degli scribi:
2,6 «Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: 7«Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?».
• La seconda è condotta da alcuni scribi della setta dei farisei perché Gesù condivide il pranzo con personaggi di malaffare. I contestatori, però, non hanno neanche il coraggio di rivolgesi direttamente a Gesù:
2,16 «Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori?».
• La terza riguarda la pratica del digiuno che i discepoli di Gesù non praticavano ed è avanzata da dei farisei:
2,18 « [...] Si recarono allora da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?».
• La quarta è condotta ancora dai farisei perché i discepoli di Gesù mangiano spighe di grano in giorno festivo:
2,23 «In giorno di sabato Gesù passava per i campi di grano, e i discepoli, camminando, cominciarono a strappare le spighe. 24 I farisei gli dissero: «Vedi, perché essi fanno di sabato quel che non è permesso?».
• La quinta avviene nella sinagoga di Cafarnao innescata dalla guarigione di un uomo con la mano inaridita in giorno di sabato ed è silenziosamente elaborata dai presenti durante celebrazione, ma poi vede decisamente all'opera farisei ed erodiani:
3,6 «E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire».
Siamo solo all'inizio e come mai tanto accanimento?
La ragione è contenuta in una sorta di spiegazione presente nella controversia centrale, la terza quella relativa al digiuno:
2,21«Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio; altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore. 22 E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi».
Gesù è portare novità insopportabili a chi è abituato ai soliti comportamenti e non è in grado neanche di immaginare che la propria idea di Dio richieda di essere corretta. Le novità sostenute da Gesù possono essere così sintetizzate: "Dio è misericordioso, Dio ti vuole bene. Dio non ti richiede infinite pratiche legalistiche per concederti il suo affetto". Una novità che abbiamo esplorato nell'analisi delle singole controversie dalla Lettura 19 alla 26.
• Dopo essersi ritirato sul monte a pregare e avere istituito i dodici come suoi apostoli, troviamo un altro gruppo di oppositori che sono ancora scribi venuti apposta da Gerusalemme, segno che la notizia dei prodigi che avvenivano in Galilea per opera Sua era arrivata fino in Giudea.
Il problema per questi oppositori sta nel modo di spiegarsi la ragione della capacità di operare questi miracoli e soprattutto la cacciata dei demoni. La loro spiegazione ribalta il senso di questi eventi fuori dal comune, non attribuendoli ad interventi divini, ma alla capacità di Satana, Lettura 31.
3,22 «Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demòni per mezzo del principe dei demòni».
La pericope termina con l'affermazione che chi pensa in questo modo, commette il peccato più grave, quello che non può essere perdonato, perché va contro lo Spirito santo.
• Un altro momento altrettanto forte dal contenuto profondamente teologico, nonostante le apparenze, è la discussione del capitolo 7,1-13 che riportiamo per intero perché viene analizzata nel profondo, più che l'ipocrisia degli scribi e farisei, la patologia religiosa dalla quale sono affetti. Questi oppositori essendo venuti direttamente da Gerusalemme dovrebbero essere delle figure di tutto rispetto della religione di Israele.
7,1«Allora si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. 2Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè non lavate - 3 i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito, attenendosi alla tradizione degli antichi, 4 e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, stoviglie e oggetti di rame - 5 quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani immonde?».
6 Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me . 7 Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini (Is 29,13). 8Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». 9 E aggiungeva: «Siete veramente abili nell'eludere il comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione.10 Mosè infatti disse: Onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre sia messo a morte . 11Voi invece dicendo: Se uno dichiara al padre o alla madre: è Korbàn, cioè offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me, 12 non gli permettete più di fare nulla per il padre e la madre, 13 annullando così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte».
14 Chiamata di nuovo la folla diceva loro: “Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo». [...] 21 Dal di dentro infatti, cioè dal cuore dell'uomo escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi,
22 adulteri... stoltezza. 23 Tutte questa cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo».
In questa controversia emergono delle linee che sono presenti, in forma più o meno manifesta, in tutte le altre discussioni.
La polemica nasce per il fatto che i discepoli di Gesù manifestano un comportamento più libero rispetto a quello corrente. Gesù, di fronte alla domanda, non si sofferma a spiegare il motivo di questa libertà, ma parte subito con l'accusa, andando a fondo citando un passo del profeta Isaia. Con la sua risposta mostra che la reazione dei farisei verso di lui non è una cosa del tutto inedita: anche i profeti avevano rimproverato i costumi del popolo, per cui questi scribi, che sembrano tanto scandalizzarsi, in realtà sono proprio loro a porsi contro la Scrittura.
In secondo luogo, Gesù, approfittando delle parole del profeta, dribbla immediatamente l'apparenza giuridica, morale della cosa e va al nocciolo della questione: il cuore dell'uomo.
Qui c'è un'insistenza particolare tra:
v8 comandamento di Dio... tradizione degli uomini
v9 comandamento di Dio... la vostra tradizione
v13 parola di Dio ... tradizione che avete tramandato voi
In definitiva si tratta del rischio di diventare schiavi dei riti e perdere di vista ciò essi vogliono significare.
Le controversie di Gerusalemme: Mc 11-12
Le controversie di Gerusalemme ai capitoli 11 e 12 si aprono anch'esse (11,18) annotando già chiaramente, come già in 3,6, la decisione di uccidere Gesù.
11, 18 «L'udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutto il popolo era ammirato del suo insegnamento».
Il motivo delle controversie, non è più, come nella prima parte, la libertà di Gesù e dei discepoli nei confronti dei costumi e della tradizioni, ma è data da parole e gesti di Gesù verso il tempio. Lo scontro è più esplicito. Ora infatti è in gioco il tempio per cui il dibattito arriva al cuore della religione. Tuttavia si tratta di contese che non mirano alla ricerca della verità, ma sono usate in attesa di trovare il modo di farlo fuori senza suscitare rivolte popolari.
• la prima controversia ha per oggetto l'autorità di Gesù ed è posta da gran sacerdoti, scribi e anziani.
11,27 «...gli si avvicinarono i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero: 28 «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farlo?».
E abbiamo visto, Lettura 79, che Gesù non risponde alla domanda, ma cerca di mettere a nudo il cuore dei suoi avversari e pone loro una controdomanda sul Battista, alla quale non possono rispondere per non esporsi alle rimostranze del popolo.
• la seconda controversia è innescata dalla parabola dei vignaioli omicidi che traccia metaforicamente il percorso fatto dalla religione ebraica che non cerca più il rapporto con il Dio dell'Esodo rispettando la Sua Alleanza, ma si è trasformata in vuoti riti. Gli oppositori non sono nominati per cui potrebbero essere quelli del dibattito precedente oppure tutti gli oppositori nel loro insieme.
Con questa parabola, quella dei servi mandati dal padrone nella vigna, tutti uccisi compreso anche l'ultimo, il Figlio, egli mostra chiaramente la sua identità e quale sarà il suo destino. La reazione degli interlocutori è categorica:
12,12 «Allora cercarono di catturarlo, ma ebbero paura della folla; avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. E, lasciatolo, se ne andarono».
• la terza controversia. Lettura 81, è condotta da farisei ed erodiani, due gruppi perennemente contrapposti perché i primi sono radicalmente antiromani, mentre i secondi sono sfacciatamente filo romani, che in questo caso trovano l'accordo per mettere in difficoltà Gesù. La domanda tranello è quello di chiedere se sia lecito pagare il tributo a Cesare. E Gesù chiedendo di mostrargli una moneta pronuncia la celebre sentenza:
12,17 «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio». E rimasero ammirati di lui».
In sostanza Egli condanna la teocrazia pur salvaguardando il primato di Dio.
• Anche quando i sadducei lo interrogano sulla risurrezione dei morti, (Lettura 82; Mc12,18-27) ironizzando per metterlo in imbarazzo, ché per certi versi avevano anche ragione, perché se pensi il mondo futuro su modello del mondo presente, un uomo che ha avuto cinque mogli, cosa fa?
Gesù prende in blocco la rivelazione dell'Antico Testamento, che al di là dei singoli testi, sui quali si può sempre discutere, dice che Dio è il Vivente, è il Dio della vita che non abbandona l'uomo alla morte.
È una lettura veramente sintetica e globale delle Scritture, ed è l'unica che sta in piedi. Ancora una volta rimproverando a questi sadducei di non conoscere, né le scritture né Dio etc.
• La quinta controversia è avanzata da uno scriba che, questa volta, non tenta di metterlo in difficoltà, e termina con
l'affermazione:
12,34 «Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo».
Perciò, in questo caso, siamo un po' fuori rotta, nel senso che questo scriba è buono, è quasi la figura dell'avversario che sta dalla parte di Gesù: non tutti gli scribi sono avversari. Ma in questo modo viene rafforzato il giudizio negativo verso gli altri interpellanti.
• L'ultimo dibattito è posto direttamente da Gesù stesso sull'identità del Messia 12,35-37. Figlio di Davide o no?
Quindi il tutto che era partito da una domanda su Gesù, si chiude con una affermazione su Gesù.
• La sezione delle controversie gerosolimitane termina mettendo a confronto due quadri: il comportamento degli scribi che si pavoneggiano in lunghe vesti, pregano, praticano tutte le regolette prescritte, ma rubano alle vedove da un lato e dall'altro, quello di una povera vedova che dà tutti quei pochi spiccioli che ha, per il Regno di Dio: per la cassa del tempio. Sperando con tutte le sue forze che chi raccoglieva i fondi del tempio usasse bene i suoi pochi spiccioli. In definitiva la vera e la falsa religiosità.
Per sintetizzare:
1- Gesù è sempre in costante riferimento alle Scritture, diretto o indiretto. Secondo lui per capire le Scritture devi essere veramente in sintonia: devi avere un cuore non capovolto, non storto; perché puoi leggere le Scritture dalla mattina alla sera senza capirle, ma non è un fatto esegetico, è un fatto di cuore. Gesù, attaccato dallo scriba, risponde mostrando che è lo stesso scriba in contraddizione con le scritture nelle quali dice di credere: è lui che è contro.
2- Gesù parla di sé, della sua identità, del suo significato. Le controversie possono partire da qualsiasi argomento, ma il nucleo è questo: la rivelazione della sua messianità.
3- Ci sono sufficienti indizi per sostenere che il nucleo ancora più profondo non è solo l'identità del Messia, perché questa a sua volta rimanda all'identità di Dio: chi è Dio!
Quindi, lo scontro è su Dio. Riguarda l'immagine di Dio: quella della tradizione e quella portata da Gesù, il quale «sin dall'inizio / archè era nel seno del Padre» Gv 1,18. Allora lo scontro è teologico.
A questo punto raccogliamo in estrema sintesi tutte le domande, più o meno sincere, poste dagli oppositori:
Perché mangia con i peccatori? (2,16)
Perché i tuoi discepoli non digiunano? (2,18)
Perché fanno di sabato ciò che non è permesso? (2,24)
Perché non si comportano secondo le tradizioni degli antichi? (7,5)
Allora vennero i farisei e incominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo (8,11)
E avvicinatisi dei farisei, gli domandarono: «È lecito ad un marito ripudiare la propria moglie?» (10,2)
Con quale autorità fai queste cose? (11,28)
È lecito dare il tributo a Cesare? (12,14)
Di chi sarà moglie? (12,23)
Qual è il primo comandamento? (12,28)
Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto? (14,61)
Sono in gran parte domande di tipo legale, casuistico, riguardano il comportamento; vogliono sapere cosa Gesù pensa a proposito dei vari comportamenti.
Due domande sono esplicite perché riguardano la sua identità. Ma abbiamo visto che anche le altre, da Gesù sono trasformate in domande esplicite: non si lascia imprigionare in una casuistica di superficie. Come se essa non lo interessasse.
Le intenzioni con cui le domande sono poste sono importanti e mai sincere: “Per accusarlo...”; “per tentarlo...”; “...per coglierlo in fallo”;... sempre! Non sincere quelle domande! Anche quando pongono delle domande precise, in realtà non sono interessati alla verità; vogliono solo trovare un modo per accusarlo, quindi un'intenzione che non è mai sincera. O per metterlo in cattiva luce, o per trovare un appiglio di accusa, o per metterlo alla prova: «Scendi dalla croce se sei capace» per deviarlo dalla strada messianica.
Queste domande dell'oppositore non esprimono mai un moto interiore verso la verità.
Osserviamo i giudizi che esprimono circa le risposte date da Gesù:
Bestemmia! (2,7 )
È posseduto dal demonio! (3,30)
Abbiamo udito la bestemmia. Che ve ne pare? (14,64)
A parte quel "posseduto dal demonio", Gesù è accusato di bestemmia, quindi è coinvolto Dio. Non solo uno che viola una legge qualsiasi, la viola pretendendo di poterla violare. E questo è un bestemmia. D'altra parte non basta dire “bestemmia!”, perché c'è un problema da risolvere, perché i miracoli Gesù li fa. Gli indemoniati li libera. Allora come spieghi che è un bestemmiatore? «È posseduto dal demonio». Appunto, “Posseduto dal demonio” è la chiave che permette di dire che è un bestemmiatore pur accettando i fatti innegabili che ti capitano sotto gli occhi.
Vediamo ora Gesù come reagisce nei confronti degli oppositori, cioè le domande che pone Gesù agli oppositori.
Perché pensate così nei vostri cuori? (2,8)
Che cosa è più facile dire: ti sono rimessi i peccati o prendi il tuo lettuccio e cammina? (2,9)
Come possono digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? (2,19)
Non avete mai letto cosa fece Davide? (2,25)
È lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla? (3,4)
Come può Satana scacciare Satana? (3,23)
Perché questa generazione chiede un segno? (8,12)
Non sapete che tutto ciò che entra nell'uomo dall'esterno non lo può contaminare...? (7,19)
Che cosa vi ha ordinato Mosè? Farò anch'io una domanda: Il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? (11,30)
Non avete forse letto questa scrittura? (12,24)
Davide stesso lo chiama Signore, come dunque può essere suo Figlio? (12,37)
Perché mi tentate? (12,15)
Di chi è questa effigie e questa iscrizione? (12,16)
Non siete voi forse in errore? Non conoscete né le Scritture né la potenza di Dio? (12,24)
Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? (12,35)
Alcune di queste domande sono un po' retoriche perché in realtà sono già dei giudizi, ma altre no. La maggior parte di esse rinvia alle Scritture: “ma come non leggete le scritture”?
Questo espediente serve a Gesù per porre l'avversario in contraddizione con se stesso.
Gesù alla fine vuole mostrare che non è lui il bestemmiatore, ma sono loro. Questo continuo riferimento alle scritture è senz'altro molto interessante.
Alla fine sta una domanda che ha tutta l'aria di essere un giudizio molto drastico rivolto a tutti e non solo ai personaggi del momento: “non conoscete né le Scritture né la potenza di Dio”(12,24).
Un'altra cosa che impressiona è il silenzio di fronte alle domande di Gesù.
Gesù pone le domande, ma gli altri non rispondono. Ancora una volta viene messa in luce che l'oppositore è una figura già completa all'inizio: non ha la minima voglia di camminare. Cerca solo appigli per prevalere, per zittire questa idea che lui non può assolutamente accettare.
Evidentemente i giudizi di Gesù sono quanto mai drastici: li accusa di durezza di cuore: “...non ci sarà perdono in eterno....”; ” ....Ipocriti”....; “...abili nell'eludere il comandamento...”; “....non conoscete né la scrittura né la potenza di Dio...”. È come Gesù non prendesse neanche in considerazione l'ipotesi che si convertano, stando a questi testi.
Ci sono alcuni oppositori ai quali Gesù non risponde:
15,29 «I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni, 30 salva te stesso scendendo dalla croce!».
31 Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri, non può salvare se stesso! 32 Il Cristo, il re d'Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano».
Ad essi la risposta arriverà direttamente dal Padre... il mattino di Pasqua.
Lettura 112 L'oppositore radicale: Satana
Nella precedente lettura abbiamo passato in rassegna i vari tipi di oppositori che Gesù ha incontrato durante il suo cammino, ma l'oppositore più radicale, abbiamo incontrato sin dall'inizio delle nostre riflessioni, è Satana.
Già il nome ebraico identifica il personaggio perché Satan significa: oppositore, accusatore, nemico, avversario.
Diavolo,invece, deriva dal greco: dia-ballo: diviso-metto, da cui divisore.
Demonio deriva dal greco e originariamente erano esseri spirituali positivi o negativi e solo più tardi hanno assunto solo la connotazione negativa.
Già tutti questi nomi danno l'idea di un essere dalla personalità sfuggente.
Ora, non è possibile presentare il demonio e tutte le sue varianti mediante definizioni o concetti. È necessario invece comprenderlo attraverso una storia perché la verità, ormai dovrebbe essere assodato, si dà storicamente.
Anche il Figlio di Dio ha dovuto scontrarsi con questo personaggio.
Infatti subito dopo il battesimo, Gesù va nel deserto dove viene tentato dal diavolo. Inizia lì una dura lotta che avrà il suo esito definitivo e vittorioso solo nella Croce, proprio perché ciò che il tentatore vuole impedire è il "Messia Crocifisso".
1,12 «Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto 13 e vi rimase quaranta giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano».
In diversi altri brani abbiamo incontrato ossessi posseduti dal demonio che Gesù scaccia semplicemente mediante un comando cioè, senza magie o abracadabra di qualche tipo. La cosa singolare è che il demonio conosce l'identità di Gesù.
1,32 «Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. 33 Tutta la città era riunita davanti alla porta. 34 Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano».
La lotta di Gesù con il demonio dura lungo tutta la vita terrena del Maestro e la vittoria si manifesta sul calvario quando a tutti viene finalmente mostrato la dimensione dell'amore di Dio per le sue creature:
15, 39 «Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!».
Solo qui in modo palese viene rivelata la reale natura di Gesù di Nazareth.
Qui sul Calvario si rende evidente la sconfitta dell'oppositore radicale, Satana, appunto.
In realtà la lotta tra Dio è il demonio era già iniziata molto tempo prima. La Scrittura rivela che l'oppositore radicale aveva già teso la sua rete nel giardino di Eden e purtroppo la sua attività prosegue anche nel nostro tempo.
Ma ci rendiamo conto che oggi parlare del diavolo è fuori moda. Anche nelle omelie è un personaggio del tutto scomparso. Però il catechismo ufficiale della Chiesa Cattolica, parla del demonio mostrando tutte le interazioni che ha avuto con Dio, con gli uomini, e con la creazione, in ultima analisi ancora con la storia.
Non è questo il luogo in cui fare una catechesi sul diavolo per cui si limitiamo a riportare gli articoli del Catechismo che di lui trattano.
Chi desiderasse tirare subito le nostre conclusione in forma sintetica può andare direttamente all'ultima nota di questa lettura.
DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 1992
NB: i numeri in grassetto sono gli articoli del catechismo, mentre le note a piè pagina, qui non riportate, sono reperibili sulla versione originale del Catechismo consultabile o scaricabile sul sito del Vaticano: http://www.vatican.va/archive/ccc_it/ccc-it_index_it.html
Paragrafo 7
LA CADUTA
385 Dio è infinitamente buono e tutte le sue opere sono buone. Tuttavia nessuno sfugge all'esperienza della sofferenza, dei mali presenti nella natura – che appaiono legati ai limiti propri delle creature – e soprattutto al problema del male morale. Da dove viene il male? « Quaerebam unde malum et non erat exitus – Mi chiedevo donde il male, e non sapevo darmi risposta », dice sant'Agostino, 501 e la sua sofferta ricerca non troverà sbocco che nella conversione al Dio vivente. Infatti « il mistero dell'iniquità » (2 Ts 2,7) si illumina soltanto alla luce del mistero della pietà. 502 La rivelazione dell'amore divino in Cristo ha manifestato ad un tempo l'estensione del male e la sovrabbondanza della grazia. 503 Dobbiamo, dunque, affrontare la questione dell'origine del male, tenendo fisso lo sguardo della nostra fede su colui che, solo, ne è il vincitore. 504
I. «Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia»
La realtà del peccato
386 Nella storia dell'uomo è presente il peccato: sarebbe vano cercare di ignorarlo o di dare altri nomi a questa oscura realtà. Per tentare di comprendere che cosa sia il peccato, si deve innanzi tutto riconoscere il profondo legame dell'uomo con Dio, perché, al di fuori di questo rapporto, il male del peccato non può venire smascherato nella sua vera identità di rifiuto e di opposizione a Dio, mentre continua a gravare sulla vita dell'uomo e sulla storia.
387 La realtà del peccato, e più particolarmente del peccato delle origini, si chiarisce soltanto alla luce della rivelazione divina. Senza la conoscenza di Dio che essa ci dà, non si può riconoscere chiaramente il peccato, e si è tentati di spiegarlo semplicemente come un difetto di crescita, come una debolezza psicologica, un errore, come l'inevitabile conseguenza di una struttura sociale inadeguata, ecc. Soltanto conoscendo il disegno di Dio sull'uomo, si capisce che il peccato è un abuso di quella libertà che Dio dona alle persone create perché possano amare lui e amarsi reciprocamente.
Il peccato originale - una verità essenziale della fede
388 Col progresso della Rivelazione viene chiarita anche la realtà del peccato. Sebbene il popolo di Dio dell'Antico Testamento abbia in qualche modo conosciuto la condizione umana alla luce della storia della caduta narrata dalla Genesi, non era però in grado di comprendere il significato ultimo di tale storia, che si manifesta appieno soltanto alla luce della morte e della risurrezione di Gesù Cristo. 505 Bisogna conoscere Cristo come sorgente della grazia per conoscere Adamo come sorgente del peccato. È lo Spirito Paraclito, mandato da Cristo risorto, che è venuto a convincere « il mondo quanto al peccato » (Gv 16,8), rivelando colui che del peccato è il Redentore.
389 La dottrina del peccato originale è, per così dire, « il rovescio » della Buona Novella che Gesù è il Salvatore di tutti gli uomini, che tutti hanno bisogno della salvezza e che la salvezza è offerta a tutti grazie a Cristo. La Chiesa, che ha il senso di Cristo, 506 ben sa che non si può intaccare la rivelazione del peccato originale senza attentare al mistero di Cristo.
Per leggere il racconto della caduta
390 Il racconto della caduta (Gn 3) utilizza un linguaggio di immagini, ma espone un avvenimento primordiale, un fatto che è accaduto all'inizio della storia dell'uomo. 507 La Rivelazione ci dà la certezza di fede che tutta la storia umana è segnata dalla colpa originale liberamente commessa dai nostri progenitori. 508
391 Dietro la scelta disobbediente dei nostri progenitori c'è una voce seduttrice, che si oppone a Dio, 509 la quale, per invidia, li fa cadere nella morte. 510 La Scrittura e la Tradizione della Chiesa vedono in questo essere un angelo caduto, chiamato Satana o diavolo. 511 La Chiesa insegna che all'inizio era un angelo buono, creato da Dio. « Diabolus enim et alii dæmones a Deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali – Il diavolo infatti e gli altri demoni sono stati creati da Dio naturalmente buoni, ma da se stessi si sono trasformati in malvagi ». 512
392 La Scrittura parla di un peccato di questi angeli. 513 Tale « caduta » consiste nell'avere, questi spiriti creati, con libera scelta, radicalmente ed irrevocabilmente rifiutato Dio e il suo Regno. Troviamo un riflesso di questa ribellione nelle parole rivolte dal tentatore ai nostri progenitori: « Diventerete come Dio » (Gn 3,5). « Il diavolo è peccatore fin dal principio » (1 Gv 3,8), « padre della menzogna » (Gv 8,44).
393 A far sì che il peccato degli angeli non possa essere perdonato è il carattere irrevocabile della loro scelta, e non un difetto dell'infinita misericordia divina. « Non c'è possibilità di pentimento per loro dopo la caduta, come non c'è possibilità di pentimento per gli uomini dopo la morte ». 514
394 La Scrittura attesta la nefasta influenza di colui che Gesù chiama « omicida fin dal principio » (Gv 8,44), e che ha perfino tentato di distogliere Gesù dalla missione affidatagli dal Padre. 515 « Il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo » (1 Gv 3,8). Di queste opere, la più grave nelle sue conseguenze è stata la seduzione menzognera che ha indotto l'uomo a disobbedire a Dio.
395 La potenza di Satana però non è infinita. Egli non è che una creatura, potente per il fatto di essere puro spirito, ma pur sempre una creatura: non può impedire l'edificazione del regno di Dio. Sebbene Satana agisca nel mondo per odio contro Dio e il suo regno in Cristo Gesù, e sebbene la sua azione causi gravi danni – di natura spirituale e indirettamente anche di natura fisica – per ogni uomo e per la società, questa azione è permessa dalla divina provvidenza, la quale guida la storia dell'uomo e del mondo con forza e dolcezza. La permissione divina dell'attività diabolica è un grande mistero, ma « noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio » (Rm 8,28).
La prova della libertà
396 Dio ha creato l'uomo a sua immagine e l'ha costituito nella sua amicizia. Creatura spirituale, l'uomo non può vivere questa amicizia che come libera sottomissione a Dio. Questo è il significato del divieto fatto all'uomo di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, « perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti » (Gn 2,17). « L'albero della conoscenza del bene e del male » (Gn 2,17) evoca simbolicamente il limite invalicabile che l'uomo, in quanto creatura, deve liberamente riconoscere e con fiducia rispettare. L'uomo dipende dal Creatore, è sottomesso alle leggi della creazione e alle norme morali che regolano l'uso della libertà.
Il primo peccato dell'uomo
397 L'uomo, tentato dal diavolo, ha lasciato spegnere nel suo cuore la fiducia nei confronti del suo Creatore 516 e, abusando della propria libertà, ha disobbedito al comandamento di Dio. In ciò è consistito il primo peccato dell'uomo. 517 In seguito, ogni peccato sarà una disobbedienza a Dio e una mancanza di fiducia nella sua bontà.
398 Con questo peccato, l'uomo ha preferito se stesso a Dio, e, perciò, ha disprezzato Dio: ha fatto la scelta di se stesso contro Dio, contro le esigenze della propria condizione di creatura e conseguentemente contro il suo proprio bene. Costituito in uno stato di santità, l'uomo era destinato ad essere pienamente « divinizzato » da Dio nella gloria. Sedotto dal diavolo, ha voluto diventare « come Dio » (Gn 3,5), ma « senza Dio e anteponendosi a Dio, non secondo Dio ». 518
399 La Scrittura mostra le conseguenze drammatiche di questa prima disobbedienza. Adamo ed Eva perdono immediatamente la grazia della santità originale. 519 Hanno paura di quel Dio 520 di cui si sono fatti una falsa immagine, quella cioè di un Dio geloso delle proprie prerogative. 521
400 L'armonia nella quale essi erano posti, grazie alla giustizia originale, è distrutta; la padronanza delle facoltà spirituali dell'anima sul corpo è infranta; 522 l'unione dell'uomo e della donna è sottoposta a tensioni; 523 i loro rapporti saranno segnati dalla concupiscenza e dalla tendenza all'asservimento. 524 L'armonia con la creazione è spezzata: la creazione visibile è diventata aliena e ostile all'uomo. 525 A causa dell'uomo, la creazione è soggetta alla schiavitù della corruzione. 526 Infine, la conseguenza esplicitamente annunziata nell'ipotesi della disobbedienza 527 si realizzerà: l'uomo tornerà in polvere, quella polvere dalla quale è stato tratto. 528 La morte entra nella storia dell'umanità. 529
401 Dopo questo primo peccato, il mondo è inondato da una vera « invasione » del peccato: il fratricidio commesso da Caino contro Abele; 530 la corruzione universale quale conseguenza del peccato; 531 nella storia d'Israele, il peccato si manifesta frequentemente soprattutto come infedeltà al Dio dell'Alleanza e come trasgressione della Legge di Mosè; anche dopo la redenzione di Cristo, fra i cristiani, il peccato si manifesta in svariati modi. 532 La Scrittura e la Tradizione della Chiesa richiamano continuamente la presenza e l'universalità del peccato nella storia dell'uomo:
« Quel che ci viene manifestato dalla rivelazione divina concorda con la stessa esperienza. Infatti, se l'uomo guarda dentro al suo cuore, si scopre anche inclinato al male e immerso in tante miserie che non possono certo derivare dal Creatore che è buono. Spesso, rifiutando di riconoscere Dio quale suo principio, l'uomo ha infranto il debito ordine in rapporto al suo ultimo fine, e al tempo stesso tutto il suo orientamento sia verso se stesso, sia verso gli altri uomini e verso tutte le cose create ». 533
Conseguenze del peccato di Adamo per l'umanità
402 Tutti gli uomini sono coinvolti nel peccato di Adamo. San Paolo lo afferma: « Per la disobbedienza di uno solo, tutti sono stati costituiti peccatori » (Rm 5,19); « Come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato... » (Rm 5,12). All'universalità del peccato e della morte l'Apostolo contrappone l'universalità della salvezza in Cristo: « Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita » (Rm 5,18).
403 Sulle orme di san Paolo la Chiesa ha sempre insegnato che l'immensa miseria che opprime gli uomini, la loro inclinazione al male e l'ineluttabilità della morte non si possono comprendere senza il loro legame con la colpa di Adamo e prescindendo dal fatto che egli ci ha trasmesso un peccato dal quale tutti nasciamo contaminati e che è « morte dell'anima ». 534 Per questa certezza di fede, la Chiesa amministra il Battesimo per la remissione dei peccati anche ai bambini che non hanno commesso peccati personali. 535
404 In che modo il peccato di Adamo è diventato il peccato di tutti i suoi discendenti? Tutto il genere umano è in Adamo « sicut unum corpus unius hominis – come un unico corpo di un unico uomo ». 536 Per questa « unità del genere umano » tutti gli uomini sono coinvolti nel peccato di Adamo, così come tutti sono coinvolti nella giustizia di Cristo. Tuttavia, la trasmissione del peccato originale è un mistero che non possiamo comprendere appieno. Sappiamo però dalla Rivelazione che Adamo aveva ricevuto la santità e la giustizia originali non soltanto per sé, ma per tutto il genere umano: cedendo al tentatore, Adamo ed Eva commettono un peccato personale, ma questo peccato intacca la natura umana, che essi trasmettono in una condizione decaduta. 537 Si tratta di un peccato che sarà trasmesso per propagazione a tutta l'umanità, cioè con la trasmissione di una natura umana privata della santità e della giustizia originali. Per questo il peccato originale è chiamato « peccato » in modo analogico: è un peccato « contratto » e non « commesso », uno stato e non un atto.
405 Il peccato originale, sebbene proprio a ciascuno, 538 in nessun discendente di Adamo ha un carattere di colpa personale. Consiste nella privazione della santità e della giustizia originali, ma la natura umana non è interamente corrotta: è ferita nelle sue proprie forze naturali, sottoposta all'ignoranza, alla sofferenza e al potere della morte, e inclinata al peccato (questa inclinazione al male è chiamata « concupiscenza »). Il Battesimo, donando la vita della grazia di Cristo, cancella il peccato originale e volge di nuovo l'uomo verso Dio; le conseguenze di tale peccato sulla natura indebolita e incline al male rimangono nell'uomo e lo provocano al combattimento spirituale.
406 La dottrina della Chiesa sulla trasmissione del peccato originale è andata precisandosi soprattutto nel V secolo, in particolare sotto la spinta della riflessione di sant'Agostino contro il pelagianesimo, e nel XVI secolo, in opposizione alla Riforma protestante. Pelagio riteneva che l'uomo, con la forza naturale della sua libera volontà, senza l'aiuto necessario della grazia di Dio, potesse condurre una vita moralmente buona; in tal modo riduceva l'influenza della colpa di Adamo a quella di un cattivo esempio. Al contrario, i primi riformatori protestanti insegnavano che l'uomo era radicalmente pervertito e la sua libertà annullata dal peccato delle origini; identificavano il peccato ereditato da ogni uomo con l'inclinazione al male (« concupiscentia »), che sarebbe invincibile. La Chiesa si è pronunciata sul senso del dato rivelato concernente il peccato originale soprattutto nel II Concilio di Orange nel 529 539 e nel Concilio di Trento nel 1546. 540
Un duro combattimento
407 La dottrina sul peccato originale – connessa strettamente con quella della redenzione operata da Cristo – offre uno sguardo di lucido discernimento sulla situazione dell'uomo e del suo agire nel mondo. In conseguenza del peccato dei progenitori, il diavolo ha acquisito un certo dominio sull'uomo, benché questi rimanga libero. Il peccato originale comporta « la schiavitù sotto il dominio di colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo ». 541 Ignorare che l'uomo ha una natura ferita, incline al male, è causa di gravi errori nel campo dell'educazione, della politica, dell'azione sociale 542 e dei costumi.
408 Le conseguenze del peccato originale e di tutti i peccati personali degli uomini conferiscono al mondo nel suo insieme una condizione peccaminosa, che può essere definita con l'espressione di san Giovanni: « il peccato del mondo » (Gv 1,29). Con questa espressione viene anche significata l'influenza negativa esercitata sulle persone dalle situazioni comunitarie e dalle strutture sociali che sono frutto dei peccati degli uomini. 543
409 La drammatica condizione del mondo che « giace » tutto « sotto il potere del maligno » (1 Gv 5,19) 544 fa della vita dell'uomo una lotta:
« Tutta intera la storia umana è infatti pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre; lotta incominciata fin dall'origine del mondo, che durerà, come dice il Signore, fino all'ultimo giorno. Inserito in questa battaglia, l'uomo deve combattere senza soste per poter restare unito al bene, né può conseguire la sua interiore unità se non a prezzo di grandi fatiche, con l'aiuto della grazia di Dio ». 545
IV. «Tu non l'hai abbandonato in potere della morte»
410 Dopo la caduta, l'uomo non è stato abbandonato da Dio. Al contrario, Dio lo chiama, 546 e gli predice in modo misterioso che il male sarà vinto e che l'uomo sarà sollevato dalla caduta. 547 Questo passo della Genesi è stato chiamato « protovangelo », poiché è il primo annunzio del Messia redentore, di una lotta tra il serpente e la Donna e della vittoria finale di un discendente di lei.
411 La Tradizione cristiana vede in questo passo un annunzio del « nuovo Adamo », 548 che, con la sua obbedienza « fino alla morte di croce » (Fil 2,8), ripara sovrabbondantemente la disobbedienza di Adamo. 549 Inoltre, numerosi Padri e dottori della Chiesa vedono nella Donna annunziata nel « protovangelo » la Madre di Cristo, Maria, come « nuova Eva ». Ella è stata colei che, per prima e in una maniera unica, ha beneficiato della vittoria sul peccato riportata da Cristo: è stata preservata da ogni macchia di peccato originale 550 e, durante tutta la sua vita terrena, per una speciale grazia di Dio, non ha commesso alcun peccato. 51
412 Ma perché Dio non ha impedito al primo uomo di peccare? San Leone Magno risponde: « L'ineffabile grazia di Cristo ci ha dato beni migliori di quelli di cui l'invidia del demonio ci aveva privati ». 552 E san Tommaso d'Aquino: « Nulla si oppone al fatto che la natura umana sia stata destinata ad un fine più alto dopo il peccato. Dio permette, infatti, che ci siano i mali per trarre da essi un bene più grande. Da qui il detto di san Paolo: "Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia" (Rm 5,20). Perciò nella benedizione del cero pasquale si dice: "O felice colpa, che ha meritato un tale e così grande Redentore!" ». 553
Nota conclusiva
Riteniamo opportuno aggiungere in questa nota conclusiva quanto scrive Bruno Maggioni, Il racconto di Marco, Cittadella, a riguardo dello scontro di Gesù con i suoi oppositori in merito al demonio.
«Prima di fare alcune osservazioni più precise attorno al dibattiti, che Gesù ha con i suoi oppositori, a proposito delle cacciate dei demoni, è opportuno fermare l'attenzione sul significato generale della lotta contro Satana: lotta che appunto Gesù intende difendere dalla distorta interpretazione degli scribi Mc 3,22-ss. Sin dall'inizio del vangelo Marco sottolinea che il Figlio di Dio prende parte alla lotta che agita il mondo.
Mediante i racconti della liberazione degli ossessi, l'evangelo ci comunica una visione della storia, quella che si svolge in profondità: una lotta fra il bene e il male, i cui protagonisti non sono le forze della natura, e neppure, semplicemente, gli uomini, ma Dio e il Maligno. Questa opposizione fra Dio e il suo avversario si manifesta a tre livelli: il contrasto fra Gesù e i suoi oppositori, fra Gesù e gli indemoniati, fra lo Spirito di Dio e Satana. Dobbiamo dire che Marco semplifica (e forse volutamente), quando sembra eliminare quella ambiguità che nella storia è sempre presente: il bene e il male non stanno di qua o di là, divisi a settori, ma si combattono all'interno di ciascun uomo e di ciascuna istituzione. Il contrasto è radicale, ed è un contrasto che passa attraverso ogni cosa. Localizzare il be
Precisiamo ulteriormente: secondo Marco il contrasto non è solo fra Dio e Satana, ma è, tutto sommato, un contrasto sull'uomo. Non è solo in gioco la gloria di Dio, ma prima ancora l'uomo, la sua consistenza e la sua libertà.
La presenza di Satana distrugge: è lo spirito della confusione, della alienazione, della disgregazione.
La presenza di Cristo è la pace. Una storia, dunque, nella quale l'uomo si dibatte fra la salvezza e la alienazione.
Ma il dibattito non afferma soltanto che Gesù è in lotta con Satana (e non invece un suo alleato) perché nell'affermazione di Gesù c'è una convinzione: con la sua venuta la vittoria sul male è un fatto assicurato.
Le liberazioni dal demonio non sono sconfitte parziali, ma il segno di una sconfitta totale che già si anticipa. È una affermazione unica, inaudita per i giudei: « il giudaismo contemporaneo non offre analogia alcuna a queste affermazioni; né la sinagoga né Qumran parlano di una vittoria su Satana che si attua già nel presente storico ».
Noi possiamo aggiungere che oltre e osservare che Gesù vince il Maligno con la potenza dell'obbedienza e dell'amore: la potenza di Dio si fa presente nella disponibilità di colui che accettò, al battesimo, di essere il Servo che si assume il peso del male. Quest'amore disinteressato di Cristo, rivolto a Dio e agli uomini a lui affidati, smaschera e vince lo spirito dell''egoismo e gli strappa il mondo di cui abusa.
Lettura 113 Le ragioni delle opposizioni
Nel leggere la Bibbia troviamo espressioni che risultano dure ai nostri orecchi: guerra santa, sterminio dei
Nelle ultime letture abbiamo esaminato attraversando tutto il Vangelo di Marco i vari oppositori che Gesù ha incontrato lungo il suo percorso terreno: oppositore escatologico, Satana; gli oppositori religiosi: farisei, scribi, sommi sacerdoti; gli oppositori interni intendo con in questo modo anche i discepoli ché, a loro volta, partiti con grande entusiasmo finiscono per abbandonare e rinnegare il Maestro.
Il fatto è che Gesù è portatore di alcune novità al riguardo di Dio che si scontrano con la tradizione. Troviamo una spiegazione sintetica nell'ultimo versetto del Prologo di Giovanni che recita:
«Dio finora nessuno l'ha mai visto/ il Figlio Unigenito / che è nel grembo del Padre / lui lo ha rivelato/ exegesato» Gv 1,18
Il termine greco dice che Gesù più che una rivelazione ha portato una esegesi della idea e della conoscenza di Dio che circolava a quel tempo. Gesù in qualche modo ha corretto l'idea di Dio portata da: patriarchi, profeti, sacerdoti, giusti, ecc. che inevitabilmente erano influenzati da precedenti "precomprensioni" esistenti nelle varie epoche storiche e dalle varie culture antiche. E non furono poche dato che stiamo parlando di un arco di tempo di quasi 2000 anni, da Abramo (circa 1800 a. C.) fino a Gesù.
"Precomprensione" nel nostro caso vuol dire che quando uno dice: "Dio" io so già di che cosa parla perché io ho già la "mia" idea di Dio, ma appunto la "mia".
Se invece voglio sapere com'è Dio e come agisce devo "guardare" Gesù perché solo Lui era ed "è nel grembo del Padre" Gv 1,1.
Allora possiamo dire che Gesù si è presentato ai suoi interlocutori presentandosi rispetto alle comprensioni correnti con alcune vistose "anomalie" tese a correggere l'idea di Dio e di religione. Ne esaminiamo alcune:
I Anomalia - Comunione con i peccatori
Peccatori in quel tempo erano le persone colpite da discredito religioso o morale. E non occorreva molto per esserlo o diventarlo, bastava nascere ciechi o zoppi o prendersi la lebbra ecc. Un malato era peccatore o figlio di peccatori, vedi Gv 9 e il libro di Giobbe. Era sufficiente toccare una donna durante il mestruo o non lavarsi le mani fino al gomito prima di mangiare, per finire in una esclusione di tipo teologico, perché c'era anche la teoria che li considerava maledetti da Dio.
Queste persone erano escluse dai rapporti sociali e chi li frequentava diventava escluso come loro.
Invece Gesù non esita a frequentare questi personaggi esclusi: entra nella casa dei pubblicani (Zaccheo), si lascia toccare da una prostituta (Maddalena), difende un'adultera che i benpensanti volevano lapidare, Egli deliberatamente viola queste prescrizioni e per farla breve, diciamo che va a cercare tutte queste figure che stano sotto il segno dell'esclusione. Sono gesti che gettano il discredito su di Lui come uomo di Dio, ma Egli mostra chiaramente e duramente, quando è il caso, di non esserne intaccato. Anzi usa parole molto dure e taglienti verso coloro che lo chiamano al rispetto della tradizione. (Riportiamo solo questi versetti, ma è consigliabile leggere tutto il capitolo)
Mc 2,15 «Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano. 16 Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori?». 17 Avendo udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori».
Sono rotture clamorose a riguardo della consuetudine. Ma Gesù insiste!
Vuol dire che queste "rotture" con il passato sono per Lui molto importanti. Anzi essenziali!
II Anomalia - Univocità dei gesti di liberazione dal male
Tutti siamo pronti a sostenere che Gesù ha compiuto molti miracoli, ma questo termine non è usato nei vangeli che invece parlano di guarigioni e cacciate dei demoni.
"Miracolo" è un termine molto ambiguo perché mette sullo stesso piano l'evento fausto e l'evento infausto verso l'uomo. Ci spieghiamo con un esempio.
Dopo che Elia è stato rapito verso il cielo su un carro di fuoco, Eliseo, il discepolo rimasto senza maestro resta per un po' di tempo a Gerico e poi leggiamo:
2 Re 2,23 «Di lì Eliseo andò a Betel. Mentre egli camminava per strada, uscirono dalla città alcuni ragazzetti che si burlarono di lui dicendo: «Vieni su, pelato; vieni su, calvo!». 24 Egli si voltò, li guardò e li maledisse nel nome del Signore. Allora uscirono dalla foresta due orse, che sbranarono quarantadue di quei fanciulli. 25 Di là egli andò al monte Carmelo e quindi tornò a Samaria».
La Bibbia di Gerusalemme intitola questo fatto come "Miracolo di Eliseo".
Bene, il teatro della rivelazione occupato da Gesù, cioè da Betlemme all'Ascensione non presenta mai, assolutamente mai, eventi di questo genere.
Se ci sono "miracoli" sono solo ciechi che vedono, zoppi che camminano, lebbrosi mondati, morti che risorgono.
E, molto importante, tutti questi gesti di Gesù sono coperti da un velo di discrezione; a qualcuno dice: "non dirlo a nessuno", a qualcun altro: "vai casa tua"... Sembra che Gesù voglia evitare il successo facile o trasformare la "liberazione di un uomo dal male" come strumento per acquisire un potere per sé.
Le guarigioni, a noi sembra impossibile, non hanno come fine il proselitismo o la propaganda.
Giovanni li chiama semplicemente "segni" e sono solo sette, cioè ci invita a vedere il contenuto, non il contorno.
Dobbiamo allora ricordare le "tentazioni nel deserto" (Mt 4 e paralleli) che gli sono suggerite da Satana: le pietre trasformate in pane, il buttarsi in caduta libera dal pinnacolo del tempio, il potere politico sul mondo intero accogliendone i suoi criteri (del mondo, cioè di Satana). Non è quello che si aspettavano i suoi discepoli?
Ma tutte queste sono vie per il successo della missione che, però, non liberano l'uomo dal male e lo lasciano ancora come prima e come sempre.
Che i cosiddetti "miracoli" siano solo "gesti di liberazione dell'uomo dal male" lo vediamo chiaramente quando si entra sulla scena della Passione. Lì non c'è nessun evento straordinario. Un soldato che cade dai gradini del Pretorio e si rompe una gamba, l'infartino ad un sacerdote o ad un funzionario romano avrebbero modificato radicalmente l'esito di quel processo... Ma non sarebbe emerso tutto l'orrore prodotto dal male / peccato. Uno che ha fatto solo del bene che viene crocifisso... in nome di Dio! E l'uomo non sarebbe stato liberato dal male, anzi qualcuno sarebbe stato colpito dal male. Qui che nel nome di Dio, a sostegno della Sua causa, non accade neanche la sbucciatura di un ginocchio: neanche un miracolino piccolo piccolo!
C'è un bel contrasto tra lo sbranamento di quarantadue bambini che hanno detto "crapa pelata" ad un profeta e quello che si svolge a Gerusalemme.
Divaricante! Assolutamente divaricante!
III Anomalia - Autorevolezza - exousia
Nella sinagoga di Cafarnao Gesù scaccia il demonio da un indemoniato. La scena dovette essere impressionante perché la gente commenta come segue:
Mc 1,27 «Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono!». 28 La sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea».
La sorpresa degli uditori di Gesù si può cogliere se teniamo presente il metodo di insegnamento usato da rabbini e maestri di quel tempo che era fatto di continue citazioni di maestri precedenti, quindi una autorevolezza basata sul riferimento ai giusti e ai sapienti del passato, mentre molto raramente Gesù cita i maestri del passato.
Infatti siamo di fronte ad «Una dottrina nuova insegnata con autorità». Da sottolineare "novità" oltre che "autorità".
La gente di Cafarnao rileva una cosa sconcertante in Gesù: l'inaudita rivendicazione di pieni poteri a riguardo dell'interpretazione delle Scritture, della Legge e soprattutto delle tradizioni.
Infatti nessun profeta, compreso Mosè, si è mai presentato ai suoi interlocutori dicendo: "Io vi dico...", ma sempre con le formule del messaggero del tipo: "Dice il Signore" oppure "Oracolo di JHWH". Gesù invece afferma categoricamente: "Io vi dico..." o addirittura: "Vi fu detto, ma io vi dico..."
Tutto ciò che appartiene alla tradizione della verità di Dio è confermato o sospeso in relazione alla Sua approvazione o negazione.
La seconda parte del versetto riguarda l'azione «Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono».
Allora non si tratta solo di parole, ma anche di opere mai accadute prima, per cui vale l'espressione sintetica usata dai due discepoli che, dopo la Risurrezione, vanno verso Emmaus che lo definiscono: «Profeta potente in parole e opere davanti a Dio e davanti agli uomini» Lc 24,19.
Questa reazione delle persone semplici, come poteva essere la gente di Cafarnao, pescatori, lassù in Galilea, fa contrasto con le reazioni rabbiose che in seguito avverranno da parte di scribi, farisei, sadducei, a Gerusalemme.
Già da queste prime battute l'opposizione e il conflitto appaiono inevitabili.
IV Anomalia - Legittimazione della speranza dell'uomo nel bisogno
L'autorevolezza di Gesù non è destinata ad affermare il suo potere, a specificare la sua grandezza, ma a sostenere e legittimare la speranza di una pienezza di vita di ogni uomo, iniziando da quelli che sono nelle difficoltà: malati, emarginati, vecchi, peccatori, ecc.
Il desiderio di una vita che non sia meno che eterna, per Gesù è assolutamente pertinente. Eterna non definisce solo un tempo senza fine, ma l'insieme di tutto ciò che l'uomo può desiderare. Anche per questo egli risuscita i morti: Lazzaro, la figlia di Giairo, il figlio della vedova di Naim, ecc.
Anche all'uomo che si trova nella condizione più misera ed estrema Gesù assicura la speranza di un "oltre", l'apertura di una futuro ulteriore.
Il desiderio di vita buona è sempre da lui apprezzato e sostenuto mentre l'idea precedente era del tipo: "Sei nato cieco, allora tu o qualcuno dei tuoi ha peccato quindi resta cieco perché sei un maledetto".
Un altro strappo di netto nei confronti della tradizione!
V - Anomalia del discepolato
L'uso dell'epoca era che i genitori pregassero un maestro che istruisse il figlio facendolo suo discepolo. Questo non avveniva molto pacificamente: il maestro sottoponeva il neofita a dure prove, esigeva un compenso molto salato e bastava un niente per rimandare l'allievo a casa.
Gesù è del tutto fuori dal coro. Alcuni stanno pescando, altri stavano assettando le reti, un altro era seduto al banco delle tasse, altri gli chiedono dove abita e poi "stettero con lui", ecc.
A nessuno di loro sono richiesti titoli accademici, percorsi religiosi precedenti, esame vocazionale, colloquio con uno psicologo, basta un semplice "Vieni e seguimi".
Forse una scelta casuale, oppure no, oppure "volutamente " casuale... e uno aveva anche la moglie e relativa suocera.
E loro gli trotterellano dietro per tre anni: a volte capiscono, a volte lo contestano, ma tengono duro.
Alla fine uno lo tradisce, l'altro lo rinnega e tutti, tranne il ragazzino, tagliano la corda.
Però a loro è stata affidata la parola della speranza... e non pare sia stato un fiasco!
Più anomalo di così!
VI - Anomalia della preghiera
Anche il suo modo di pregare è del tutto anomalo a riguardo della tradizione.
Un maestro che si rispetti deve pregare insieme a tutti i suoi discepoli, magari sulle piazze così che tutti possano vedere ed imparare. Dovrebbe lasciare un bel libro di preghiere, magari con la musica, così che tutti possano dire: ma che bravo! E invece no!
«Non fate come gli ipocriti che pregano nelle piazze... ma quando preghi entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto... ». Mt 6,5 ss
Assolutamente divaricante! Ma è esattamente quello che fa Lui.
In diversi momenti si allontana dai suoi «e da solo pregava».
Una sola volta chiede a tre dei suoi di pregare con lui, ma loro si addormentano e anche quella volta resta solo. Di lì a poco sarà arrestato!
Però in questo caso qualcuno dei tre sente come Gesù chiama Dio: «Abbà Padre» (Mc14,36).
È l'appellativo degli affetti famigliari. Il termine ebraico indica la tenerezza che c'è tra un papà e il suo piccolino. Ed è stupendo e dobbiamo ringraziare Marco che lo ha registrato.
A dire la verità una preghiera ce l'ha lasciata, ma hanno dovuto quasi strappargliela di bocca. Lui stava pregando in disparte come al solito e discepoli riescono a metterlo con le spalle al muro: "Giovanni B. ha insegnato a pregare ai suoi discepoli e tu invece..." E lui consegna loro il Padre nostro. Tutto qui!
Anche per la preghiera l'intenzione di Gesù è di evitarne il fine di legittimare la sua rappresentanza di Dio, ma di manifestare la "dedizione incondizionata di Dio" stesso verso ogni uomo, per cui anche la preghiera non può essere che un gesto di estrema confidenza personale verso l'Abbà... che coincide con il desiderio di compiere la Sua volontà.
Più anomalo di così!
VII - Anomalia rispetto a Giovanni Battista
Possiamo pensare il Battista come ultimo rappresentate dei profeti dell'Antico Testamento nel quale si concentra in qualche modo il loro stile di predicazione.
Il senso del messaggio di Giovanni B. si può sintetizzare in questo modo: "Sta per arrivare il Regno di Dio perciò dovete fare penitenza e convertirvi perché quello sarà un giorno di giudizio, un dies irae. Razza di vipere, la scura è già posta alle radice dell'albero e chi non si dà da fare sarà tagliato fuori" (Vedi Mt 3 e paralleli).
Arriva Gesù e dice: "Beati i poveri... il Regno di Dio è in mezzo a voi... allora adesso potete convertirvi..."
Vale a dire: non è la conversione che fa venire il Regno di Dio, ma è il Regno che rende possibile la conversione.
In sostanza, grazie a Dio, il suo Regno non dipende da noi perché altrimenti...
Divaricante!
E Giovanni va in fibrillazione per cui manda a Gesù dei messaggeri: «sei tu quello che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro»?
Risposta: «I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati... ai prigionieri è annunciata la liberazione».
Allora il Regno di Dio coincide con la liberazione dal male, ogni male perché per Gesù Dio il Regno è questo e nient'altro che questo.
E proprio per questo Egli può rappresentarlo
1- in mezzo ai peccatori senza paura di esserne contaminato
2- attraverso i segni di liberazione dal male (non semplici miracoli)
3- con un'autorevolezza inaudita nei confronti della tradizione religiosa precedente
4- legittimando la speranza di vita dell'uomo nel bisogno
5- e i discepoli devono apprendere questa figura di Dio che non si impara sui libri
6- ma in una relazione continua e segreta con Dio coltivata nella forma dell'Abbà
VIII - Anomalia della rappresentanza di Dio
Tutto quanto detto può essere riassunto dicendo che Gesù si presenta sulla scena religiosa con una pretesa di alto profilo: essere il rappresentate assoluto di Dio. Ma le sue credenziali non sono quelle tipiche della divinità: fulmini, tuoni, incenerimento di avversari, qualche segno nei cieli, almeno un terremotino... Per dirla con il linguaggio della filosofia, i segni di un Dio alla Feuerbach, che per molti versi coincide con l'idea di Dio esistente nell'immaginario collettivo di tutti i tempi, compresi i nostri, anche se siamo venuti dopo.
1- Il piano dei sacerdoti e dei capi del popolo
I sacerdoti, i capi del popolo e ci mettiamo anche il procuratore romano Pilato, perché siamo in un regime tipicamente teocratico, organizzano una dimostrazione teologica. Se lo si condanna alla pena capitale si giunge alla verità perché se viene da Dio, Egli verrà in suo aiuto e impedirà che gli si faccia del male; se in vece è un impostore morirà come un cane. In entrambi i casi il problema è risolto.
Ovviamente essi pensano che la verità sia la seconda.
2- I discepoli di Gesù
Paradossalmente anche i discepoli condividono la stessa teologia, ma sono sicuri come l'oro che al momento buono Gesù tirerà fuori tutte le sue artiglierie, farà fuori tutti gli avversari e finalmente instaurerà il suo regno che dominerà tutta la terra.
Abbiamo racconti evangelici che ci fanno intendere questa teologia, anche se quando vengono messi per iscritto dagli stessi discepoli, qualche decennio dopo, probabilmente si vergognavano di avere pensato così. E lo troviamo chiaramente nella quarta sezione del vangelo di Luca che presenta il viaggio finale che porterà Gesù a Gerusalemme nel momento in cui devono attraversare un villaggio di samaritani:.
Lc 9,51 «Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse decisamente verso Gerusalemme 52 e mandò avanti dei messaggeri. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per fare i preparativi per lui. 53 Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme. 54 Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». 55 Ma Gesù si voltò e li rimproverò. 56 E si avviarono verso un altro villaggio».
Sono già tre anni che vanno dietro a Gesù, ma sono ancora sintonizzati sul prima: incenerire qualcuno fa sempre un bel effetto ai fini della propaganda!
D'altra parte dopo la Passione, la Morte e la Risurrezione ed essere stato con loro altri 40 giorni al momento dell'Ascensione la loro preoccupazione è ancora quella:
At 1,6 «Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: «Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?». 7 Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, 8 ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra». 9 Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo».
Più chiara è la cosiddetta "Confessione di Cesarea"
Mc 8,27 «Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo; e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: «Chi dice la gente che io sia?». 28 Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti». 29 Ma egli replicò: «E voi chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». 30 E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno.
31 E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare. 32 Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte, e si mise a rimproverarlo. 33 Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: «Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Il rimprovero a Pietro la dice lunga: ritiene che Gesù, il suo eroe, sia colto non tanto da un momento di stanchezza, ma da una vera e propria crisi di fede e lo rimprovera: "Come? noi ti abbiamo seguito fin qui perché vogliamo ricostruire il regno d'Israele e tu adesso ti tiri indietro"? Che guarda caso è esattamente la terza tentazione proposta da Satana nel deserto: un governo universale che domini su tutto il mondo...
E Pietro si becca del "Satana"! Da Uno che aveva affermato: «chi dice "raca" (sciocco) al suo fratello è degno del fuoco della Geenna (discarica dei rifiuti di Gerusalemme)».
3- La posizione di Gesù
Gesù si trova all'incrocio di un dilemma drammatico che riguarda la fedeltà / infedeltà alla sua testimonianza
Se Gesù resta fedele testimone all'immagine del Dio Abbà che ha praticato per tutta la sua vita, deve lasciarsi sopraffare dagli avversari e così tradire la fede che i discepoli hanno posto in lui.
Se tradisce la figura del Dio Abbà i suoi discepoli continueranno ad avere fede in lui, non subiranno dispersioni; certo dovrà fare fuori qualche sacerdote o capo del popolo, qualcosa non tanto grave perché tutto sommato è a fin di bene. Ma in questo modo però continuerebbe a sopravvive nell'uomo l'altra immagine di Dio, quella di un Dio che guarisce o ammazza, che benedice o maledice a seconda dei suoi disegni o capricci... che tanto «quanto il cielo è alto sopra la terra tanto lontano sono i pensieri di Dio dai nostri» come dice Isaia.
Come si vede è in gioco fede e tradimento in entrambi i casi... e due figure radicalmente diverse di Dio.
Essere fedele alla sua testimonianza tradendola nella figura della sopraffazione.
Essere fedele alla sua testimonianza tradendola nella figura nella figura dell'essere sopraffatto.
Ma possiamo dire anche:
essere infedele alla testimonianza del Dio Abbà introducendo per la prima volta una sopraffazione violenta verso i suoi oppositori infliggendo loro del male, cioè se fino ad oggi ha dato la vista ai ciechi, accecarne qualcuno, azzopparne altri, ecc.
Oppure: essere fedele alla testimonianza del Dio Abbà lasciandosi sopraffare? Sì, ma poi chi sostiene il suo buon diritto? E che ne sarà poi di quelli che fino ad oggi l'hanno seguito?
E poi tutte le sue parole saranno giudicate false, i gesti di liberazione dal male fasulli o opere del maligno.
Passi pure essere sopraffatto, ma qui si tratta di essere sopraffatto nel nome di Dio... e tutta la baracca che va a ramengo! Questo dilemma è la ragione delle lacrime e del sangue del Getsemani.
Poiché Gesù sceglierà quest'ultima ipotesi, di fronte a Pilato produce un disastro di autodifesa e di fronte ai sommi sacerdoti fa una figura meschina. Non appare per niente «profeta potente in parole ed opere», ma un poveraccio confuso.
E i discepoli che non vedono alcuna reazione, alcun miracolo si sentono autorizzati a pensare: "è proprio venuta meno la sua fede"... e restano scandalizzati.
L'uscita dal dilemma
Gesù esce dal dilemma anticipando con un simbolo reale la sopraffazione: si consegna alla memoria dei suoi come Pane e Vino separati, che significano, nella ritualità del tempio, una morte violenta . E i discepoli dovranno poi rileggere tutto questo alla luce di quanto avverrà il giorno dopo: «un profeta potente in parole ed opere» che non apre bocca e si lascia crocifiggere proprio come un poveraccio qualunque, anzi: come un malfattore qualunque. La compagnia dei due ladroni crocifissi con lui la dice lunga!
La consegna ai discepoli sta proprio in quel «fate questo in memoria di me» che non indica semplicemente un gesto liturgico, ma soprattutto una scelta di vita.
Il «fate questo in memoria di me» è bene interpretato da Luca
Lc 22,24 «Sorse anche una discussione, chi di loro poteva esser considerato il più grande. 25 Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. 26 Per voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. 27 Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve».
Sono parole che vogliono dire: "Io non voglio instaurare un dominio politico o religioso o morale come fanno i re e i sacerdoti che tutti si riferiscono ad un Dio nel nome del quale poi giustificare ogni loro violenza e sopraffazione perché quello è il "loro" Dio si chiami pure: Shaddai, El, Dio dei Padri, JHWH, Allah, Essere Supremo, Assoluto, Motore Immobile, Grande Entone che governa il mondo, ecc. Questo è il Dio che sta nell'immaginario collettivo, ma che non ha nulla a che fare con il Dio Abbà Padre la cui essenza è dedizione incondizionata. E appaia molto chiaramente che è quel loro dio che fa crocifissi, mentre il Dio Abbà, se proprio un crocifisso ci deve essere è disposto a prendersi Lui la croce. Ma neanche un grammo di male sarà inflitto ad un uomo nel suo nome".
Questo vuol dire e viene a costare la difesa dell'immagine del Dio di Gesù!
Giovanni è forse più radicale nell'elaborare il tema del servizio perché invece del racconto dell'istituzione dell'Eucaristia riporta la "Lavanda dei piedi"
Gv 13:1 «Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. 2 Mentre cenavano, [...]4 si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. 5 Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. [...] 12 Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? 13 Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. 14 Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. 15 Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi».
Nel dialogo con Pietro che non permette gli siano lavati i piedi dice: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Non è lo stesso senso del «fate questo in memoria di me»?
Si noti la dissimmetria: «Come ho lavato i piedi a voi», non voi lavateli a me, ma «lavateli l'un l'altro»
Proprio come il Comandamento Nuovo del v 34 «Come ho amato voi», non voi amate me, ma «amatevi gli uni gli altri».
Conclusione
Abbiamo cercato di evidenziare brevemente ciò che Gesù ha fatto per comunicarci la "sua" immagine di Dio, quella che egli conosce fin dal "principio" (archè Gv 1), l'immagine del Dio Abbà Padre.
Par fare questo non solo si è incarnato, ma ha dovuto fare anche un grande lavoro e una grande fatica per contrastare le precedenti immagini di Dio sedimentate nell'immaginario collettivo, fino a "consegnarsi" alla morte di croce.
La lezione è stata compresa? Non del tutto se ancora all'interno del Nuovo Testamento troviamo il racconto di Anania e Saffira (At 5) nel quale per una menzogna restano fulminati prima l'uno e poi l'altra.
La causa? Avere mentito allo Spirito Santo.
Certo, gli esegeti ci dicono che è un racconto didattico, ma qui non c'è lo Spirito di Gesù, la fatica di Gesù viene vanificata e lo Spirito Santo ne esce male.
Abbiamo sempre la necessità di purificare la nostra idea di Dio e in passi come questo o come quello di Eliseo dobbiamo decidere se uscire con Gesù e il Dio Abbà Padre o restare con il Dio dei filosofi, il Giustiziere, il Dio Vendicatore, il Dio di Feuerbach, ecc. Ma in questo caso tutte le nostre preghiere, i nostri sacrifici, le nostre penitenze non si sa dove ci possano portare perché lasciate al capriccio di un dio Imprevedibile.
L'Eucaristia, memoria di ciò che Gesù ha fatto dovrebbe istruirci e rammentarcelo ogni volta.
Se non facciamo così anche noi dobbiamo metterci in compagnia con i Suoi oppositori.
Queste incursioni nel Vangelo di Marco, condotte da Adriano G. terminano qui.
Prega per me.
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
S. Fausti, Ricorda e racconta il Vangelo. La catechesi narrativa di Marco, Ancora.
B. Maggioni, Il racconto di Marco, Cittadella editrice.
B. Maggioni, I racconti evangelici della passione, Cittadella editrice.
B. Maggioni, I racconti evangelici della risurrezione, Cittadella editrice.
J. Mateos - F. Camacho, Il Vangelo di Marco. Analisi linguistica e commento esegetico, Cittadella Editrice.
E. Mazza, Il Nuovo Testamento e la Cena del Signore, EDB.
G. F. Nolli, Evangelo secondo Marco,Greco, Latino, Italiano, Libreria Editrice Vaticana.
G. Perego, Marco. Introduzione, traduzione e commento. Greco - italiano, San Paolo.
R. Pesch, Il Vangelo di Marco, testo greco e traduzione, Paideia Editrice Brescia.
A. Poppi, Sinossi dei quattro Vangeli, greco - italiano, Edizioni messaggero Padova.
SE VUOI TORNARE ALL'ULTIMA PAGINA PUBBLICATA............................CLICCA QUI
