4- Glosse
.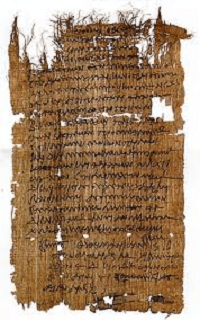
Nota esegetica 1 La veridicità dei fatti storici
Qualunque libro di storia si abbia tra le mani non è in realtà "storia", ma storiografia.
La storia è la successione dei fatti effettivamente accaduti nelle loro specifiche modalità, mentre le storiografie sono quello che di essi "raccontano" i libri di storia; che possono essere errati, ideologici, parziali e comunque partono sempre da un inevitabile punto di vista. La realtà, lo svolgimento preciso dei fatti narrati non possono più essere raggiunti.
Fra i vari criteri per accertare, solamente "accertare", se un fatto è effettivamente accaduto abbiamo il "senso" che quel fatto ha lasciato. Ci spieghiamo con un esempio basato sulla filosofia di Husserl.
Nei libri di storia scolastici, che in effetti sono anch'essi storiografie, veniamo a sapere che Giulio Cesare dopo avere conquistato le Gallie (Francia) tornando a Roma (50 a. C) attraversa il Rubicone... E ancora oggi se ne parla per indicare una scelta radicale; magari aggiungendo la famosa battuta: "Alea jacta est" .
Il Rubicone è un torrentello che sfocia nel mare poco più a sud di Cesena, per la maggior parte dell'anno asciutto; e quando lo si attraversa sull'Adriatica si fatica a notarlo.
Ma per arrivare fin lì Giulio Cesare ha dovuto attraversare fiumi molto più larghi, pericolosi e profondi. Pensiamo ad esempio al Rodano, al Ticino, al Po, ecc., per guadare i quali il suo esercito ha dovuto impiegare giorni e giorni e forse settimane. Eppure di quei fiumi... neanche una parola. Come se non ci fossero stati. Del Rubicone, che hanno attraversato a piedi asciutti e senza scendere da cavallo, ne parlano tutti i libri. Come mai?
Avendo attraversato il Rubicone senza congedare l'esercito, Cesare è automaticamente diventato nemico di Roma, l'esercito è un esercito invasore nemico, Pompeo fugge da Roma, il Senato cerca di organizzare una difesa e inizia una guerra civile che andrà avanti per qualche anno. La Repubblica è praticamente agonizzante e di lì a poco nascerà l'Impero Romano. E il Rubicone resta là al suo posto, quasi sempre in secca! Però da lì è partito tutto!
Non sappiamo se quel giorno piovesse, o nevicasse se fosse in piena o asciutto, ma è sicuro come l'oro che lo abbia attraversato e noi oggi ne parliamo, non perché lì ci fossero le telecamere, ma per il grande "senso" che ha lasciato nei contemporanei e in tutti quelli che sono venuti dopo. Oggi impropriamente potremmo dire che diventato un "simbolo".
Da qui un criterio per verificare la veridicità di fatti storici: "non c'è fatto senza senso, non c'è senso senza fatto".
Se non c'è senso i fatti si perdono perché non interessano a nessuno e così non diventano "storia". Come gli altri fiumi attraversati da Cesare.
Se c'è senso i fatti sono ricordati e diventano storia anche se al momento se ne sono accorti in pochi o sembravano irrilevanti.
Applicando questo criterio ai testi biblici, dobbiamo dire che essi non sono relazioni cronachistiche di avvenimenti, ma sono racconti di fatti lontani e confusi, che uomini di diverse generazioni hanno ritenuto importante "raccontare" ai loro figli e tramandare poi alle generazioni successive perché dotati di grande senso: per chi li raccontava e per chi li ascoltava.
Riferendoci al libro di Esodo, lo svolgimento particolareggiato di quell'evento si è perduto nella trasmissione fra le generazioni, ma è rimasto un nucleo fondamentale perché dotato di un grande senso: "un gruppo di schiavi guidati da un principe egiziano decaduto è riuscito a fuggire e i soldati che li hanno inseguiti sono annegati nel mare". Se fosse giovedì o domenica, se piovesse, se Mosè fosse alto 1,80 o 1,60 sono dati non tramandati perché privi di senso.
Poi questo nucleo originario si arricchito di racconti che avessero senso per quelli li ascoltavano magari centinaia di anni dopo. Per esempio, agli ebrei che tornano da Babilonia dopo 70 anni di esilio e probabilmente sono ormai solo i figli dei deportati, che trovano Gerusalemme ridotta ad un cumulo di rovine, cosa gli racconti? Gli dirai: guarda cos'hanno fatto i nostri padri fuggiti dall'Egitto che hanno dovuto vagare per quarant'anni prima di potere entrare in questa "terra dove scorre latte e miele. Loro sì che sono stati coraggiosi". Cioè, cercherai di infondere loro fiducia e speranza per un nuovo futuro. Più esattamente, riprenderai le tradizioni relative all'esodo dall'Egitto e le "risignificherai" per la loro situazione. Cioè, un racconto del passato attualizzato nell'oggi.
È la stessa cosa che facciamo noi quando leggiamo la Bibbia e poi ci chiediamo: cosa mi dice questo brano oggi?
Ecco, questo è il modo in cui nascono le diverse tradizioni o documenti o storiografie bibliche.
Nota esegetica 2 Storiografie bibliche
(Estratto sintetico da: G. Borgonovo, Il testo biblico: per un approccio scolastico, SEI, 24-ss; al quale è opportuno riferirsi per un quadro più completo della composizione e struttura della Bibbia).
Nel 1750 Jean Astruc (1750), medico personale di Luigi XV di Francia, (non esegeta, ma medico) ebbe un'idea che modificò pesantemente gli studi biblici. Osservando che in alcuni testi Dio era chiamato Elohim e in altri JHWH (il nome scritto per esteso è Jahwhè, ma l'uso ebraico e cristiano che non vuole pronunciare invano il nome di Dio lo sostituisce con "Signore" come fanno le nostre Bibbie) pensò che ciò fosse dovuto all'accorpamento di due documenti distinti e cercò di separarli ricostruendo i due testi originali. Egli chiamò la prima narrazione Elohista, la seconda Jahwista, termini rimasti nel vocabolario corrente.
Quello che conta è il principio: "esistono dei documenti precedenti che un copista ha messo insieme". Nasce così la"teoria documentaria". Su questa pista si sono mossi gli esperti e senza analizzare le vari fasi, arriviamo al 1880 quando la critica riconosce gli studi di J. Wellhausen (1880), il quale dimostra che i documenti originali sono quattro: lo Jahwista (J), l'Elohista (E), il Deuteronomista (D) e il sacerdotale (P), (dal tedesco Priestercodex).
La prosecuzione degli studi e la vivisezione dei testi portò ad individuare altri documenti per cui gli esperti parlavano di J1, J2, J3, o D1, D2, ecc.
Si pensi che un famoso commento di Esodo del 1961 usava sei diversi tipi di caratteri in modo da potere riconoscere subito a quale tradizione appartenesse ogni versetto (G. Azou, Dalla schiavitù al servizio, EDB). Forse si coltivava l'idea che più si andava indietro cercando gli strati più antichi si arrivasse ad una "verità più vera".
Poi però, si recuperò l'importanza della trasmissione orale dei racconti prima della loro trasformazione in documenti scritti, accreditando loro una maggior antichità. Così la "teoria documentaria" viene in parte abbandonata e si pensa ad una crescita della storiografia antica come tanti strati di tradizione che si sono venuti sedimentando attorno ad un nucleo narrativo più antico e scarno.
Negli ultimi decenni la teoria documentaria è stata messa in crisi, ad esempio, non ha senso parlare di un documento Jahwista ed Elohista, in quanto, per la storia premonarchica, si avrebbero solo materiali frammentari e dispersi, uniti in narrazione solo molto tardi da una mano deuteronomista. Per cui il discorso è alquanto complesso e a noi non interessa più di tanto. Tuttavia ogni storiografia ha delle caratteristiche proprie che possono aiutare la comprensione della Bibbia; ne vediamo alcune.
Storiografia jahwista (J)
L'opera di J è considerata la storiografia più antica e collocata nel periodo davidico-salomonico (X-IX secolo a. C.) e sarebbe un teologo-storiografo della corte gerosolimitana che, partendo dalla creazione (Gn 2,4b ss), voleva dare un fondamento unitario alle tribù unite in un solo regno a seguito delle guerre di Davide, e quindi giustificare l'istituzione monarchica davidica, presentandola come compimento delle promesse e delle benedizioni patriarcali.
Storiografia Elohista (E)
Questa storiografia E è un problema perché al di là delle affermazioni della prima ora è diventato molto forte il dubbio che non debba essere pensata come opera a sé, ma piuttosto da considerarsi come aggiunta o modificazione dello J. Buona parte degli studiosi oggi preferisce parlare di un complemento di J.
L'Elohista si ritrova qua e là nelle narrazioni del Pentateuco e ciò spiegherebbe la difficoltà di definire con precisione il suo arco narrativo. Normalmente viene datato nell'VIII secolo a.C. ed ambientato nel regno del Nord, in quanto riecheggia tematiche della predicazione profetica settentrionale.
Storiografia deuteronomista (D)
L'opera deuteronomista, facilmente decifrabile a livello di vocabolario, di fraseologia e di interessi teologici, è di ampio respiro storico ed è decisiva per la ricostruzione del periodo monarchico.
Il nucleo ideologico generatore lo troviamo nella riforma di Giosia (621a.C.). Viene trovato nel tempio un rotolo della legge (2 Re 22) che era stata dimentica, da cui "Seconda legge: " deuteros nomos"; la storicità del ritrovamento è molto discussa, ma è verosimile. Sta di fatto che attorno a questa "seconda legge" si forma l'opera teologica del Deuteronomio. Essa subisce revisioni e ampliamenti subito dopo la caduta di Gerusalemme per mano di colui che viene chiamato deuteronomista (sigla dtr).
A partire da questo nucleo teologico, il dtr vuole spiegare il perché della caduta di Gerusalemme e dell'esilio. Per questo rilegge tutta la storia, dall'insediamento nella terra promessa al momento in cui scrive.
Il suo racconto si conclude con l'esilio (585 a. C) e questo dovrebbe essere grosso modo il periodo di composizione. La tesi teologica è il rispetto del primo comandamento (Non avrai altro Dio fuori di me) e la centralizzazione del culto a Gerusalemme. Essa diventa il metro di giudizio per tutto il periodo. Qui sta anche la spiegazione della caduta di Gerusalemme e dell'esilio (2 Re 17,7-41): prima Israele e poi Giuda hanno tradito l'alleanza con JHWH, seguendo altri dèi e costruendo altri santuari oltre a quello di Gerusalemme. Per questo JHWH si adirò molto e si allontanò dal tempio così Gerusalemme potè cadere nelle mani dei nemici (Ez 10,18-22; 11,22-25)
L'opera dtr copre ben sei libri, oltre al Deuteronomio che originariamente fungeva con molta probabilità da introduzione: Giosuè, Giudici, 1 e 2 Samuele, 1 e 2 Re.
Storiografia sacerdotale (P)
La mano di questa scuola è facilmente distinguibile a partire dallo stile omogeneo e dagli interessi teologici che la guidano. Al tempo dell'esilio si fa risalire una prima stesura della storia detta "sacerdotale" (in tedesco Priester) proprio a causa dello spiccato interesse per le cose che riguardano il culto, il santuario, la circoncisione, il sabato e le leggi, che permettevano di mantenere la propria identità in un periodo di dispersione e frammistione agli altri popoli.
La caduta della monarchia e la tragedia dell'esilio imponevano la necessità di una rilettura della storia: le promesse e l'alleanza antica sembravano non avere più senso e il popolo era caduto in uno stato di indifferenza e delusione. C'era bisogno di un risorgimento, (cfr. Ez 36-37), che rileggesse la storia passata lasciando cadere quegli aspetti troppo materiali, per ridare fiducia e speranza ad un popolo distrutto.
A partire dalla creazione, P mostra il progressivo svelarsi di Dio: a tutta l'umanità come Elohim (= Dio), ai padri come El Shaddaj (= Dio del deserto o della montagna? Spesso tradotto come Dio onnipotente) e infine a Mosè come JHWH. Da questo momento in poi la "Gloria di Dio", in ebraico: "Kavod", abita in mezzo al suo popolo nella "Tenda": essa diventa il centro della vita del popolo d'Israele e l'accompagna in tutta la sua peregrinazione fino al traguardo della "Terra della promessa". Un messaggio di grande fiducia e speranza per coloro che, con l'esilio, sembrava avessero perso la terra materiale.
Questa tradizione ebbe ampliamenti di un certo rilievo nel periodo postesilico: fu il momento in cui il gruppo dei sacerdoti rimpatriati a Gerusalemme tentò di ripristinare e organizzare la nuova società teocratica, creando la coscienza di Israele come «popolo santo, nazione di sua conquista, regno di sacerdoti ». Gli ampliamenti riguardano soprattutto la sfera del culto (sacrifici, problemi di purità, il concetto di sacro) e la professione sacerdotale. Ma non mancano sezioni che riguardano la ridistribuzione della terra: sono sezioni che si ritrovano nella parte finale del libro dei Numeri.
Storiografia cronistica
I due libri delle Cronache e i libri di Esdra-Neemia rappresentano un ultimo tentativo storiografico presente nella tradizione biblica. Si discute molto del progetto unitario di questa opera storica. Senza entrare in questo problema complesso, possiamo dare i risultati accolti dalla maggior parte degli studiosi.
All'inizio del III secolo a. C., quando ormai la Giudea era nella sfera dell'impero ellenistico, uno storico (o una scuola) tenta di spiegare il proprio presente, rileggendo la storia antica. Per il periodo monarchico l'unico materiale a disposizione era la storiografia deuteronomista; per il periodo postesilico ci si rifèrì alle memorie di Neemia e alle tradizioni su Esdra, già in qualche modo conosciute.
Tre interessi particolari hanno guidato il cronista a rileggere il passato: la speranza messianica, il metro di giudizio sapienziale della retribuzione divina e la passione per il culto e in genere per la città di Gerusalemme, contro lo scisma samaritano. Dietro questa storiografia, s'intravede in filigrana la costante professione di fede che "Dio è con noi". Essa sola è capace di tenere viva quella speranza nazionalistica cui tenacemente si aggrappa il "resto d'Israele" che abita a Gerusalemme e nei dintorni, legato al tempio e al suo culto.
Nota esegetica 3
La complessità del Pentateuco
La presa di coscienza critica delle diverse storiografie, trattate nella nota esegetica 2, ci permette ora di comprendere meglio anche la complessità redazionale dei primi cinque libri biblici.
In un contesto precritico si riteneva che tutto il Pentateuco fosse stato scritto materialmente da Mosè senza fare troppi distinguo, e si pensava poi all'autore come uno scrittore che a tavolino scrive una sua opera.
La critica letteraria, con l'analisi delle diverse fonti o documenti, fece emergere la complessa storia della formazione di questi libri. Dapprima, reagì contro l'affermazione di Mosè autore del Pentateuco, applicando però ancora un concetto inadeguato di autore. Poi si moltiplicarono gli autori, aggiungendo la figura di un "redattore" finale, vale a dire un compilatore, normalmente considerato distratto e incapace di tessere perfettamente gli scritti che aveva tra le mani per giustificare le ripetizioni e tutte le incongruenze del testo.
Nello stesso tempo la considerazione della storia della tradizione orale, antecedente alla trasmissione del testo scritto, contribuì a spiegare il carattere frammentario e talvolta contraddittorio di alcune narrazioni antiche prima ancora della loro redazione scritta. Questa attenzione, già avvertita da H. Gunkel agli inizi del '900, non fu subito recepita e solo negli ultimi decenni sta producendo risultati degni di nota. In questa luce, più che di fonti, o documenti, si preferisce parlare di "tradizioni", le quali si sarebbero progressivamente sedimentate e arricchite lungo la storia dell'antico Israele, non sempre in vere e proprie opere a sé stanti.
L'attenzione alla fase pre-letteraria di un testo permette di vagliare con più equilibrio quei criteri invocati per l'attribuzione dei testi alle diverse "tradizioni" che ovviamente si sono ridotte di numero rispetto alle valutazioni precedenti.
Senza voler essere troppo rigidi nella loro applicazione si possono indicare alcuni criteri utili ad identificare le diversi tradizioni.
1- lo stile e il linguaggio;
2 - l'uso dei nomi divini (JHWH, Elohim, El Shaddai);
3 - le contraddizioni e le incongruenze;
4 - i duplicati e le ripetizioni;
5 - le diverse prospettive teologiche.
Al punto in cui ci troviamo nella ricerca possiamo dire che:
• è più facile identificare la mano deuteronomista (dtr) e sacerdotale (P); per il resto il lavoro diventa molto più ipotetico;
• l'attribuzione dei testi a J, E, D e P è una semplificazione di quel lungo processo tradizionale, il quale talvolta rimane imprecisabile proprio a causa della fase orale della trasmissione.
• questo lavoro critico non deve mirare all'inutile sforzo di ricostruire un "originale", magari mai esistito nella forma ipotizzata, ma a prendere coscienza della particolare complessità della formazione del testo che ora possediamo.
È questo testo I'oggetto dell'interpretazione. Noi dobbiamo interpretarlo nella forma e nella struttura in cui oggi si dà. La ricostruzione della storia della tradizione non deve scomporre e frantumare la redazione finale del testo, ma
deve rendere consapevole l'interprete della complessità di una narrazione, che è talvolta incongruente, cade in contraddizione o è duplicato di altri racconti.
Nota esegetica 4
I generi letterari
Quando uno studioso racconta dei fatti storici anche se cerca di essere rigoroso, "neutrale", inevitabilmente parte da un punto di vista e quindi si ha una "storiografia". Se poi il racconto non è fatto da uno storico, ma da persone che hanno altre funzioni la narrazione assume tonalità relative al compito svolto dal narratore. Sia ha così un genere letterario.
Ci spieghiamo brevemente con un esempio. Ecco come viene raccontato il medesimo incidente stradale.
1) Un testimone oculare all'amico: «La miseria che cosa ho visto! Ecco, ero in via Giulio Cesare, me ne andavo dritto per la strada, quando sfreccia a rapidità sbalorditiva un ciclista. Penso: "Ti spacchi la testa"! Nello stesso momento, crac! il ciclista vola per aria...».
2) Il verbale della polizia: «Il 3 aprile 1971, di pomeriggio, alle 17.07, N.N., nato il 12 agosto 1954, residente in via Battisti n. 55, percorreva con una bicicletta marca "Legnano" via Giulio Cesare in direzione di piazza Marconi. Su detta bicicletta non si sono potuti riscontrare difetti...».
3) Il sermone del parroco: «Cari fratelli! C'è una persona che vuol arrivare in un determinato posto in un preciso momento. Ha fatto bene i calcoli, arriverà per tempo. Basta darci dentro. Balza sulla sua bicicletta. Ma, nel viaggio, ecco un'ombra venire da destra! Quell'uomo cade e resta a terra ferito. Il suo piano è andato all'aria. Così, cari miei, è la vita umana...».
A prima vista viene da chiedersi: ma quelli parlano tutti della stessa cosa?
Sì, narrano tutti la stessa cosa, ma devono usare "generi letterari" differenti.
Allora possiamo dire che il genere letterario è la forma, la struttura che il testo assume in conseguenza del panorama di interessi dell'autore, del suo punto di vista, del suo linguaggio, del modo con cui descrive un fatto, nonché dei destinatari del racconto. Questo non significa che la verità sia altra rispetto al racconto, ma che la verità narrata non è mai il tutto di quel fatto, e che bisogna scavare ulteriormente se si vuole trovare qualcosa di più.
Nell'esempio riportato, oltre a quanto detto dai tre narratori, ci si può chiedere: il ciclista come avrà raccontato quell'incidente a sua moglie? come l'ha riferito agli amici del bar? come la moglie l'ha detto alle sue amiche? E chi più ne ha più ne metta.
Questo dice che lo stesso evento raccontato da persone diverse in ambiti differenti produce comprensioni altrettanto differenti. Non solo: Se nello stesso ambito cambiano gli uditori si avranno interpretazioni diverse dalle precedenti.
La critica letteraria ci ha reso attenti a distinguere il "genere letterario", riflettendo sulla relazione di un certo modo di narrare e la finalità propria del racconto all'interno dell'ambiente vitale (Sitz im Leben) in cui esso è stato narrato e tramandato.
Così in quell'esempio si tratta sempre dello stesso episodio, ma la finalità e l'ambientazione del racconto permettono di capire il diverso interesse manifestato dalle tre narrazioni per l'esattezza dei particolari.
Il racconto concitato dell'amico vuole sorprendere e quindi tende ad enfatizzare i particolari. L'asettico verbale che la polizia deve redigere ha il compito di segnalare tutte le circostanze dell'accaduto nel modo più preciso possibile. L'intento moralistico del predicatore non è per nulla interessato ai particolari, ma rende l'accaduto un caso esemplare per la sua tesi da dimostrare.
Ora, la Bibbia è una sorgente di generi letterari diversi. Le cose da raccontare sono talmente importanti che i diversi narratori sono stati indotti a potenziare il linguaggio usando i diversi generi letterari disponibili e creandone di nuovi per cercare di esprimere il mistero delle azioni di Dio nella storia.
In questa sede è possibile esaminare tutti i generi letterari biblici; ne vediamo solo alcuni che interessano il libro il Pentateuco ed in particolare Esodo, perché nella lettura dei testi non si prenda tutto "alla lettera".
L'eziologia
L'eziologia è la ricerca di una spiegazione di qualche particolare fenomeno che desta stupore. Il vocabolo deriva dal greco aition, causa, e logos, discorso, indagine, spiegazione. È un genere di racconto popolare, che non sente la difficoltà di mescolare realtà a fantasia. Proprio per questo motivo i racconti più antichi, che risalgono al periodo della trasmissione orale, sono ricchi di eziologie. Il valore dell'eziologia sta nella descrizione di come è una realtà, più che nell'esattezza scientifica della sua spiegazione.
Ad esempio in Gs 6 viene narrata la caduta di Gerico nelle mani di Giosuè e come le mura crollarono al suono delle trombe insieme all'urlo di guerra degli ebrei; una descrizione più liturgica che militare. Questo fatto è cantato ancora oggi da un celebre spiritual negro-americano (Joshua fit the battle of Jerico), che certamente ha dato molta speranza a diverse generazioni che hanno vissuto in condizioni di oppressione.
Però le ricerche archeologiche hanno mostrato che le mura di Gerico erano cadute qualche millennio prima dell'arrivo degli ebrei. Ma quelle mura mastodontiche, fatte di massi ormai rotolati a terra, hanno indubbiamente stupito gli ebrei che avevano appena attraversato il Giordano e si accingevano a conquistare la Terra Promessa. Forse questa eziologia aveva lo scopo di infondere loro fiducia e speranza. Più tardi, a quelli vissuti nei secoli successivi, è servita sostenerli quando di tanto in tanto un invasore assediava le loro città.
Il messaggio era qualcosa del tipo: non è la forza del tuo braccio che ti salva, ma la potenza di Dio "che ha perfino fatto crollare le mura di Gerico semplicemente al suono delle trombe".
L'eziologia metastorica di Gn 1-11
È un tipo tutto particolare di racconto. Con essa si vuole dare una risposta ai grandi perché dell'uomo: il perché della creazione, di questa storia, il problema del male, il senso dell'uomo in rapporto a Dio. Così i saggi costruirono racconti su canovacci molto antichi e comuni all'area culturale dell'antico vicino oriente. Con essi si voleva spiegare l'oggi, non il tempo passato, utilizzando una metastoria invece che una metafisica. È infatti una caratteristica del pensiero biblico leggere la realtà sul versante storico più che sul versante essenzialista o dell'essere. Metastoria non vuol dire "astorico" o "al di là della storia", ma piuttosto "fondativo della storia", spiegazione della storia di sempre, in parallelo a metafisica che è il fondamento della fisica.
Per esempio: il sapiente si chiede perché tutti gli uomini peccano e la sua risposta è: perché fin dall'inizio hanno peccato a partire dai progenitori. E poi lo spiega, non con una teoria, ma con un racconto: quello del giardino Gn3.
Il racconto patriarcale
I racconti più antichi, quelli che si riferiscono al periodo patriarcale, prima della storia scritta, sono memorie di clan o di famiglia. Essi sono centrati su pochi elementi: nascita di un figlio, ricerca di nuovi pascoli, battaglie che, in effetti, sono semplici scaramucce tra pastori, azioni eroiche, ecc. Non si preoccupano della connessione con l'insieme della vita di un personaggio o dei rapporti con la "grande storia", che rimane alquanto imprecisata. Si pensi a molti racconti di Gn 12-50 e alle azioni eroiche del libro dei Giudici.
I racconti patriarcali non sono biografie e si potrebbero accostare alle moderne narrazioni di storie familiari come Beautiful o Radici, con la differenza fondamentale che il racconto patriarcale nasce da piccole unità narrative, tramandate e sedimentate nella memoria di un gruppo e magari accorpate a quelle di altri gruppi a seguito di matrimoni o alleanze. In questi racconti troviamo spesso l'elenco delle generazioni (toledot) che è un modo per rendersi conto e mostrare la propria identità. Passi il paragone: oggi abbiamo le carte di identità, gli antichi usavano la successione delle generazioni. Cosa non da poco perché potevano essere in gioco interessi quali possesso di terreni, diritti di pascolo, ecc.
La saga
La saga, come amano chiamarla gli studiosi dell'area tedesca in analogia alla loro tradizione, tende a rivestire il ricordo del passato con nuovi elementi appartenenti al mondo del narratore che e non teme di aggiungere anche elementi leggendari, come, ad esempio, il ciclo di Sansone nel libro dei Giudici.
La saga e il racconto patriarcale, a differenza dell'eziologia, nasce da un avvenimento originante reale percepito come significativo per il presente.
Per certi versi questi racconti costituiscono una memoria storica, ma da vagliare molto criticamente, perché il nucleo originario è ormai intriso di aggiunte, impressioni e significati che rendono molto difficile raggiungerlo.
L'arringa profetica (rib)
L'arringa profetica è la requisitoria che il profeta pronuncia a nome di JHWH contro il popolo o il re che hanno violato l'alleanza o alcuni contenuti dell'alleanza. Essa segue uno schema molto preciso che è quello usato nei rapporti diplomatici tra un re e i suoi vassalli o alleati. Quando il grande re veniva a sapere che un suo vassallo non si era attenuto alle obbligazioni dell'alleanza siglata, mandava un ambasciatore che, a nome suo, pronunciasse un discorso di accusa e un invito a rispettare le clausole del patto, altrimenti si sarebbero poste in atto le "maledizioni" con cui normalmente un trattato si chiudeva.
L'arringa iniziava con la "formula del messaggero": «Così dice il gran sovrano...». E dopo aver elencato i benefici ottenuti dal vassallo, lo richiamava al rispetto del patto, minacciando un'azione punitiva nel caso di ulteriori inadempienze o la rottura completa e la guerra.
Analogamente le arringhe dei profeti iniziano con la "formula del messaggero": "Così dice JHWH..." e poi si entra nei particolari chiamando in giudizio i testimoni, esponendo le minacce, le maledizioni e, in genere, sempre in vista di una riformulazione del patto. Anche se non sono è propriamente testi profetici si può suggerire di leggere il salmo 50 che è l'arringa e poi il salmo 51 che è la richiesta di ripristinare l'alleanza.
Nel libro di Esodo troviamo una prima forma di arringa profetica: sono le richieste formulate da Mosè, il primo dei profeti, al Faraone.
La storiografia
È senza dubbio il genere letterario più diffuso e importante per i libri biblici, tanto che la Bibbia è spesso citata come "storia biblica". Ma cerchiamo anzitutto di capire quale storiografia è in gioco.
La capacità di stendere una storia è possibile solo ad un pensiero che ha raggiunto una visione sintetica di tutti i frammenti costituiti dai diversi eventi accaduti lungo i secoli.
Il primo di tutti i problemi è quello di una cronologia lineare valida per tutti. Questo vuol dire raccordare le innumerevoli cronologie particolari a quella lineare universale. Infatti i vari popoli antichi misuravano gli anni a partire da eventi per loro importanti: l'incoronazione del re, una vittoria strepitosa contro i nemici, un terremoto, un disastro climatico e via dicendo.
Il superamento di questa concezione ha consentito di considerare la storia come una successione di eventi legati tra loro e non semplicemente come un grande calderone in cui pescare a piacere quello che serviva per l'insegnamento.
Per quel che ci riguarda dobbiamo allora distinguere tra verità ed esattezza che sono due modi diversi di sondare la realtà dei fatti.
La verità mira a raggiungere il senso dei fatti del passato perché sia utilizzabile per l'oggi: "Historia magistra vitae" si diceva.
L'esattezza punta alla precisione degli eventi che però restano muti e opachi come una sequenza di date imparate a memoria per superare un esame scolastico.
Le storiografie bibliche che, appunto, cercano il senso degli eventi tentano di esprimere il disegno di Dio sulla storia, che non vuol dire ignorarne l'esattezza, ma andare oltre.
A dire il vero, dentro le storiografie bibliche troviamo spezzoni più vicini al genere delle storiografie moderne. Ad esempio, alla storia della successione al trono di Davide in 2 Sam 6-20 e 1 Re 1-2. Questo racconto è per lo storico moderno una fonte molto precisa dei movimenti di potere che si sono avuti alla fine del regno di Davide: i fatti vengono messi in primo piano e vengono documentati con riferimenti accurati.
Il racconto didattico
Il racconto didattico è più difficile da determinare per la sua apparente parentela con la storia. Scambiandolo per "storia" è spesso stato usato per contestare verità storica della Bibbia.
Il racconto didattico deve essere considerato una sorta di parabola allargata; gli studiosi parlano di "parabola espansa", la quale può usare notizie storiche, accostando tra loro personaggi e situazioni che non avrebbero mai potuto essere contigui.
Mentre la narrazione storica mira a descrivere come sono andati i fatti. La finalità del racconto didattico è quella di illustrare una verità di fede, formulata come tesi da dimostrare, il più delle volte espressa da qualche discorso dei protagonisti e intrecciata più o meno palesemente nello svolgimento del racconto.
La dimostrazione viene svolta creando un racconto nel quale i protagonisti hanno ruoli ben caratterizzati.
Sono un esempio il ciclo di Giuseppe (Gn 37-50) e i libri di Giuditta, Tobia, Giona.
Oltre al senso del racconto: mostrare una verità di fede, vi sono due altri criteri che possono aiutare a distinguere il racconto didattico dall'opera storica.
1- La evidente inesattezza dei dati storici, che non è frutto di ignoranza dei dati, ma volontà di leggere i diversi periodi storici che presentano gli stessi problemi.
Per esempio il libro di Giuditta inizia con: «Nell'anno decimosecondo del regno di Nabucodonosor, che regnava sugli Assiri nella grande città di Ninive, Arpacsad regnava sui Medi in Ecbatana» (Gdt 1,1).
Quando questo libro viene scritto nel II° secolo a. C. tutti sapevano che Nabucodonosor era il re che aveva distrutto di Gerusalemme nel 585 a.C. Tutti sapevano che la capitale era Babilonia e non Ninive e che egli era un re babilonese e non assiro. Inoltre nessuno conosceva un re dei Medi chiamato Arpacsad. Ma al narratore non interessava l'esattezza storica, bensì creare un personaggio che fosse per eccellenza il nemico del popolo di Dio. Il suo scopo era quello di rivelare una sequenza che si ripete nella storia, quasi una legge della natura, per confortare il popolo del suo tempo che viveva sotto il tallone di Antioco Epifane (169-164 a.C.) il quale voleva modificare a suo uso anche la religione dei padri.
2- Il secondo criterio è l'abbondanza di elementi simbolici e anche favolistici. Non si ha paura a far entrare in scena Dio o i suoi angeli (Tobia) ed anche i nomi assumono funzione narrativa. Si prenda il libro di Giona: non vi sono nomi propri, eccetto il nome-programma del protagonista ( = "colomba"); non c'è alcuna datazione, a differenza degli altri libri profetici. Ninive, la grande città, è simbolo del potere opposto a Dio; Tarsis, che per gli ebrei erano le "Colonne d'Ercole" è simbolo dell'estrema lontananza da Dio; il pesce significa la morte e gli inferi.
Il genere liturgico
Molto importanti per il libro di Esodo sono le prescrizioni liturgiche che spesso assumono la forma di un racconto. Infatti la liturgia, in molti modi, assume la forma di memoriale di un evento del passato, per cui quello stesso evento viene ripreso e raccontato, magari in forma epica come uno scontro tra il bene e il male o un intervento prodigioso di Dio. Allora bisogna essere molto attenti a non trattare questi eventi come avvenimenti storici tout court.
Anche la nostra Messa, per esempio è memoriale della morte e risurrezione di Gesù, ma in questo caso non c'è niente di epico.
Ci sono anche lunghi capitoli che riportano normative che stabiliscono pedantemente anche nei minimi dettagli come devono essere costruiti spazi e oggetti di culto e soprattutto come si devono svolgere i riti.
Si veda ad esempio Es 25-32;35-40.
Nota conclusiva
Tutto questo può dare l'impressione che i racconti biblici siano solo delle favole. Ammettiamolo pure, ma la fede riconosce a queste "favole" di essere "Parola di Dio". E questo è oggetto del nostro stupore! Come se Dio ci dicesse: "Guarda che quando io mi muovo agisco così".
Per saperne di più.
G. Borgonovo, Il testo biblico per un approccio scolastico; SEI.
J: A. Soggin, Storia d'Israele, Paideia.
Nota esegetica 5 - Compatibilità Cristologica
Premessa
Nel leggere la Bibbia troviamo espressioni che risultano dure ai nostri orecchi: guerra santa, sterminio dei nemici, herem, lapidazioni, impiccagioni e così via, tutte attuate nel nome di Dio. Abbiamo perciò il problema di interpretarle correttamente. Cerchiamo di farlo sinteticamente in questo scritto.
L'ultimo versetto del Prologo di Giovanni dice:
«Dio finora nessuno l'ha mai visto/ il Figlio Unigenito / che è nel grembo del Padre / lui lo ha rivelato» Gv 1,18
Però, se Lui ha "rivelato" il Padre tutti quelli che sono venuti prima: patriarchi, profeti, sacerdoti, giusti, ecc. cosa hanno comunicato? non hanno "rivelato" anche loro?
Il versetto segnala subito una differenza sostanziale: «prima nessuno l'ha mai visto » mentre il Figlio Unigenito è addirittura «nel grembo del Padre». E questo ribadisce Gv 1,1.
Allora la rivelazione di Gesù è in grado di mettere a punto, di correggere, purificare tutte le rivelazioni precedenti dalle "precomprensioni" introdotte dalle varie culture in si sono manifestate. E non sono poche dato che stiamo parlando di un arco di tempo di quasi 2000 anni, da Abramo (circa 1800 a. C.) fino a Gesù.
"Precomprensione" nel nostro caso vuol dire che quando uno dice: "Dio" io so già di che cosa si parla perché io ho già la "mia" idea di Dio, ma appunto la "mia".
Se invece voglio sapere com'è Dio e come agisce devo "guardare" Gesù.
Ora, i vangeli non raccontano tutto ciò che Gesù ha fatto perché non sono una descrizione cronachistica, ma solo le parole e i gesti che hanno colpito i suoi discepoli e i suoi interlocutori, talvolta antagonisti. Sono questi gesti e queste parole che gli stessi discepoli hanno ritenuto essenziali tramandare a noi venuti dopo e costituiscono la memoria evangelica. In particolare essi ci hanno tramandato alcune "anomalie" rispetto alla cultura religiosa di quel tempo perché anche per loro sono state difficili da digerire. E infatti non hanno esitato a segnalarci anche le figuracce che essi hanno fatto, quasi per dirci: guardate che si prendono cantonate e bisogna fare fatica.
Passiamo in rassegna alcune di queste anomalie più importanti.
[ Chi non vuole seguire tutto lo sviluppo può passare alla conclusione]
I Anomalia - Comunione con i peccatori
Peccatori in quel tempo erano le persone colpite da discredito religioso o morale. E non occorreva molto per esserlo o diventarlo, bastava nascere ciechi o zoppi o prendersi la lebbra ecc. Un malato era peccatore o figlio di peccatori, vedi Gv 9 e il libro di Giobbe. Era sufficiente toccare una donna durante il mestruo o non lavarsi le mani fino al gomito prima di mangiare, per finire in una esclusione di tipo teologico, perché c'era anche la teoria che li considerava maledetti da Dio.
Queste persone erano escluse dai rapporti sociali e chi li frequentava diventava come loro.
Invece Gesù non esita a frequentare questi personaggi esclusi: entra nella casa dei pubblicani (Zaccheo), si lascia toccare da una prostituta (Maddalena), difende un'adultera che i benpensanti volevano lapidare, Egli deliberatamente viola queste prescrizioni e, per farla breve, diciamo che va a cercare tutte queste figure che stano sotto il segno dell'esclusione. Sono gesti che gettano il discredito su di lui come uomo di Dio, ma Egli mostra chiaramente e duramente quando è il caso, di non esserne intaccato. Anzi usa parole molto dure e taglienti verso coloro che lo chiamano al rispetto della tradizione. (Riportiamo solo questi versetti, ma è consigliabile leggere tutto il capitolo)
Mc 2,15 «Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano. 16 Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori?». 17 Avendo udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori».
Sono rotture clamorose a riguardo della consuetudine. Ma Gesù insiste!
Vuol dire che queste "rotture" con il passato sono per lui molto importanti. Anzi essenziali!
II Anomalia - Univocità dei gesti di liberazione dal male
Tutti siamo pronti a sostenere che Gesù ha compiuto molti miracoli, ma questo termine non è usato nei Vangeli che invece parlano di guarigioni e cacciate dei demoni.
"Miracolo" è un termine molto ambiguo perché mette sullo stesso piano l'evento fausto e l'evento infausto verso l'uomo. Ci spieghiamo con un esempio.
Dopo che Elia è stato rapito verso il cielo su un carro di fuoco, Eliseo, il discepolo rimasto senza maestro resta per un po' di tempo a Gerico e poi leggiamo:
2 Re 2,23 «Di lì Eliseo andò a Betel. Mentre egli camminava per strada, uscirono dalla città alcuni ragazzetti che si burlarono di lui dicendo: «Vieni su, pelato; vieni su, calvo!». 24 Egli si voltò, li guardò e li maledisse nel nome del Signore. Allora uscirono dalla foresta due orse, che sbranarono quarantadue di quei fanciulli. 25 Di là egli andò al monte Carmelo e quindi tornò a Samaria».
La Bibbia di Gerusalemme intitola questo fatto come "Miracolo di Eliseo".
Bene, il teatro della rivelazione occupato da Gesù, cioè da Betlemme all'Ascensione non presenta mai, assolutamente mai, eventi di questo genere.
Se ci sono "miracoli" sono solo ciechi che vedono, zoppi che camminano, lebbrosi mondati, morti che risorgono.
E, importante, tutti questi gesti di Gesù sono coperti da un velo di discrezione; a qualcuno dice: "non dirlo a nessuno", a qualcun altro: "vai casa tua"... Sembra che Gesù voglia evitare il successo facile o trasformare la "liberazione di un uomo dal male" come strumento per acquisire un potere per sé.
Le guarigioni, a noi sembra impossibile, non hanno come fine il proselitismo o la propaganda.
Giovanni li chiama semplicemente "segni", cioè ci invita a vedere il contenuto, non il contorno.
Dobbiamo allora ricordare le "tentazioni nel deserto" (Mt 4 e paralleli) che gli sono suggerite da Satana: le pietre trasformate in pane, il buttarsi in caduta libera dal pinnacolo del tempio, il potere politico sul mondo intero accogliendone i suoi criteri (del mondo, cioè di Satana).
Tutte queste sono vie per il successo della missione che non liberano l'uomo dal male e lo lasciano ancora come prima e come sempre.
Che i cosiddetti "miracoli" siano solo "gesti di liberazione dell'uomo dal male" lo vediamo chiaramente quando si entra sulla scena della Passione. Lì non c'è nessun evento straordinario. Un soldato che cade dai gradini del Pretorio e si rompe una gamba, l'infartino ad un sacerdote o ad un funzionario romano avrebbero modificato radicalmente l'esito di quel processo... Ma non sarebbe emerso tutto l'orrore prodotto dal male / peccato. Uno che ha fatto solo del bene che viene crocifisso... in nome di Dio! E l'uomo non sarebbe stato liberato dal male, anzi qualcuno sarebbe stato colpito dal male. Qui che nel nome di Dio, a sostegno della sua causa, non accade neanche la sbucciatura di un ginocchio: neanche un miracolino piccolo piccolo
C'è un bel contrasto tra lo sbranamento di quarantadue bambini che hanno detto "crapa pelata" ad un profeta e quello che si svolge a Gerusalemme.
Divaricante! Assolutamente divaricante!
III Anomalia - Autorevolezza - exousia
Nella sinagoga di Cafarnao Gesù scaccia il demonio da un indemoniato. La scena dovette essere impressionante perché la gente commenta come segue:
Mc 1,27 «Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono!». 28 La sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea».
La sorpresa degli uditori di Gesù si può cogliere se teniamo presente il metodo di insegnamento usato da rabbini e maestri di quel tempo che era fatto di continue citazioni di maestri precedenti, quindi una autorevolezza basata sul riferimento ai giusti e ai sapienti del passato, mentre molto raramente Gesù cita i maestri del passato.
Infatti siamo di fronte ad «Una dottrina nuova insegnata con autorità». Da sottolineare "novità" oltre che "autorità".
La gente di Cafarnao rileva una cosa sconcertante in Gesù: l'inaudita rivendicazione di pieni poteri a riguardo dell'interpretazione delle Scritture, della Legge e soprattutto delle tradizioni.
Infatti nessun profeta, compreso Mosè, si è mai presentato ai suoi interlocutori dicendo: "Io vi dico...", ma sempre con le formule del messaggero del tipo: "Dice il Signore" oppure "Oracolo di JHWH". Gesù invece afferma categoricamente: "Io vi dico..." o addirittura: "Vi fu detto, ma io vi dico..."
Tutto ciò che appartiene alla tradizione della verità di Dio è confermato o sospeso in relazione alla sua approvazione o negazione.
La seconda parte del versetto riguarda l'azione «Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono».
Allora non si tratta solo di parole, ma anche di opere mai accadute prima, per cui vale l'espressione sintetica usata dai due discepoli che, dopo la Risurrezione, vanno verso Emmaus che lo definiscono: «Profeta potente in parole e opere davanti a Dio e davanti agli uomini» Lc 24,19.
Questa reazione delle persone semplici, come poteva essere la gente di Cafarnao, pescatori, lassù in Galilea, fa contrasto con le reazioni rabbiose che in seguito avverranno da parte di scribi, farisei, sadducei, a Gerusalemme.
Già da queste prime battute il conflitto appare inevitabile.
IV Anomalia - Legittimazione della speranza dell'uomo nel bisogno
L'autorevolezza di Gesù non è destinata ad affermare il suo potere, a specificare la sua grandezza, ma a sostenere e legittimare la speranza di una pienezza di vita di ogni uomo iniziando da quelli che sono nelle difficoltà: malati, emarginati, vecchi, peccatori, ecc.
Il desiderio di una vita che non sia meno che eterna, per Gesù è assolutamente pertinente. Eterna non definisce solo un tempo senza fine, ma l'insieme di tutto ciò che l'uomo può desiderare. Anche per questo egli risuscita i morti: Lazzaro, la figlia di Giairo, il figlio della vedova di Naim, ecc.
Anche all'uomo che si trova nella condizione più misera ed estrema Gesù assicura la speranza di un oltre, l'apertura di una futuro ulteriore.
Il desiderio di vita buona è sempre da lui apprezzato e sostenuto mentre l'idea precedente era del tipo: "Sei nato cieco, allora tu o qualcuno dei tuoi ha peccato quindi resta cieco perché sei un maledetto".
Un altro strappo netto verso la tradizione!
V - Anomalia del discepolato
L'uso dell'epoca era che i genitori pregassero un maestro che istruisse il figlio facendolo suo discepolo. Questo non avveniva molto pacificamente: il maestro sottoponeva il neofita a dure prove, esigeva un compenso molto salato e bastava un niente per rimandarlo a casa.
Gesù è del tutto fuori dal coro. Alcuni stanno pescando, altri stavano assettando le reti, un altro era seduto al banco delle tesse, altri gli chiedono dove abita e poi "stettero con lui", ecc.
A nessuno di loro sono richiesti titoli accademici, percorsi religiosi precedenti, esame vocazionale, colloquio con uno psicologo, basta invece un semplice "Vieni e seguimi".
Forse una scelta casuale, oppure no, oppure "volutamente " casuale... e uno aveva anche la moglie e relativa suocera.
E loro gli trotterellano dietro per tre anni: a volte capiscono, a volte lo contestano, ma tengono duro.
Alla fine uno lo tradisce, l'altro lo rinnega e tutti, tranne il ragazzino, tagliano la corda.
Però a loro è stata affidata la parola della speranza... e non pare sia stato un fiasco!
Più anomalo di così!
VI - Anomalia della preghiera
Anche il suo modo di pregare è del tutto anomalo a riguardo della tradizione.
Un maestro che si rispetti deve pregare insieme a tutti i suoi discepoli, magari sulle piazze così che tutti possano vedere ed imparare. Dovrebbe lasciare un bel libro di preghiere, magari con la musica, così che tutti possano dire: ma che bravo! E invece no!
«Non fate come gli ipocriti che pregano nelle piazze... ma quando preghi entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto... ». Mt 6,5 ss
Assolutamente divaricante! Ed è esattamente quello che fa lui.
In diversi momenti si allontana dai suoi «e da solo pregava».
Una sola volta chiede a tre dei suoi di pregare con lui, ma loro si addormentano e anche quella volta resta solo. Di lì a poco sarà arrestato!
Però in questo caso qualcuno dei tre sente come Gesù chiama Dio: «Abbà Padre» (Mc14,36).
È l'appellativo degli affetti famigliari. Il termine ebraico indica la tenerezza che c'è tra un papà e il suo piccolino. Ed è stupendo e dobbiamo ringraziare Marco che lo ha registrato.
A dire la verità una preghiera ce l'ha lasciata, ma hanno dovuto quasi strappargliela di bocca. Lui stava pregando in disparte come al solito e discepoli riescono a metterlo con le spalle al muro: "Giovanni B. ha insegnato a pregare ai suoi discepoli e tu..." E lui consegna loro il Padre nostro. Tutto qui!
Anche per la preghiera l'intenzione di Gesù è di evitarne al fine di legittimare la sua rappresentanza di Dio, ma di manifestare la "dedizione incondizionata di Dio" stesso verso ogni uomo, per cui anche la preghiera non può essere che un gesto di estrema confidenza personale verso l'Abbà... che coincide con il desiderio di compiere la Sua volontà.
Più anomalo di così!
VII - Anomalia rispetto a Giovanni Battista e i profeti precedenti
Possiamo pensare il Battista come ultimo rappresentate dei profeti dell'Antico Testamento nel quale si concentra in qualche modo il loro stile di predicazione.
Il senso del messaggio di Giovanni B. si può sintetizzare in questo modo: "Sta per arrivare il Regno di Dio perciò dovete fare penitenza e convertirvi perché quello sarà un giorno di giudizio, un dies irae. Razza di vipere, la scura è già posta alle radice dell'albero e chi non si dà da fare sarà tagliato fuori" (Vedi Mt 3 e paralleli).
Arriva Gesù e dice: "Beati i poveri... il Regno di Dio è in mezzo a voi... allora adesso potete convertirvi..."
Vale a dire: non è la conversione che fa venire il Regno di Dio, ma è il Regno che rende possibile la conversione.
In sostanza, grazie a Dio, il suo Regno non dipende da noi perché altrimenti...
Divaricante!
E Giovanni va in fibrillazione per cui manda a Gesù dei messaggeri: «sei tu quello che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro»?
Risposta: «I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati... ai prigionieri è annunciata la liberazione».
Allora il Regno di Dio coincide con la liberazione dal male, ogni male perché per Gesù Dio è questo e nient'altro che questo.
E proprio per questo Egli può rappresentarlo
1- in mezzo ai peccatori senza paura di esserne contaminato
2- attraverso i segni di liberazione dal male (non semplici miracoli)
3- con un'autorevolezza inaudita nei confronti della tradizione religiosa precedente
4- legittimando la speranza di vita dell'uomo nel bisogno
5- e i discepoli devono apprendere questa figura di Dio che non si impara sui libri
6- ma in una relazione continua e segreta con Dio coltivata nella forma dell'Abbà
VIII - Anomalia della rappresentanza di Dio
Tutto quanto detto può essere riassunto dicendo che Gesù si presenta sulla scena religiosa con una pretesa di alto profilo: essere il rappresentate assoluto di Dio. Ma le sue credenziali non sono quelle tipiche della divinità: fulmini, tuoni, incenerimento di avversari, qualche segno nei cieli, almeno un terremotino... Per dirla con il linguaggio della filosofia, i segni di un Dio alla Feuerbach, che per molti versi coincide con l'idea di Dio esistente nell'immaginario collettivo di tutti i tempi, compresi i nostri, anche se siamo venuti dopo.
1- Il piano dei sacerdoti e dei capi del popolo
I sacerdoti, i capi del popolo e ci mettiamo anche il procuratore romano Pilato perché siamo in un regime tipicamente teocratico, organizzano una dimostrazione teologica. Se lo si condanna alla pena capitale si giunge alla verità perché se viene da Dio, Egli verrà in suo aiuto e impedirà che gli si faccia del male; se in vece è un impostore morirà come un cane. In entrambi i casi il problema è risolto.
Ovviamente essi pensano che la verità sia la seconda.
2- I discepoli di Gesù
Paradossalmente anche i discepoli condividono la stessa teologia, ma sono sicuri come l'oro che al momento buono Gesù tirerà fuori tutte le sue artiglierie, farà fuori tutti gli avversari e finalmente instaurerà il suo regno che dominerà tutta la terra.
Abbiamo racconti evangelici che ci fanno intendere questa teologia, anche se quando vengono messi per iscritto qualche decennio dopo, probabilmente si vergognavano di avere pensato così.
La IV sezione del vangelo di Luca presenta l'inizio del viaggio finale che porterà Gesù a Gerusalemme e devono attraversare un villaggio di samaritani:.
Lc 9,51 «Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse decisamente verso Gerusalemme 52 e mandò avanti dei messaggeri. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per fare i preparativi per lui. 53 Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme. 54 Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». 55 Ma Gesù si voltò e li rimproverò. 56 E si avviarono verso un altro villaggio».
Sono già tre anni che vanno dietro a Gesù, ma sono ancora sintonizzati sul prima: incenerire qualcuno fa sempre un bel effetto ai fini della propaganda!
D'altra parte dopo la Passione, la Morte e la Risurrezione ed essere stato con loro altri 40 giorni al momento dell'Ascensione la loro preoccupazione è ancora quella:
At 1,6 «Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: «Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?». 7 Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, 8 ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra». 9 Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo».
Più chiara è la cosiddetta "Confessione di Cesarea"
Mc 8,27 «Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo; e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: «Chi dice la gente che io sia?». 28 Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti». 29 Ma egli replicò: «E voi chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». 30 E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno.
31 E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare. 32 Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte, e si mise a rimproverarlo. 33 Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: «Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Il rimprovero a Pietro la dice lunga: ritiene che Gesù, il suo eroe, sia colto non tanto da un momento di stanchezza, ma da una vera e propria crisi di fede e lo rimprovera: "Come? noi ti abbiamo seguito fin qui perché vogliamo ricostruire il regno d'Israele e tu adesso ti tiri indietro"? Che guarda caso è esattamente la terza tentazione proposta da Satana nel deserto: un governo universale che domini su tutto il mondo...
E Pietro si becca del "Satana"! Da Uno che aveva affermato: «chi dice "raca" (sciocco) al suo fratello è degno del fuoco della Geenna (discarica dei rifiuti di Gerusalemme)».
3- La posizione di Gesù
Gesù si trova all'incrocio di un dilemma drammatico che riguarda la fedeltà / infedeltà alla sua testimonianza
Se Gesù resta fedele testimone all'immagine del Dio Abbà che ha praticato per tutta la sua vita, deve lasciarsi sopraffare dagli avversari e così tradire la fede che i discepoli hanno posto in lui.
Se tradisce la figura del Dio Abbà i suoi discepoli continueranno ad avere fede in lui, non subiranno dispersioni; certo dovrà fare fuori qualche sacerdote o capo del popolo, qualcosa non tanto grave perché tutto sommato è a fin di bene. Ma in questo modo però continuerebbe a sopravvive nell'uomo l'altra immagine di Dio, quella di un Dio che guarisce o ammazza, che benedice o maledice a seconda dei suoi disegni o capricci... che tanto «quanto il cielo è alto sopra la terra tanto lontano sono i pensieri di Dio dai nostri» come dice Isaia.
Come si vede è in gioco fede e tradimento in entrambi i casi... e due figure radicalmente diverse di Dio.
Essere fedele alla sua testimonianza tradendola nella figura della sopraffazione.
Essere fedele alla sua testimonianza tradendola nella figura nella figura dell'essere sopraffatto.
Ma possiamo dire anche:
essere infedele alla testimonianza del Dio Abbà introducendo per la prima volta una sopraffazione violenta verso i suoi oppositori infliggendo loro del male, cioè se fino ad oggi ha dato la vista ai ciechi, accecarne qualcuno, azzopparne altri, ecc.
Oppure: essere fedele alla testimonianza del Dio Abbà lasciandosi sopraffare? Sì, ma poi chi sostiene il suo buon diritto? E che ne sarà poi di quelli che fino ad oggi l'hanno seguito?
E poi tutte le sue parole saranno giudicate false, i gesti di liberazione dal male fasulli o opere del maligno.
Passi pure essere sopraffatto, ma qui si tratta di essere sopraffatto nel nome di Dio... e tutta la baracca che va a ramengo! Questo dilemma è la ragione delle lacrime e del sangue del Getsemani.
Poiché Gesù sceglierà quest'ultima ipotesi, di fronte a Pilato produce un disastro di autodifesa e di fronte ai sommi sacerdoti fa una figura meschina. Non appare per niente «profeta potente in parole ed opere», ma un poveraccio confuso.
E i discepoli che non vedono alcuna reazione, alcun miracolo si sentono autorizzati a pensare: "è proprio venuta meno la sua fede"... e restano scandalizzati.
L'uscita dal dilemma
Gesù esce dal dilemma anticipando con un simbolo reale la sopraffazione: si consegna alla memoria dei suoi come Pane e Vino separati, che significano, nella ritualità del tempio, una morte violenta . E i discepoli dovranno poi rileggere tutto questo alla luce di quanto avverrà il giorno dopo: «un profeta potente in parole ed opere» che non apre bocca e si lascia crocifiggere proprio come un poveraccio qualunque, anzi: come un malfattore qualunque. La compagnia dei due ladroni crocifissi con lui la dice lunga!
La consegna ai discepoli sta proprio in quel «fate questo in memoria di me» che non indica semplicemente un gesto liturgico ma soprattutto una scelta di vita.
Il «fate questo in memoria di me» è bene interpretato da Luca
Lc 22,24 «Sorse anche una discussione, chi di loro poteva esser considerato il più grande. 25 Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. 26 Per voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. 27 Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve».
Sono parole che vogliono dire: "Io non voglio instaurare un dominio politico o religioso o morale come fanno i re e i sacerdoti che tutti si riferiscono ad un Dio nel nome del quale poi giustificare ogni loro violenza e sopraffazione perché quello è il "loro" Dio si chiami pure: Shaddai, El, Dio dei Padri, JHWH, Allah, Essere Supremo, Assoluto, Motore Immobile, Grande Entone che governa il mondo, ecc. Questo è il Dio che sta nell'immaginario collettivo, ma che non ha nulla a che fare con il Dio Abbà Padre la cui essenza è dedizione incondizionata. E appaia molto chiaramente che è quel loro dio che fa crocifissi, mentre il Dio Abbà, se proprio un crocifisso ci deve essere è disposto a prendersi Lui la croce. Ma neanche un grammo di male sarà inflitto ad un uomo nel suo nome".
Questo vuol dire e viene a costare la difesa dell'immagine del Dio di Gesù!
Giovanni è forse più radicale nell'elaborare il tema del servizio perché invece del racconto dell'istituzione dell'Eucaristia riporta la "Lavanda dei piedi"
Gv 13:1 «Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. 2 Mentre cenavano, [...]4 si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. 5 Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. [...] 12 Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? 13 Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. 14 Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. 15 Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi».
Nel dialogo con Pietro che non permette che gli lavi i piedi dice: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Non è lo stesso senso del «fate questo in memoria di me»?
Si noti la dissimmetria: «Come ho lavato i piedi a voi», non voi lavateli a me, ma «lavateli l'un l'altro»
Proprio come il Comandamento Nuovo del v 34 «Come ho amato voi» non voi amate me ma «amatevi gli uni gli altri».
Conclusione
Abbiamo cercato di evidenziare brevemente ciò che Gesù ha fatto per comunicarci la "sua" immagine di Dio, quella che egli conosce fin dal "principio" (archè Gv 1), l'immagine del Dio Abbà Padre.
Par fare questo non solo si è incarnato, ma ha dovuto fare anche un grande lavoro e una grande fatica per contrastare le precedenti immagini di Dio sedimentate nell'immaginario collettivo, fino a "consegnarsi" alla morte di croce.
La lezione è stata compresa? Non del tutto se ancora all'interno del Nuovo Testamento troviamo il racconto di Anania e Saffira (At 5) nel quale per una menzogna restano fulminati prima l'uno e poi l'altra.
La causa? Avere mentito allo Spirito Santo.
Certo, gli esegeti ci dicono che è un racconto didattico, ma qui non c'è lo Spirito di Gesù, la fatica di Gesù viene vanificata e lo Spirito Santo ne esce male.
Abbiamo sempre la necessità di purificare la nostra idea di Dio e in passi come questo o come quello di Eliseo dobbiamo decidere se uscire con Gesù e il Dio Abbà Padre o restare con il Dio dei filosofi, il Giustiziere, il Dio Vendicatore, il Dio di Feuerbach, ecc. Ma in questo caso tutte le nostre preghiere, i nostri sacrifici, le nostre penitenze non si sa dove ci possano portare perché lasciate al capriccio di un dio Imprevedibile.
L'Eucaristia, memoria di ciò che Gesù ha fatto dovrebbe istruirci e rammentarcelo ogni volta.
Nota esegetica 6 La Bibbia e il tempo novembre 2013
Abbiamo avuto modo di segnalare nel contesto delle letture relative alla Prima Pasqua, (vedi lettura 25), che in quell'occasione si ha l'invenzione del tempo lineare e l'abbandono del tempo naturistico, ciclico, ripetitivo, tipico del mondo agricolo, legato al succedersi delle stagioni.
Tuttavia pur se la nostra concezione del tempo viene dalla Bibbia, il rapporto della Sacra Scrittura con il tempo stesso non è propriamente il nostro. Noi abbiamo acquisito una precisa idea di storia secondo la quale gli avvenimenti devono essere collocati nella loro precisa successione temporale. Basti pensare alle "date" che si devono imparare per le interrogazioni e gli esami di storia. Però questo bisogno di precisione storica nasce solo verso la fine del '700 insieme alle periodizzazioni: Medioevo, Rinascimento, ecc. Ma sia chiaro: un medievale non ha mai saputo di essere "medievale"!
La Bibbia, invece, attribuisce agli avvenimenti storici e di conseguenza anche al tempo, un significato teologico, il che ha consentito ai redattori di spostare avanti e indietro i fatti per sostenere il "loro" disegno teologico.
Se ora consideriamo l'Antico Testamento secondo la suddivisione ebraica in tre parti abbiamo:
1- La Torah o Legge, corrispondente al Pentateuco
2- I Nevihim o Profeti, che nella suddivisione ebraica contengono anche i libri storici come Giosuè, Giudici, Re...
3- Ketubim o Altri Scritti, corrispondenti grosso modo ai Libri Sapienziali: Qoelet, Salmi, Giobbe...
Ora seguiamo quanto scrive P. Beuchamp, L'uno e l'altro testamento, vol. 1, pg 157 ss, Paideia:
«Il rapporto con il tempo non è lo stesso per la Legge, i Profeti, la Sapienza.
La Legge antidata le leggi in modo spregiudicato perché sotto l'immagine dell'inizio nasconde l'origine.
Il Profeta mostra le condizioni di emergenza della Parola nel suo tempo usando la cronologia universale degli astri e della storia.
La Sapienza fa un discorso a-cronico o pan-cronico.
La Legge pone un "prima". Il Profeta pone un "adesso". Il Sapiente parte da un "sempre".
In questo modo tutta la Legge "diventa" opera di Mosè. Infatti fino al 700 e oltre si credeva che Mosè fosse l'autore di tutto il Pentateuco. La Sapienza sarebbe tutta opera di Salomone, il re saggio per eccellenza.
Il Profeta, inviato da Dio, parla nel suo tempo, del suo tempo».
Si noti come all'inizio di quasi tutti i libri dei profeti è ricordato il nome del re e l'anno del regno e spesso anche il luogo.
Siccome Esodo fa parte della Torah, tralasciamo Profeti e Sapienza e cerchiamo di capire come essa (Torah) è strutturata in relazione al tempo. Lo facciamo seguendo la traccia di G. A. Borgonovo, Torah e storiografie dell'Antico Testamento, LDC , pg 93 ss.
La Torah narra il passato partendo addirittura dalla Creazione perché essa diventi Rivelazione e norma di ogni momento della creazione stessa.
In questo modo nel passato trovo il senso del presente, quindi la mia identità e l'identità di Dio (Es 34,5-9). E questa riflessione avviene durante e nel post-esilio quando non c'è più il re, il Tempio è distrutto e Gerusalemme è un cumulo di rovine.
Così ripensando al suo passato, Israele scopre la propria identità di popolo liberato da un Dio che si è rivelato come Elohim nella Creazione, come El Shaddai ai Patriarchi e come JHWH nell'Esodo.
È un popolo chiamato dalla schiavitù (abodah) al servizio (abodah). Ma un servizio che si esercita attraverso due verbi: abodah, servizio, appunto, e shamar: osservare, custodire... Che cosa? Il Comandamento dell'Alleanza.
Abbiamo poi la risalita fino alla Creazione il cui scopo non intende informare sulla nascita del kosmos, ma vuole mostrare qual è la natura dell'uomo, il suo Essere. Dice Borgonovo: «è una grammatica dell'essere che chiede di essere attuata in ogni momento dell'esserci».
Anche la filosofia greca cercava l'origine dell'Essere, l'Archè, il principio. Così come la Bibbia che parte da "bereshit", «In "principio" creò Dio il cielo e la terra...». Ma Giovanni si spinge oltre perché va ad un "principio" ancora più lontano.«En archè en ho Logos...»: «In principio era il Verbo... e tutto fu fatto per mezzo di Lui». Allora la creazione non è l'origine. C'è un originario ancora più remoto.
In questo quadro i racconti dei Patriarchi, ancora nomadi, fondano la "premessa" della liberazione dalla "casa di schiavitù" e della "promessa" di "una Terra in cui scorre latte e miele".
Ma è una Terra il cui possesso è precario perché sempre condizionato dallo "shamar", osservanza e custodia del Comandamento dell'Alleanza. Se esso viene trasgredito c'è sempre un Faraone di turno pronto a riportare il popolo in Egitto, si chiami pure Assiria o Babilonia o quello che si vuole.
Per questo il libro del Deuteronomio, l'ultimo della Torah, ribadisce continuamente l'alternativa tra possesso e perdita della Terra e, più radicalmente l'alternativa tra vita e morte.
Dt 9,1 Ascolta, Israele! Oggi tu attraverserai il Giordano per andare a impadronirti di nazioni più grandi e più potenti di te, di città grandi e fortificate fino al cielo, 2 di un popolo grande e alto di statura, dei figli degli Anakiti che tu conosci e dei quali hai sentito dire: Chi mai può resistere ai figli di Anak? 3 Sappi dunque oggi che il Signore tuo Dio passerà davanti a te come fuoco divoratore, li distruggerà e li abbatterà davanti a te; tu li scaccerai e li farai perire in fretta, come il Signore ti ha detto. 4 Quando il Signore tuo Dio li avrà scacciati dinanzi a te, non pensare: A causa della mia giustizia, il Signore mi ha fatto entrare in possesso di questo paese; mentre per la malvagità di queste nazioni il Signore le scaccia dinanzi a te. 5 No, tu non entri in possesso del loro paese a causa della tua giustizia, né a causa della rettitudine del tuo cuore; ma il Signore tuo Dio scaccia quelle nazioni dinanzi a te per la loro malvagità e per mantenere la parola che il Signore ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. 6Sappi dunque che non a causa della tua giustizia il Signore tuo Dio ti dà il possesso di questo fertile paese; anzi tu sei un popolo di dura cervice.
Però Dio è sempre fedele alle sue promesse e quando il popolo dell'Alleanza la trasgredisce perde la Terra; ma quando si pente e ritorna a JHWH la Terra gli viene restituita:
Dt 11,8 Osserverete dunque tutti i comandi che oggi vi do, perché siate forti e possiate conquistare il paese che state per entrare a prendere in possesso 9 e perché restiate a lungo sul suolo che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri e alla loro discendenza: terra dove scorre latte e miele.
Il Deuteronomio e con esso la Torah si chiude prima dell'entrata nella Terra.
Un solo uomo non la perderà mai: è Mosè che dalla vetta del Nebo contempla quella grande distesa si fiumi e valli e lì si chiudono i suoi occhi. L'impresa per la quale è stato chiamato da JHWH è stata completata: la terra è portata di mano, basta attraversare il Giordano.
Ora tentiamo una conclusione
Se questo è il disegno che avevano in testa i redattori della Torah, i quali hanno "violentato" la storia, sorge per noi il problema di come leggere questo scritto. Dobbiamo tenere conto delle scansioni della storia facendone una lettura diacronica oppure dobbiamo leggere il testo così come ci è pervenuto, lettura sincronica?
In questo secondo caso si tratterebbe di leggerlo come hanno fatto fino al '700 coloro che ci hanno preceduto che non avevano la nostra sensibilità circa la storia.
Oggi l'esegesi ritiene che si debbano prendere le distanze dalla lettura diacronica se essa intende contestare il testo ricevuto, mentre è da apprezzare se aiuta a comprendere meglio il senso del messaggio biblico. Che vuole anche dire: tenere conto della "storia della rivelazione", proprio perché la rivelazione è stata comunicata secondo un disegno storico e non tutta in una volta .
Una lettura sincronica che esclude la storia, in fondo, è come se ritenesse che la rivelazione è stata consegnata ad un autore, un agiografo seduto a tavolino davanti ad un papiro che, ispirato da Dio, compilava i vari testi così appare in certi affreschi che raffigurano, ad esempio, Mosè o gli evangelisti in quel modo.
L'ispirazione, invece, è una realtà molto più complessa perché riporta l'esperienza di Dio che hanno fatto più persone nelle situazioni più disparate della vita, che è diventata racconto, poi scritto, poi gli scritti insieme ad altri racconti hanno portato alla redazione di nuovi documenti, e così via. Ad esempio, se guardiamo al vertice della rivelazione che è Gesù Cristo, Lui non ha scritto un rigo.
Allora nel nostro caso possiamo dire che anche i redattori che hanno composto la Torah strutturandola con l'idea di tempo di cui abbiamo detto, erano ispirati quindi sotto l'influsso dello Spirito. Loro possono avere commesso tutti gli errori ortografici, di composizione e comunque sempre orientati dal loro punto di vista e tuttavia erano ispirati. Il sacro testo è uscito dalla loro penna. Noi non possiamo modificare neanche una iota.
Ecco cosa dice un documento ufficiale: Pontificia Commissione Biblica, L'interpretazione biblica nella Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, pg35-36, 1993.
«Circa l'inclusione nel metodo [esegetico] di un'analisi sincronica dei testi, bisogna riconoscere che si tratta di un'operazione legittima perché è il testo nel suo stadio finale che è espressione della Parola di Dio e non una redazione anteriore. Ma lo studio diacronico rimane indispensabile per far comprendere il dinamismo storico che anima la Sacra Scrittura e per manifestare la sua ricca complessità: per esempio il Codice dall'Alleanza (Es 21-23) riflette uno stato politico, sociale e religioso della società israelitica diverso da quello che riflettono le altre legislazioni conservate nel Deuteronomio (Dt 12-26) e nel Levitico (Codice di Santità Lv 17-26). Bisogna ricordare che alla tendenza storicizzante, che si rimproverava alla esegesi storico-critica non succeda l'eccesso inverso: la dimenticanza della storia da parte di un'esegesi esclusivamente sincronica.
In definitiva lo scopo del metodo storico-critico è quello di mettere in luce, in modo soprattutto diacronico, il senso espresso dagli autori e redattori. Con l'aiuto di altri metodi e approcci, esso apre al lettore moderno l'accesso al significato del testo della Bibbia così come l'abbiamo».
Tutto questo vuol dire che non ci deve sconcertare scoprire che dal punto di vista storico, la Prima Pasqua non è avvenuta nella notte che ha preceduto la fuga dall'Egitto o che nelle teofanie del Sinai manca il "Vitello d'oro", come mostra la lettura diacronica, che ovviamente ha il suo senso. Anche perché il "Vitello d'oro" storico riguarda i due idoli costruiti da Geroboamo, dopo la divisione del Regno, a Betel e Dan (1Re 12,26-33) in opposizione al Tempio di Gerusalemme.
Ma non possiamo fermarci lì. L'insieme della lettura diacronica e sincronica ci mostra chiaramente l'intenzione e l'ammonizione dell'agiografo diretta al lettore di tutti i tempi, quindi anche a noi del XXI secolo.
Egli ci dice: guarda che il popolo già al momento della sua nascita come popolo, appena ricevuta la Legge dell'Alleanza, si è costruito un idolo. Anche tu, se non stai attento, rischi di fabbricarti, nei momenti più impensati, il tuo Vitello d'oro, anche se lo chiami: carriera, soldi, sesso, i-pod, i- pad o internet, ecc..
Nota esegetica 7 I salmi imprecatori
Nella note esegetica 5 abbiamo sostenuto che la lettura della Bibbia deve essere cristologicamente compatibile.
Vale a dire che noi interpretiamo le Scritture dal punto di vista di Gesù Cristo perché Lui è il vero ermeneuta di tutta la Parola di Dio.
Ne segue che la nostra lettura della Bibbia è condizionata dall'idea che nutriamo a riguardo di Gesù Cristo.
Certamente Gesù era buono, ma la sua bontà non corrisponde con il "buonismo" o il "politically correct" oggi imperanti in ogni comunicazione pubblica.
Gesù era buono ma non buonista.
Nei vangeli vi sono passaggi che dovrebbero dissolvere certe idee magari legate a sacre immagini mielose e sdolcinate.
Quando si tratta di trattare il male o i malvagi Gesù non esita a ricorrere a parole, a invettive e a mezzi molto, ma molto severi.
Di uno dice: « Guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito! Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato» Mt 26,24
Ad un altro: «È, inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono; sarebbe meglio per quell'uomo si legasse una macina di mulino e sia gettato nel mare» Lc 17,1
Ai ricchi dice più volte: «Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione» Lc 6,24, invettiva del "discorso della montagna" che da alcuni viene fatto passare come decalogo del buonismo.
Dice anche: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a portare pace, ma una spada»Mt 10, 34-39.
Gesù arriva anche a praticare la violenza fisica con i venditori del tempio:
«Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e i cambiavalute seduti al banco. 15 Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi, 16 e ai venditori di colombe disse: «Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato» Gv 2, 14.
Un Gesù "buonista" che sta lì a preparare con cura una sferza di cordicelle per prendere a frustate i venditori... lo togliamo dal Vangelo? Oggi diremmo che è un affronto alla libertà d'impresa.
La minaccia: "guai" indirizzata a scribi, farisei, sadducei e capi dei popoli è usata moltissime volte; più esattamente in tutto il Nuovo Testamento è presente 50 volte e ben 32 volte è pronunciata da Gesù. Al contrario la parola "pace" è usata 26 volte e "amore" solo 9 volte.
Il racconto del "Giudizio universale" di Mt 25 dovrebbe farci riflettere circa l'atteggiamento del Buon Pastore nei confronti del male e di chi opera il male.
La Bibbia è intransigente verso il male e chi non si pente di averlo compiuto.
Ma scandalizza la nostra sensibilità quando essa sostiene colui che lo ha subìto di chiedere a Dio di essere vendicato. Sì, certo, una vendetta, però non eseguita direttamente dall'offeso, ma affidata al giudizio di Dio.
Questo troviamo soprattutto nei Salmi. Ora, se i salmi sono il modo in cui Dio ama essere pregato proprio perché sono "Parola di Dio", e tra di essi troviamo alcuni che suonano duri alle nostre orecchie, non dovremmo fare le anime belle che li eliminano, ma dovremmo provare a calarci nella situazione di colui o coloro che quel male l'hanno subito.
In breve, non possiamo permetterci di mutilare la Parola di Dio senza avere cercato spiegazioni e giustificazioni che gli studiosi possono offrire.
Per questo riteniamo opportuno riportare quanto scrive Enzo Bianchi, priore della comunità monastica di Bose, nota per la profonda spiritualità biblica, che egli tratta nell'opuscolo, "Pregare i salmi", Gribaudi, pag 37ss.
«E concludiamo queste osservazioni sui salmi come preghiera cristiana con una nota sui salmi imprecatori: i cristiani hanno avuto difficoltà a pregarli e soprattutto oggi pretendono di qualificarli come salmi precristiani, facenti parte di una rivelazione imperfetta, quando non arrivano a parlare di preghiera non cristiana. E qui noi diventiamo forzatamente polemici a motivo dello zelo per la parola di Dio.
Nel nuovo breviario tre salmi sono stati addirittura tolti e in molti altri sono stati tralasciati versetti considerati impossibili a pregarsi. Io capisco lo zelo pastorale di chi ha compiuto tale riforma, ma non posso approvarlo. Di fatto, con questo provvedimento di epurazione, invocato con superficialità anche dai sedicenti rinnovatori postconciliari, si mettono in causa i padri ebrei e li si giudica incattiviti per la troppa umiliazione subita; si dichiara che la loro preghiera era selvaggia e non secondo la rivelazione.
Ma se oggi questi salmi ci disgustano, forse è perché non li abbiamo capiti.
Certo, darli tali e quali da pregare significa dare pietre ai figli che chiedono pane, ma non darli significa diminuire la loro razione di pane. E poi, se oggi i salmi imprecatori non sono di moda, per dei cristiani che non conoscono l'oppressione ma hanno la tendenza a diventare oppressori, per dei cristiani che vivono in società del benessere e dell'opulenza, domani quale altra parte della Scrittura non sarà di moda? Per me questo è un cedimento, perché la parola di Dio non si mutila, semmai la si riceve in silenzio e la si dice sottovoce come fanno molte sinagoghe ebraiche, proprio per i salmi imprecatori, lasciandoli al mistero di Dio. Ma non li tralasciano. Chi ci autorizza a togliere l'apice o lo iota che Cristo ha dichiarato che non sarà tolto dalla Scrittura? Certo, se noi non li capiamo, se nelle assemblee li proclamiamo e li cantiamo senza aver educato alla comprensione i fedeli, ci sentiremo dire, come è successo in un monastero, da parte di giovani che avevano partecipato all'ufficio notturno dei monaci: «Perché vi alzate alle tre di notte per dire tutti questi insulti e fare tante maledizioni?».
Ma non si risolve il problema togliendoli e cancellandoli come se non fossero Parola di Dio. E poi siamo così sicuri che nel Nuovo Testamento questo genere letterario di esortazione profetica contro i cattivi sia scomparso? Non troviamo forse sulla bocca di Cristo espressioni riprese dai salmi di imprecazione e di condanna?
Quell'imprecazione: «Su di essi cada vergogna per sempre, confusione e perdizione!» del Sal 83,18 non è ripresa da Gesù in Mt 25,41?
E quella del Sal 109,8 non è usata dal Nuovo Testamento in At 1,20 contro il traditore?
Le attribuzioni del Sal 58,5 ai malvagi non sono riprese dal Vangelo in Mt 3,7?
E le maledizioni del Sal 69,23-24 non sono riecheggiate da Cristo per gli invitati scortesi e indegni del Regno in Mt 22,13?
Queste urla, queste grida imprecatorie sono tutte sintetizzate nel grido continuo dell'Apocalisse dove gli `anawim, i poveri, gridano in nome delle loro oppressioni davanti al trono dell'Agnello: «Fino a quando, o Signore santo e verace, non compi il giudizio e non trai vendetta del nostro sangue dagli abitanti della terra?» (Ap 6,10).
E le espressioni di Giacomo (5,1-6) verso i ricchi non sono secondo le invettive dei salmi, come pure quelle delle maledizioni in Lc 6,24-25?
Perché non togliamo quelle del Nuovo Testamento, se togliamo quelle dell'Antico?
Non a caso, e rincresce ma occorre dirlo, la prima comunità monastica che tolse i salmi imprecatori tolse pure, come si nota nel suo lezionario, tutte le parti del Nuovo Testamento che oggi non sono di moda, ossia le invettive.
La nostra opinione è che i salmi o i versetti imprecatori vanno lasciati: non possono essere aboliti, perché sono parola di Dio! Se non li comprendiamo, facciamo come i rabbini che consigliano di leggerli sottovoce, senza proclamarli col canto, ma lasciamoli, affinché la parola di Dio sia intatta. E poi, a moda corrisponde moda, e nel pluralismo delle mode ho sentito più volte esclamare, per esempio: «Sono salmi, quelli imprecatori, con cui ci si sente perfettamente d'accordo. C'è troppa ingiustizia nel mondo, troppi tiranni, ed è un sollievo poter dire, nella preghiera, ciò che si pensa di loro!».
Al di là delle mode, questi salmi sono lo strumento dei poveri, degli oppressi, dei giusti perseguitati di fronte al male operante nella storia: costoro trovano nei salmi imprecatori tutta la forza per gridare a Dio, per chiedergli di intervenire, astenendosi però dal farsi giustizia da sé e rimettendo a Dio ogni castigo del male.
Ma vediamo altre ragioni per mantenere i salmi imprecatori.
Innanzitutto, la liturgia non deve essere ridotta ad ogni costo a un clima edulcorato. Mi sembra che la proclamazione dei salmi imprecatori nelle nostre assemblee sia uno strumento efficace affinché, senza dare scomuniche, ognuno accolga su di sé una parola di giudizio, ognuno mangi e beva la propria condanna o la propria giustificazione. Non è bene che nel trovarsi insieme tutto sia bello, tutto dolce, tutto buono ad ogni costo. La liturgia non si accorderebbe con la realtà! C'è una violenza, una collera che abita in noi! Paolo dice infatti: «Andate in collera» (Ef 4,26 che cita Sal 4,5 LXX). La collera è un sentimento umano che cogliamo più volte sulle labbra, sul viso e nel cuore di Cristo. I salmi devono dunque esprimerla e sono forse il mezzo per non lasciare «tramontare il sole sulla nostra ira»; in essi noi la sfoghiamo davanti a Dio e lasciamo che sia lui, e non noi, a fare giustizia. Esiste una buona e santa aggressività. Le collere di Cristo verso i capi non erano collere finte. Nelle lotte dell'umanità, nella violenza, nella persecuzione, non si può fare sempre il viso dolce. Ma il salmista che impreca è un uomo povero, debole, che
Come farà Cristo, anche il salmista situa nell'orizzonte escatologico la sua liberazione e la condanna degli empi. Nel Talmud è scritto: «Quei tali barioniti che abitavano nelle vicinanze di Rabbi Me'ir lo opprimevano molto. Rabbi Me'ir pregò che morissero; gli disse sua moglie Berurjà: "Su quale testo ti appoggi? Forse perché sta scritto: 'Periscano i peccatori?'. È scritto forse: 'Peccatori?'. 'Peccati', sta scritto! Inoltre prosegui a leggere nel verso: 'Gli empi non ci saranno più' (Sal 104,35). Ma se sono scomparsi i peccatori, e i malvagi non sono più! Implora invece la misericordia [di Dio] perché si convertano! "» (Berakhot 10a).
Dunque anche gli ebrei han capito e sottolineato il vero senso dei salmi imprecatori; noi possiamo capirlo come loro.
Infine mi pare che per noi cristiani ci sia un'altra ragione per dire i salmi imprecatori. Essi sono l'occasione di meditare sulla morte del giusto, dell'innocente, Gesù Cristo. Senza il loro riferimento all'alleanza i salmi imprecatori sono solo grida di vendetta; ma situati nel contesto dell'evento cristiano sono l'espressione dell'odio nei confronti del male, odio che deve essere vigoroso, profetico, a causa della santità di Dio, della santità dell'alleanza. Sono questi salmi il luogo su cui noi possiamo giudicare in che misura siamo desiderosi di non edulcorare il nostro cristianesimo e in quale misura abbiamo capito la profondità dell'amore di Dio per noi nello scandalo della croce. Il salmista chiede la vendetta di Dio sui nemici perché il male deve essere punito, il peccatore deve essere castigato. Ma la vendetta e il castigo di Dio sono vendetta di giustizia e castigo liberatore che si sono abbattuti su Gesù Cristo, come osservava Bonhoeffer. Le sue piaghe che ci hanno guarito, la morte che egli ha inchiodato sulla croce, il suo corpo castigato e punito sono stati il segno dell'avvenuta vendetta di Dio. Dio certo non si è vendicato con la legge umana della vendetta. La vendetta di Dio contro i suoi nemici ha obbedito alla legge di Dio che è legge di amore. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio Gesù: ecco la vendetta di Dio!
Quando ci sono le imprecazioni, saremmo ben poco cristiani se le indirizzassimo a delle persone; ma saremmo ben poco cristiani anche se pensassimo che tali vendette sono vendette al modo umano. La vendetta di Dio è che la giustizia agisce contro il peccato, e il peccato è sempre peccato che esige riparazione, non contraccambio o risposta all'offesa con l'offesa. Dio compie la sua giustizia inviando suo Figlio nel mondo. Dio prende sul serio il peccato: non lo dimentica, lo punisce, ma lo punisce a modo suo, secondo la sua legge che è legge d'amore. Gli oranti del Primo Testamento giustamente chiedevano la vendetta e Dio l'ha da
I salmi imprecatori non diventano così più comprensibili? Non acquistano forse un senso? I salmi imprecatori dicono: «Trattali come colpevoli» (Sa15,11), e Dio ha trattato come colpevole suo Figlio (Is 53,4); «gli empi vadano agli inferi», canta il Sal 9,18, e Dio ha mandato allo she' ol Gesù; «toglili dalla terra dei vivi» (Sal 52,7), e Gesù fu tolto dalla terra dei vivi (Is 53,8); «li coprano l'insulto e l'infamia», grida il Sal 71,13, ed egli ha preso l'insulto su di sé (Is 53,3), ha preso la vergogna invocata sui nemici di Dio dal Sal 40,16. Mistero dell'amore di Dio! Le vendette invocate sui suoi nemici sono quelle subite da Gesù.
I salmi imprecatori ci insegnano, dunque, anche se ne ammettiamo le difficoltà pastorali, che Dio agisce sì nella vendetta, ma agisce con amore, con molto amore, amandoci fino alla fine. Una sinossi tra i salmi imprecatori e il capitolo 53 di Isaia non illumina forse i salmi imprecatori, e non ci permette forse di recitarli tenendo lo sguardo sul mistero della croce, dove il giusto servo del Signore ha giustificato le moltitudini? «Per le sue piaghe noi siamo stati guariti» (Is 53,5)».
Nota esegetica 8 Il tema del demonio
Presentazione
Non è possibile presentare il demonio e tutte le sue varianti mediante definizioni o concetti. È necessario invece comprenderlo attraverso una storia perché la verità, ormai dovrebbe essere assodato, si dà storicamente.
In questo caso anche il catechismo parla del demonio attraverso tutte le interazioni che ha avuto con Dio, con gli uomini, e con la creazione, in ultima analisi ancora con la storia.
Anche la Redenzione ha dovuto scontrarsi con questo personaggio.
Subito dopo il battesimo Gesù va nel deserto dove viene tentato dal diavolo. Inizia lì una dura lotta che avrà il suo esito definitivo e vittorioso solo nella croce e nella risurrezione, proprio perché ciò che il tentatore vuole impedire è il "Messia Crocifisso".
Infatti il nome ebraico Satan significa: oppositore, accusatore, nemico, avversario.
Diavolo deriva dal greco: dia-ballo: diviso-metto, da cui divisore.
Demonio deriva dal greco e originariamente erano esseri spirituali positivi o negativi e solo più tardi hanno assunto solo la connotazione negativa.
Già tutti questi nomi danno l'idea di un essere dalla personalità sfuggente.
NB: i numeri in grassetto sono gli articoli del catechismo, mentre le note a piè pagina sono reperibili sulla versione originale del Catechismo reperibile sul sito del Vaticano: http://www.vatican.va/archive/ccc_it/ccc-it_index_it.html
DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 1992
Paragrafo 7
LA CADUTA
385 Dio è infinitamente buono e tutte le sue opere sono buone. Tuttavia nessuno sfugge all'esperienza della sofferenza, dei mali presenti nella natura – che appaiono legati ai limiti propri delle creature – e soprattutto al problema del male morale. Da dove viene il male? « Quaerebam unde malum et non erat exitus – Mi chiedevo donde il male, e non sapevo darmi risposta », dice sant'Agostino, 501 e la sua sofferta ricerca non troverà sbocco che nella conversione al Dio vivente. Infatti « il mistero dell'iniquità » (2 Ts 2,7) si illumina soltanto alla luce del mistero della pietà. 502 La rivelazione dell'amore divino in Cristo ha manifestato ad un tempo l'estensione del male e la sovrabbondanza della grazia. 503 Dobbiamo, dunque, affrontare la questione dell'origine del male, tenendo fisso lo sguardo della nostra fede su colui che, solo, ne è il vincitore. 504
I. «Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia»
La realtà del peccato
386 Nella storia dell'uomo è presente il peccato: sarebbe vano cercare di ignorarlo o di dare altri nomi a questa oscura realtà. Per tentare di comprendere che cosa sia il peccato, si deve innanzi tutto riconoscere il profondo legame dell'uomo con Dio, perché, al di fuori di questo rapporto, il male del peccato non può venire smascherato nella sua vera identità di rifiuto e di opposizione a Dio, mentre continua a gravare sulla vita dell'uomo e sulla storia.
387 La realtà del peccato, e più particolarmente del peccato delle origini, si chiarisce soltanto alla luce della rivelazione divina. Senza la conoscenza di Dio che essa ci dà, non si può riconoscere chiaramente il peccato, e si è tentati di spiegarlo semplicemente come un difetto di crescita, come una debolezza psicologica, un errore, come l'inevitabile conseguenza di una struttura sociale inadeguata, ecc. Soltanto conoscendo il disegno di Dio sull'uomo, si capisce che il peccato è un abuso di quella libertà che Dio dona alle persone create perché possano amare lui e amarsi reciprocamente.
Il peccato originale - una verità essenziale della fede
388 Col progresso della Rivelazione viene chiarita anche la realtà del peccato. Sebbene il popolo di Dio dell'Antico Testamento abbia in qualche modo conosciuto la condizione umana alla luce della storia della caduta narrata dalla Genesi, non era però in grado di comprendere il significato ultimo di tale storia, che si manifesta appieno soltanto alla luce della morte e della risurrezione di Gesù Cristo. 505 Bisogna conoscere Cristo come sorgente della grazia per conoscere Adamo come sorgente del peccato. È lo Spirito Paraclito, mandato da Cristo risorto, che è venuto a convincere « il mondo quanto al peccato » (Gv 16,8), rivelando colui che del peccato è il Redentore.
389 La dottrina del peccato originale è, per così dire, « il rovescio » della Buona Novella che Gesù è il Salvatore di tutti gli uomini, che tutti hanno bisogno della salvezza e che la salvezza è offerta a tutti grazie a Cristo. La Chiesa, che ha il senso di Cristo, 506 ben sa che non si può intaccare la rivelazione del peccato originale senza attentare al mistero di Cristo.
Per leggere il racconto della caduta
390 Il racconto della caduta (Gn 3) utilizza un linguaggio di immagini, ma espone un avvenimento primordiale, un fatto che è accaduto all'inizio della storia dell'uomo. 507 La Rivelazione ci dà la certezza di fede che tutta la storia umana è segnata dalla colpa originale liberamente commessa dai nostri progenitori. 508
391 Dietro la scelta disobbediente dei nostri progenitori c'è una voce seduttrice, che si oppone a Dio, 509 la quale, per invidia, li fa cadere nella morte. 510 La Scrittura e la Tradizione della Chiesa vedono in questo essere un angelo caduto, chiamato Satana o diavolo. 511 La Chiesa insegna che all'inizio era un angelo buono, creato da Dio. « Diabolus enim et alii dæmones a Deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali – Il diavolo infatti e gli altri demoni sono stati creati da Dio naturalmente buoni, ma da se stessi si sono trasformati in malvagi ». 512
392 La Scrittura parla di un peccato di questi angeli. 513 Tale « caduta » consiste nell'avere, questi spiriti creati, con libera scelta, radicalmente ed irrevocabilmente rifiutato Dio e il suo Regno. Troviamo un riflesso di questa ribellione nelle parole rivolte dal tentatore ai nostri progenitori: « Diventerete come Dio » (Gn 3,5). « Il diavolo è peccatore fin dal principio » (1 Gv 3,8), « padre della menzogna » (Gv 8,44).
393 A far sì che il peccato degli angeli non possa essere perdonato è il carattere irrevocabile della loro scelta, e non un difetto dell'infinita misericordia divina. « Non c'è possibilità di pentimento per loro dopo la caduta, come non c'è possibilità di pentimento per gli uomini dopo la morte ». 514
394 La Scrittura attesta la nefasta influenza di colui che Gesù chiama « omicida fin dal principio » (Gv 8,44), e che ha perfino tentato di distogliere Gesù dalla missione affidatagli dal Padre. 515 « Il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo » (1 Gv 3,8). Di queste opere, la più grave nelle sue conseguenze è stata la seduzione menzognera che ha indotto l'uomo a disobbedire a Dio.
395 La potenza di Satana però non è infinita. Egli non è che una creatura, potente per il fatto di essere puro spirito, ma pur sempre una creatura: non può impedire l'edificazione del regno di Dio. Sebbene Satana agisca nel mondo per odio contro Dio e il suo regno in Cristo Gesù, e sebbene la sua azione causi gravi danni – di natura spirituale e indirettamente anche di natura fisica – per ogni uomo e per la società, questa azione è permessa dalla divina provvidenza, la quale guida la storia dell'uomo e del mondo con forza e dolcezza. La permissione divina dell'attività diabolica è un grande mistero, ma « noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio » (Rm 8,28).
La prova della libertà
396 Dio ha creato l'uomo a sua immagine e l'ha costituito nella sua amicizia. Creatura spirituale, l'uomo non può vivere questa amicizia che come libera sottomissione a Dio. Questo è il significato del divieto fatto all'uomo di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, « perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti » (Gn 2,17). « L'albero della conoscenza del bene e del male » (Gn 2,17) evoca simbolicamente il limite invalicabile che l'uomo, in quanto creatura, deve liberamente riconoscere e con fiducia rispettare. L'uomo dipende dal Creatore, è sottomesso alle leggi della creazione e alle norme morali che regolano l'uso della libertà.
Il primo peccato dell'uomo
397 L'uomo, tentato dal diavolo, ha lasciato spegnere nel suo cuore la fiducia nei confronti del suo Creatore 516 e, abusando della propria libertà, ha disobbedito al comandamento di Dio. In ciò è consistito il primo peccato dell'uomo. 517 In seguito, ogni peccato sarà una disobbedienza a Dio e una mancanza di fiducia nella sua bontà.
398 Con questo peccato, l'uomo ha preferito se stesso a Dio, e, perciò, ha disprezzato Dio: ha fatto la scelta di se stesso contro Dio, contro le esigenze della propria condizione di creatura e conseguentemente contro il suo proprio bene. Costituito in uno stato di santità, l'uomo era destinato ad essere pienamente « divinizzato » da Dio nella gloria. Sedotto dal diavolo, ha voluto diventare « come Dio » (Gn 3,5), ma « senza Dio e anteponendosi a Dio, non secondo Dio ». 518
399 La Scrittura mostra le conseguenze drammatiche di questa prima disobbedienza. Adamo ed Eva perdono immediatamente la grazia della santità originale. 519 Hanno paura di quel Dio 520 di cui si sono fatti una falsa immagine, quella cioè di un Dio geloso delle proprie prerogative. 521
400 L'armonia nella quale essi erano posti, grazie alla giustizia originale, è distrutta; la padronanza delle facoltà spirituali dell'anima sul corpo è infranta; 522 l'unione dell'uomo e della donna è sottoposta a tensioni; 523 i loro rapporti saranno segnati dalla concupiscenza e dalla tendenza all'asservimento. 524 L'armonia con la creazione è spezzata: la creazione visibile è diventata aliena e ostile all'uomo. 525 A causa dell'uomo, la creazione è soggetta alla schiavitù della corruzione. 526 Infine, la conseguenza esplicitamente annunziata nell'ipotesi della disobbedienza 527 si realizzerà: l'uomo tornerà in polvere, quella polvere dalla quale è stato tratto. 528 La morte entra nella storia dell'umanità. 529
401 Dopo questo primo peccato, il mondo è inondato da una vera « invasione » del peccato: il fratricidio commesso da Caino contro Abele; 530 la corruzione universale quale conseguenza del peccato; 531 nella storia d'Israele, il peccato si manifesta frequentemente soprattutto come infedeltà al Dio dell'Alleanza e come trasgressione della Legge di Mosè; anche dopo la redenzione di Cristo, fra i cristiani, il peccato si manifesta in svariati modi. 532 La Scrittura e la Tradizione della Chiesa richiamano continuamente la presenza e l'universalità del peccato nella storia dell'uomo:
« Quel che ci viene manifestato dalla rivelazione divina concorda con la stessa esperienza. Infatti, se l'uomo guarda dentro al suo cuore, si scopre anche inclinato al male e immerso in tante miserie che non possono certo derivare dal Creatore che è buono. Spesso, rifiutando di riconoscere Dio quale suo principio, l'uomo ha infranto il debito ordine in rapporto al suo ultimo fine, e al tempo stesso tutto il suo orientamento sia verso se stesso, sia verso gli altri uomini e verso tutte le cose create ». 533
Conseguenze del peccato di Adamo per l'umanità
402 Tutti gli uomini sono coinvolti nel peccato di Adamo. San Paolo lo afferma: « Per la disobbedienza di uno solo, tutti sono stati costituiti peccatori » (Rm 5,19); « Come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato... » (Rm 5,12). All'universalità del peccato e della morte l'Apostolo contrappone l'universalità della salvezza in Cristo: « Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita » (Rm 5,18).
403 Sulle orme di san Paolo la Chiesa ha sempre insegnato che l'immensa miseria che opprime gli uomini, la loro inclinazione al male e l'ineluttabilità della morte non si possono comprendere senza il loro legame con la colpa di Adamo e prescindendo dal fatto che egli ci ha trasmesso un peccato dal quale tutti nasciamo contaminati e che è « morte dell'anima ». 534 Per questa certezza di fede, la Chiesa amministra il Battesimo per la remissione dei peccati anche ai bambini che non hanno commesso peccati personali. 535
404 In che modo il peccato di Adamo è diventato il peccato di tutti i suoi discendenti? Tutto il genere umano è in Adamo « sicut unum corpus unius hominis – come un unico corpo di un unico uomo ». 536 Per questa « unità del genere umano » tutti gli uomini sono coinvolti nel peccato di Adamo, così come tutti sono coinvolti nella giustizia di Cristo. Tuttavia, la trasmissione del peccato originale è un mistero che non possiamo comprendere appieno. Sappiamo però dalla Rivelazione che Adamo aveva ricevuto la santità e la giustizia originali non soltanto per sé, ma per tutto il genere umano: cedendo al tentatore, Adamo ed Eva commettono un peccato personale, ma questo peccato intacca la natura umana, che essi trasmettono in una condizione decaduta. 537 Si tratta di un peccato che sarà trasmesso per propagazione a tutta l'umanità, cioè con la trasmissione di una natura umana privata della santità e della giustizia originali. Per questo il peccato originale è chiamato « peccato » in modo analogico: è un peccato « contratto » e non « commesso », uno stato e non un atto.
405 Il peccato originale, sebbene proprio a ciascuno, 538 in nessun discendente di Adamo ha un carattere di colpa personale. Consiste nella privazione della santità e della giustizia originali, ma la natura umana non è interamente corrotta: è ferita nelle sue proprie forze naturali, sottoposta all'ignoranza, alla sofferenza e al potere della morte, e inclinata al peccato (questa inclinazione al male è chiamata « concupiscenza »). Il Battesimo, donando la vita della grazia di Cristo, cancella il peccato originale e volge di nuovo l'uomo verso Dio; le conseguenze di tale peccato sulla natura indebolita e incline al male rimangono nell'uomo e lo provocano al combattimento spirituale.
406 La dottrina della Chiesa sulla trasmissione del peccato originale è andata precisandosi soprattutto nel V secolo, in particolare sotto la spinta della riflessione di sant'Agostino contro il pelagianesimo, e nel XVI secolo, in opposizione alla Riforma protestante. Pelagio riteneva che l'uomo, con la forza naturale della sua libera volontà, senza l'aiuto necessario della grazia di Dio, potesse condurre una vita moralmente buona; in tal modo riduceva l'influenza della colpa di Adamo a quella di un cattivo esempio. Al contrario, i primi riformatori protestanti insegnavano che l'uomo era radicalmente pervertito e la sua libertà annullata dal peccato delle origini; identificavano il peccato ereditato da ogni uomo con l'inclinazione al male (« concupiscentia »), che sarebbe invincibile. La Chiesa si è pronunciata sul senso del dato rivelato concernente il peccato originale soprattutto nel II Concilio di Orange nel 529 539 e nel Concilio di Trento nel 1546. 540
Un duro combattimento
407 La dottrina sul peccato originale – connessa strettamente con quella della redenzione operata da Cristo – offre uno sguardo di lucido discernimento sulla situazione dell'uomo e del suo agire nel mondo. In conseguenza del peccato dei progenitori, il diavolo ha acquisito un certo dominio sull'uomo, benché questi rimanga libero. Il peccato originale comporta « la schiavitù sotto il dominio di colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo ». 541 Ignorare che l'uomo ha una natura ferita, incline al male, è causa di gravi errori nel campo dell'educazione, della politica, dell'azione sociale 542 e dei costumi.
408 Le conseguenze del peccato originale e di tutti i peccati personali degli uomini conferiscono al mondo nel suo insieme una condizione peccaminosa, che può essere definita con l'espressione di san Giovanni: « il peccato del mondo » (Gv 1,29). Con questa espressione viene anche significata l'influenza negativa esercitata sulle persone dalle situazioni comunitarie e dalle strutture sociali che sono frutto dei peccati degli uomini. 543
409 La drammatica condizione del mondo che « giace » tutto « sotto il potere del maligno » (1 Gv 5,19) 544 fa della vita dell'uomo una lotta:
« Tutta intera la storia umana è infatti pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre; lotta incominciata fin dall'origine del mondo, che durerà, come dice il Signore, fino all'ultimo giorno. Inserito in questa battaglia, l'uomo deve combattere senza soste per poter restare unito al bene, né può conseguire la sua interiore unità se non a prezzo di grandi fatiche, con l'aiuto della grazia di Dio ». 545
IV. «Tu non l'hai abbandonato in potere della morte»
410 Dopo la caduta, l'uomo non è stato abbandonato da Dio. Al contrario, Dio lo chiama, 546 e gli predice in modo misterioso che il male sarà vinto e che l'uomo sarà sollevato dalla caduta. 547 Questo passo della Genesi è stato chiamato « protovangelo », poiché è il primo annunzio del Messia redentore, di una lotta tra il serpente e la Donna e della vittoria finale di un discendente di lei.
411 La Tradizione cristiana vede in questo passo un annunzio del « nuovo Adamo », 548 che, con la sua obbedienza « fino alla morte di croce » (Fil 2,8), ripara sovrabbondantemente la disobbedienza di Adamo. 549 Inoltre, numerosi Padri e dottori della Chiesa vedono nella Donna annunziata nel « protovangelo » la Madre di Cristo, Maria, come « nuova Eva ». Ella è stata colei che, per prima e in una maniera unica, ha beneficiato della vittoria sul peccato riportata da Cristo: è stata preservata da ogni macchia di peccato originale 550 e, durante tutta la sua vita terrena, per una speciale grazia di Dio, non ha commesso alcun peccato. 51
412 Ma perché Dio non ha impedito al primo uomo di peccare? San Leone Magno risponde: «L'ineffabile grazia di Cristo ci ha dato beni migliori di quelli di cui l'invidia del demonio ci aveva privati ». 552 E san Tommaso d'Aquino: « Nulla si oppone al fatto che la natura umana sia stata destinata ad un fine più alto dopo il peccato. Dio permette, infatti, che ci siano i mali per trarre da essi un bene più grande. Da qui il detto di san Paolo: "Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia" (Rm 5,20). Perciò nella benedizione del cero pasquale si dice: "O felice colpa, che ha meritato un tale e così grande Redentore!" ». 553
Nota esegetica 9 IL demonio nel Vangelo di Marco
Abbiamo già riportato nella nota esegetica 8 alcune considerazioni circa la presenza del demonio nella realtà, ma riteniamo opportuno aggiungere in questa nota quanto scrive Bruno Maggioni, Il racconto di Marco, Cittadella, a riguardo dello scontro di Gesù con i suoi oppositori in merito a questo argomento.
«Prima di fare alcune osservazioni più precise attorno al dibattiti, che Gesù ha con i suoi oppositori a proposito delle cacciate dei demoni, è opportuno fermare l'attenzione sul significato generale della lotta contro Satana: lotta che appunto Gesù intende difendere dalla distorta interpretazione degli scribi Mc 3,22-ss. È dall'inizio del vangelo che Marco sottolinea che il Figlio di Dio prende parte alla lotta che agita il mondo.
Mediante i racconti della liberazione degli ossessi, l'evangelo ci comunica una visione della storia, quella che si svolge in profondità: una lotta fra il bene e il male, i cui protagonisti non sono le forze della natura, e neppure, semplicemente, gli uomini, ma Dio e il Maligno. Questa opposizione fra Dio e il suo avversario si manifesta a tre livelli: il contrasto fra Gesù e i suoi oppositori, fra Gesù e gli indemoniati, fra lo Spirito di Dio e Satana. Dobbiamo dire che Marco semplifica (e forse volutamente), quando sembra eliminare quella ambiguità che nella storia è sempre presente: il bene e il male non stanno di qua o di là, divisi a settori, ma si combattono all'interno di ciascun uomo e di ciascuna istituzione. Il contrasto è radicale, ed è un contrasto che passa attraverso ogni cosa. Localizzare il be
Precisiamo ulteriormente: secondo Marco il contrasto non è solo fra Dio e Satana, ma è, tutto sommato, un contrasto sull'uomo. Non è solo in gioco la gloria di Dio, ma prima ancora l'uomo, la sua consistenza e la sua libertà.
La presenza di Satana distrugge: è lo spirito della confusione, della alienazione, della disgregazione.
La presenza di Cristo è la pace. Una storia, dunque, nella quale l'uomo si dibatte fra la salvezza e la alienazione.
Ma il dibattito non afferma soltanto che Gesù è in lotta con Satana (e non invece un suo alleato) perché nell'affermazione di Gesù c'è una convinzione: con la sua venuta la vittoria sul male è un fatto assicurato.
Le liberazioni dal demonio non sono sconfitte parziali, ma il segno di una sconfitta totale che già si anticipa. È una affermazione unica, inaudita per i giudei: « il giudaismo contemporaneo non offre analogia alcuna a queste affermazioni; né la sinagoga né Qumran parlano di una vittoria su Satana che si attua già nel presente storico ».
Possiamo andare oltre e osservare che Gesù vince il Maligno con la potenza dell'obbedienza e dell'amore: la potenza di Dio si fa presente nella disponibilità di colui che accettò, al battesimo, di essere il Servo che si assume il peso del male. Quest'amore disinteressato di Cristo, rivolto a Dio e agli uomini a lui affidati, smaschera e vince lo spirito dell''egoismo e gli strappa il mondo di cui abusa.
Nota esegetica 10
Il capitolo 1 di Genesi che noi stiamo esaminando è di tradizione sacerdotale P (dal tedesco Priester), una storiografia della quale abbiamo trattato in Glosse alla nota esegetica 2. È una tradizione molto legata al culto, alla liturgia, al sacerdozio, al tempio e alla successione dei tempi liturgici.
Uno dei fondamenti di questa tradizione è l'idea di separazione. Alla radice sta la separazione tra sacro e profano e questo ci porterebbe ad affrontare il tema dal punto di vista antropologico. Ma noi vogliamo restare per quanto possibile sul testo biblico.
Abbiamo già detto che il genere letterario di Genesi è quello dell'eziologia metastorica e questo vuol dire che vengono proiettate all'origine, quindi nel momento della creazione, le realtà che l'agiografo, il sapiente, il redattore vedono accadere nel loro mondo e cercano di dare loro una spiegazione che le giustifichi.
Allora è sensata la nostra domanda: dove ha inizio questo processo "storico" di separazione?
Se, come abbiamo affermato nella nostra riflessione sul libro di Esodo, esso è il primo libro della Bibbia, è lì che possiamo trovare qualche risposta.
Già all'inizio del racconto quando Mosè, fuggito dall'Egitto dove era stato allevato come principe dalla figlia di Faraone e, dopo la fuga, diventato pastore alle pendici del monte Sinai, vede il roveto che brucia senza consumarsi si avvicina per vedere cosa succede, si sente rivolgere da Dio queste parole:
Es 3,5 «Riprese: «Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa / sacra!» [l'ebraico non distingue sacro da santo].
Più avanti quando il popolo fuggito dalla terra di schiavitù si ritrova ai piedi del Sinai in attesa che Mosè riceva da Dio le tavole della Legge, troviamo questa ingiunzione:
Es19,12 «Fisserai per il popolo un limite tutto attorno, dicendo: Guardatevi dal salire sul monte e dal toccare le falde. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. 13 Nessuna mano però dovrà toccare costui: dovrà essere lapidato o colpito con tiro di arco. Animale o uomo non dovrà sopravvivere».
Se nel caso precedente l'accostamento al sacro richiedeva delle disposizioni di riguardo, togliere i sandali, in questo secondo caso il popolo deve stare lontano, assolutamente "separato" da quel luogo. Ma in realtà ciò che è separato è il luogo di Dio, mentre quello in cui si trova il popolo e "profano".
Sarà proprio sul Sinai che Mosè riceverà tutte le leggi che riguardano la vita di Israele anche quando il popolo sarà entrato in possesso della Terra Promessa. In realtà sappiamo che molte di quelle leggi sono nate e maturate, non nell'ambito di quel gruppo di ex schiavi fuggiti dall'Egitto che vagavano nel deserto, ma all'interno di un popolo maturo provvisto già delle sue istituzioni politiche e religiose ben consolidate. Tuttavia le leggi importanti vennero riportate al Sinai e poste sotto l'autorità di Mosè che le avrebbe ricevute da Dio. In realtà l'esegesi ritiene che solo il Decalogo e poche altre prescrizioni siano state ricevuto su quel monte.
Ora, già qui al Sinai troviamo che Aronne svolge la funzione di sacerdote, ma non Mosè che essendo suo fratello era anch'egli discendente di Levi. Questo dice che tra i discendete di Levi solo gli aronniti possono diventare sacerdoti e anche questa è una separazione legata al culto.
All'interno dei capitoli Es 25-28, che prescrivono come deve essere costruito il Santuario, si stabilisce chi possa diventare sacerdote:
Es 28,1 «Tu fa' avvicinare a te tra gli Israeliti, Aronne tuo fratello e i suoi figli con lui, perché siano miei sacerdoti; Aronne e Nadab, Abiu, Eleazaro, Itamar, figli di Aronne. 2 Farai per Aronne, tuo fratello, abiti sacri, che esprimano gloria e maestà».
Però, subito dopo l'episodio del Vitello d'oro, alla costruzione del quale Aronne ha contribuito alla grande, egli sparisce letteralmente dalla narrazione successiva di Esodo; verosimilmente sono rimasti solo i suoi figli. E questa è un'altra separazione.
Sebbene la separazione ha originariamente un senso di elezione, mostra anche qualche aspetto negativo.
È proprio nel racconto del Vitello d'oro che troviamo una parte sconcertante operata esattamente dai figli di Levi, i leviti:
Es 28,25 «Mosè vide che il popolo non aveva più freno, perché Aronne gli aveva tolto ogni freno, così da farne il ludibrio dei loro avversari. 26 Mosè si pose alla porta dell'accampamento e disse: «Chi sta con il Signore, venga da me!». Gli si raccolsero intorno tutti i figli di Levi. 27 Gridò loro: «Dice il Signore, il Dio d'Israele: Ciascuno di voi tenga la spada al fianco. Passate e ripassate nell'accampamento da una porta all'altra: uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio parente».
28 I figli di Levi agirono secondo il comando di Mosè e in quel giorno perirono circa tremila uomini del popolo. 29 Allora Mosè disse: «Ricevete oggi l'investitura dal Signore; ciascuno di voi è stato contro suo figlio e contro suo fratello, perché oggi Egli vi accordasse una benedizione».
E ci chiediamo, ma i leviti non avevano contribuito a costruire il Vitello d'oro? Era proprio necessario un simile massacro? E come premio ricevono l'investitura al sacerdozio. È chiaro che il racconto è cristologicamente incompatibile, vedi in Glosse, Nota esegetica 5, nonché un commento più esaustivo svolto nella Lettura 52 di Esodo.
Qui ci interessa solo mettere in evidenza che la separazione non è indolore, non è acqua fresca, richiede lotte e sacrifici molto pesanti. Ricordiamo che quando la Terra promessa viene divisa /separata tra le tribù, a quella di Levi non viene assegnato alcun territorio perché essi vivranno solo delle decime versate dalle altre tribù. Una separazione, ma altresì elezione.
Al tempo della successione al trono di Davide abbiamo un'altra separazione. Anzitutto Davide aveva unificato il culto esclusivamente a Gerusalemme, politica proseguita da Salomone dopo la costruzione del Tempio, in questo modo vengono eliminati tutti i santuari sparsi per il paese: Betel, Bersabea, Sichem, ecc., per cui molti sacerdoti non leviti non poterono più svolgere la loro funzione, altra separazione - elezione, ma il fatto interessante è che all'interno del sacerdozio di Gerusalemme si svolge una lotta tra Abiatar, sacerdote durante il regno di Davide e Sadoc o Zadoc, che alla fine risultò vincitore perché appoggiato dal nuovo re, Salomone. Da questo momento e siamo intorno al 900 a. C., i sacerdoti saranno esclusivamente discendenti di Sadoc che più tardi daranno vita al gruppo dei Sadducei. Quindi un ulteriore separazione all'interno dei leviti.
Tuttavia il processo di separazione non riguarda solo la classe sacerdotale, ma lo stesso popolo che appunto diventa il "popolo eletto".
Lv 20,22 «Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e le metterete in pratica, perché il paese dove io vi conduco ad abitare non vi rigetti. 23 Non seguirete le usanze delle nazioni che io sto per scacciare dinanzi a voi; esse hanno fatto tutte quelle cose, perciò le ho in abominio 24 e vi ho detto: Voi possiederete il loro paese; ve lo darò in proprietà; è un paese dove scorre il latte e il miele. Io il Signore vostro Dio vi ho separati dagli altri popoli».
Terribile! Gli ebrei popolo eletto, separato dagli altri popoli che Dio avrebbe in abominio!
La separazione non riguarda solo il popolo rispetto ai gentili, i gojm, ma altresì il cibo:
Lv 20,25 «Farete dunque distinzione tra animali mondi e immondi, fra uccelli immondi e mondi e non vi renderete abominevoli, mangiando animali, uccelli o esseri che strisciano sulla terra e che io vi ho fatto distinguere come immondi. 26 Sarete santi per me, poiché io, il Signore, sono santo e vi ho separati dagli altri popoli, perché siate miei».
27 Se uomo o donna, in mezzo a voi, eserciteranno la negromanzia o la divinazione, dovranno essere messi a morte; saranno lapidati e il loro sangue ricadrà su di essi».
In questo caso la separazione è anche elezione perché il popolo è divenuto proprietà di Dio stesso, come abbiamo visto nella Lettura 44 del libro di esodo.
Es 19, 5 «Ora, se ascoltare ascoltate (shemah) la mia voce e osservate (shamar) la mia Alleanza allora sarete la mia segullah/ eredità/ proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra!».
Essere proprietà di Dio o sua eredità significa godere di una particolare benedizione da parte Sua.
Il principio della separazione dagli altri popoli diventa il motivo per cui verso le città conquistate viene praticato lo herem / sterminio di ogni essere vivente. Ne abbiamo trattato nel Libretto di Elia, Lettura 6. È esemplare quanto succede durante la conquista di Gerico, la prima città al di qua del Giordano.
Ricordiamo che le possenti mura di Gerico, crollano rovinosamente il settimo giorno dopo che nei precedenti sei i sacerdoti avevano fatto, ogni giorno, il giro della mura suonando le trombe.
Gs 6,16 «Alla settima volta i sacerdoti diedero fiato alle trombe e Giosuè disse al popolo: «Lanciate il grido di guerra perché il Signore mette in vostro potere la città.
17 La città con quanto vi è in essa sarà votata allo sterminio per il Signore; soltanto Raab, la prostituta, vivrà e chiunque è con lei nella casa, perché ha nascosto i messaggeri che noi avevamo inviati. 18 Solo guardatevi da ciò che è votato allo sterminio, perché, mentre eseguite la distruzione, non prendiate qualche cosa di ciò che è votato allo sterminio e rendiate così votato allo sterminio l'accampamento di Israele e gli portiate disgrazia. 19 Tutto l'argento, l'oro e gli oggetti di rame e di ferro sono cosa sacra per il Signore, devono entrare nel tesoro del Signore». 20 Allora il popolo lanciò il grido di guerra e si suonarono le trombe. Come il popolo udì il suono della tromba ed ebbe lanciato un grande grido di guerra, le mura della città crollarono; il popolo allora salì verso la città, ciascuno diritto davanti a sé, e occuparono la città. 21 Votarono poi allo sterminio, passando a fil di spada, ogni essere che era nella città, dall'uomo alla donna, dal giovane al vecchio, e perfino il bue, l'ariete e l'asino».
Dal punto di vista archeologico sappiamo che le mura di Gerico erano cadute almeno un paio di millenni prima dell'arrivo degli ebrei, per cui il genere di questo racconto e didattico o se si vuole un'altra eziologia metastorica.
Questa breve incursione tra le sacre pagine dovrebbe riuscire a mostrare quanto sia seria e gravida di conseguenza l'idea di separazione.
Ovviamente si possono trovare moltissime altre pagine di questo tenore, ma riteniamo che questo "assaggio" sia sufficiente per sostenere che tale separazione - elezione ha senso finché si è in contesto enoteistico: ogni popolo ha il suo Dio, ma non regge più quando si passa al monoteismo ad un unico Dio Creatore: un solo Dio per tutti gli uomini.
Tuttavia già nell'Antico Testamento troviamo racconti che vanno in tutt'altra direzione; la separazione si attenua o sparisce.
Il libro di Ruth è sostanzialmente un elogio di Ruth la moabita, cioè una "straniera", una "gojm" di Moab che rimasta vedova di un giovane di Betlemme (casa del pane) emigrato nel paese di Moab, decide di tornare con la suocera a Betlemme perché la carestia a Betlemme era finita. Ruth sposerà un betlemita, Booz che sarà il bisnonno del grande re Davide. Allora nelle vene di Davide scorreva anche sangue moabita: quello della sua bisnonna.
Non da meno il libro di Giona (commento reperibile in archivio) che esalta la decisione di conversione presa dai niniviti, uno dei popoli più feroci dell'antico vicino oriente, a seguito della predicazione del profeta Giona colà inviato da Dio.
Se il bisnonno di Davide ha sposato una donna straniera vuol dire che questa idea di separazione non fosse così seguita dal popolo, tuttavia non possiamo dimenticare i capitoli 9-10 di Esdra. In essi si racconta dei deportati ritornati dall'esilio babilonese a Gerusalemme con le famiglie che si erano formate in terra straniera. Ad un certo punto si rendono conto di non avere rispettato la legge che prescrive di non unirsi a donne straniere e pentiti del peccato commesso rimandano mogli e figli. Chi non l'avesse fatto entro tre giorni sarebbe stato condannato allo sterminio (Esd 10,8).
Quindi, sembra di poter dire che la "separazione" così sostenuta dall'ambiente sacerdotale non fosse altrettanto condivisa dal popolo nel suo insieme. In altre parole: questa prescrizione, che gli studiosi ritengono alquanto tardiva, non fosse tanto osservata dal popolo.
Però dobbiamo affrontare l'argomento anche nel suo approdo neotestamentario, cioè: cosa trova Gesù quando giunge tra la sua gente?
Nella Lettura 38 del Vangelo di Marco abbiamo trattato l'episodio dell'emorroissa. Questa donna da dodici anni perdeva sangue dalle emorroidi. Una persona che perde sangue è impura; tutto quello che tocca diventa impuro e se qualcuno la tocca diventa impuro. Esattamente come ogni donna che durante il mestruo è impura. A questa donna fin da bambina avevano detto che durante "le sue cose" sarebbe stata impura e se avesse toccato qualcuno lo avrebbe reso impuro... e sarebbe andata dritta dritta all'inferno. Essa dopo dodici anni di isolamento "separazione", matura l'idea che Dio non può essere l'origine di questa segregazione e, chissà con quale timore osa toccare il mantello dell'uomo di Dio.
Sappiamo come è finito l'episodio. Gesù le dice: «La tua fede ti ha salvata». Gesù afferma clamorosamente in mezzo alla folla, che lo premeva da tutti le parti, che Dio, l'Abbà, non vuole una tale separazione.
Separato era anche il cieco di Gv 9 che stava presso la porta del tempio a chiedere l'elemosina. "Separato" perché peccatore. Ché se non ha peccato lui hanno peccato i suoi genitori. E in sovrappiù maledetto perché i suoi occhi non gli consentono di leggere la Parola di Dio.
Conosciamo anche in questo caso l'esito del racconto. Il cieco guarito viene ignorato dai genitori che non prendono posizione a sua difesa. Cacciato dalla sinagoga perché:
Gv 9,34 «Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?». E lo cacciarono fuori».
Anche se non più cieco rimane peccatore e comunque sempre separato. Ma sarà Gesù ad andare a cercarlo per inserirlo in una nuova comunità.
Molte sono le figure della separazione presenti nei vangeli e non possiamo passarle tutte in rassegna.
Per sommi capi c'erano dentro: lebbrosi, prostitute, adultere (se non venivano lapidate), posseduti da spiriti impuri, sordi, ciechi, muti, malati di ogni tipo, perché la malattia era sempre originata da qualche colpa.
L'idea di separazione finisce per creare una mentalità che produce orgoglio in quelli che si sentono "separati / santi / eletti e contro tutti gli altri, che devono essere esclusi. Forse riusciamo a comprenderlo dalla parabola del fariseo e del pubblicano che Gesù racconta per denunciare questa situazione.
Lc 18,9 «Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di esser giusti e disprezzavano gli altri: 10 «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. 11 Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. 12 Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo. 13 Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me peccatore. 14 Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato».
Il fariseo ha l'idea chiara e distinta per potersi salvare. Sa esattamente tutto quello che si deve fare e quello che non si deve fare. Egli ha trasformato l'immagine di Dio Abbà in quella di un ragioniere occhiuto che sul Libro Mastro segna tutto il dare e l'avere; Dio trasformato in un mercante che, con il bilancino in mano, registra tutte le entrate e le uscite. Ed è sicuro come l'oro che l'inventario è decisamente a suo favore. Egli non ha bisogno di Dio. Gli basta la sua dirittura morale! Egli è un eletto.
Quell'altro invece sa di presentarsi a Dio con le mani vuote. È un escluso... e sa che deve restare ai margini.
Poi, forse entrambi, sanno quello che dice il profeta: «Quanto i cieli sono altri sopra la terra / altrettanto il Miei pensieri sono diversi dai vostri»... ma queste sono solo belle frasi poetiche... la realtà è altro...
La finale della parabola dice esattamente qual è il pensiero di Gesù che letteralmente capovolge la situazione.
Pensiamo sia il caso di esaminare un po' nel dettaglio la parabola del buona samaritano.
Lc 10,30 «Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31 Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. 32 Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. 33 Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione. 34 Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. 35 Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. 36 Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?».
La strada da Gerusalemme a Gerico in realtà è un sentiero di montagna molto impervio perché deve superare un dislivello di 1000 - 1200 metri.
Ci interessa la reazione del sacerdote e del levita che tirano dritto. Se si fossero fermati a dare soccorso a "un uomo" che perdeva sangue avrebbero contratto l'impurità legale e pertanto non avrebbero potuto svolgere le loro funzioni nel Tempio. Se è così dovevano rimanere puri, separati.
Però il sacerdote "scendeva", quindi non doveva svolgere il suo servizio, e comunque sarebbe diventato impuro; avrebbe dovuto fare le pratiche per ripristinare la purità lasciando trascorre i giorni prescritti. Tutto sommato, una bella rogna. Meglio tirare dritto.
Il levita non si sa se salisse a Gerusalemme o tornasse. Se ci stava andando non avrebbe potuto svolgere il suo compito, se, invece, tornava, tutto come nel caso del sacerdote.
Una cosa è certa: entrambi vogliono rimanere separati da quel malcapitato per non contrarre impurità legale.
E siamo tornati alla grande al tema della separazione.
Il samaritano, poco osservante della legge, non si pone un problema di purità e soccorre "un uomo".
Allora la domanda è: Gesù ce l'ha con le persone o con la Legge che riduce le persone a non essere "prossimo"?
Tentiamo con una risposta molto sintetica.
Sul Sinai è stata stabilita l'Alleanza che ha fatto di Israele il popolo eletto.
Sul Calvario è nata la "Nuova Alleanza" che è per tutti i popoli e per ogni uomo.
* NOTA ESEGETICA 11 Le guerre di JHWH
Non è necessario cercare molte documentazioni per sostenere che la guerra è purtroppo una realtà connaturata nell'essere umano già all'emergere delle prime società umane. Le tombe che gli archeologi e paleontologi hanno trovato, anche quelle più antiche mostrano tra gli arredi che accompagnavano i defunti la presenza di armi, come punte di freccia in pietra o pugnali dello stesso materiale, il che mostra che già l'uomo delle caverne usava questi strumenti... e non solo per la caccia.
Le stesse grandi "civiltà" del passato si manifesta con la nascita di piccole comunità che via via si ingrandiscono diventando grandi imperi: Sumeri, Babilonesi, Egiziani, Assiri, Cinesi, ecc. che lasciano le loro tracce storiche attraverso famosi monumenti che sono il più delle volte monumenti memoriali di grandi battaglie con migliaia di morti ogni volta: «la guerra si rivela come una realtà permanente di questo mondo e come un male» (Leon Dufour).
La stessa Bibbia narra, sin dai primi capitoli, la prima guerra. È la storia di Caino e Abele, che ricordiamo è una "eziologia metastorica" cioè spiegazione e risposta alla domanda di sempre: perché la guerra? Che secondo la cultura epocale diventa: "perché fin dalle origini gli uomini hanno fatto la guerra". E per giunta questi erano due fratelli, il che significa che neanche i rapporti familiari impediscono quella triste attività.
E dobbiamo dire che già il primo evento "bellico" coinvolge Dio. Infatti Caino uccide Abele perché ha ritenuto che il sacrificio del fratello fosse più gradito del suo.
Questo coinvolgimento di Dio non riguarda solo Israele perché tutto l'Antico Vicino Oriente è animato da questa comprensione : guerre degli uomini che diventano guerre degli dèi, ma anche il contrario: guerre tra dèi che si ripercuotono in terra diventando guerre tra uomini. Una per tutte molto nota è la guerra di Troia, il cui motivo scatenante è un bisticcio tra due dee: un litigio tra Venere e Minerva che coinvolge il povero Paride incaricato di scegliere quale delle due fosse la più bella a cui segue una guerra tra gli dei dell'Olimpo nella quale sono trascinati i rispettivi fedeli. Ma non basta! Nella seconda metà dell'ottocento H. Schliemann scoprì le rovine dell'antica città di Troia, ma gli archeologi posteriori costatarono che la città scoperta in superficie aveva sotto di sé altri otto strati, il primo datato al 3000 a. C. il nono alla fine dell'impero romano. Quell'antica città aveva perciò subito ben nove distruzioni. Possiamo ancora parlare di civiltà?
Per tornare al libro sacro, subito in Genesi 14, si narra che Abramo appena arrivato in Canaan si trova coinvolto in una guerra di quattro re locali contro altri cinque e si troverà costretto ad intervenire per liberare il nipote Lot, rapito con tutta la sua gente (Lettura 58 di Genesi vedi archivio). In questo caso sembra che Dio non fosse coinvolto.
Ma, lasciata la protostoria ed entrati nella storia cioè in Esodo troviamo subito una guerra che coinvolge JHWH.
Si tratta della guerra con Amalek che vuole vietare ad Israele di raggiungere la Terra della Promessa impedendogli di transitare nei pressi del suo territorio.
Abbiamo trattato diffusamente questo argomento nelle letture 38 e 39 di Esodo (vedi archivio).
Es.17,8 «Allora Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. 9 Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio». 10 Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aronne, e Cur salirono sulla cima del colle. 11 Quando Mosè alzava le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava cadere, era più forte Amalek. 12 Poiché Mosè sentiva pesare le mani dalla stanchezza, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. 13 Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo passandoli poi a fil di spada. 14 Allora il Signore disse a Mosè: «Scrivi questo per ricordo nel libro e mettilo negli orecchi di Giosuè: io cancellerò del tutto la memoria di Amalek sotto il cielo!».
(Abbiamo spiegato dettagliatamente il significato delle mani alzate in atteggiamento di preghiera nella citata lettura 38)
Questi ex schiavi hanno appena superato la seconda prova della sete e contemporaneamente hanno sperimentato che Dio ha accettato di essere messo alla prova - tentato - nasah, che si presenta un'altra sfida.
Il testo originale scrive letteralmente: Es 17,8 «E venne Amalek a combattere contro Israele a Refidim» quasi che con Amalek sia già avvenuto qualcosa di cui il lettore sia a conoscenza.
Refidim, non è mai stato localizzato: il deserto non offre molte strutture che possano essere identificate: è un luogo dove non c'è niente.
Il testo ci presenta due scene: una nella valle, l'altra sul monte.
La prima riguarda lo scontro tra due eserciti, che dobbiamo verosimilmente pensare storicamente come una battaglia tra due bande armate alla meglio e senza una struttura gerarchica definita, perché è gente appena fuggita dalla schiavitù e non può avere alcuna esperienza militare. Per usare una battuta delle nostre: una guerra fatta con i forconi e le fionde. Notare che Giosuè va in battaglia solo con «alcuni uomini».
La seconda scena è sulla cima di un colle: "Mosè tende la mani verso l'alto".
Queste amni alzate verso l'alto è lo stile di preghiera tipico degli ebrei che stendono le mani verso l'alto volgendosi verso Gerusalemme e il Tempio i luoghi sacri per eccellenza. Allo stesso modo, i musulmani quando pregano si rivolgono verso un luogo: la Mecca.
I cristiani non si rivolgono verso alcuna parte perché sanno che il Signore Gesù e lo Spirito sono lì presso di loro, vale a dire i cristianesimo non ha un baricentro di riferimento verso cui rivolgersi durante la preghiera.
Infatti nel Vangelo troviamo questo passo:
Mt 6,6 «Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà».
Allora il luogo della preghiera del cristiano è quello in cui vive, cioè qualunque luogo, ovvero il mondo intero.
Ritornando ad Amalek, notiamo che man mano che il racconto prosegue la prima scena diviene sempre più sfumata fin quasi a sparire, mentre giganteggia la figura di Mosè con quelle mani alzate, tenute in alto da due aiutanti perché lui non ce la faceva più.
E restano così per tutto il giorno fino al tramonto del sole e la sconfitta di Amalek.
Da sottolineare: non c'è vittoria senza esercito e nemmeno senza quelle mani alzate. Però è un esercito che indietreggia quando le mani non sono alzate.
In questa guerra Dio non è neutrale, ma è coinvolto in pieno durante tutto il tempo dello scontro fino alla vittoria finale.
Allora possiamo dire che è la prima "Guerra di JHWH" che la Bibbia riporta.
In verità dovremmo ricordare anche le piaghe d'Egitto e l'attraversamento del Mar Rosso, ma non si è trattato di guerre vere e proprie. Ad ogni modo là il nemico, che andava contro il piano di Dio era faraone, ora è Amalek.
Però qui il coinvolgimento di JHWH è più che evidente; e oltretutto c'è una Sua promessa terribile: io cancellerò del tutto la memoria di Amalek sotto il cielo!».
In questo brano appare nitida la figura del Male rappresentato da Amalek contro il quale Dio opera costantemente senza tregua lunga tutta la storia.
Ma il Deuteronomio è ancor più duro:
Dt 25,17 «Ricordati di ciò che ti ha fatto Amalek lungo il cammino quando uscivate dall'Egitto: 18 come ti assalì lungo il cammino e aggredì nella tua carovana tutti i più deboli della retroguardia, mentre tu eri stanco e sfinito, e non ebbe alcun timor di Dio. 19 Quando dunque JHWH tuo Dio ti avrà assicurato tranquillità, liberandoti da tutti i tuoi nemici all'intorno nel paese che JHWH tuo Dio sta per darti in eredità, cancellerai la memoria di Amalek sotto al cielo: non dimenticare»!
In definiva l'impegno di JHWH consiste nel cancellare la memoria di Amalek, ma è anche un imperativo di Israele, che sarà per sempre impegnato a ricordare ciò che Amalek gli ha fatto.
Amalek qui è rappresentato come figura del Male Assoluto, allora bisogna esplorare chi è o cosa è Amalek.
Qui è necessario esplorare da dove proviene Amalek. Ciò che sorprende è che tra Amalek ed Israele esisteva una certa parentela perché all'origine stanno i due figli di Isacco: Esaù e Giacobbe.
A suo tempo Esaù aveva disubbidito alle tradizioni di famiglia sposando due donne al di fuori della gente di Carran. Egli non è andato in Mesopotamia a cercarsi moglie come, poi, farà Giacobbe, ma aveva sposato due donne Ittite, come recita:
« Gn 34,34 Quando Esaù ebbe quarant'anni, prese in moglie Giudit, figlia di Beeri l'Hittita, e Basemat, figlia di Elon l'Hittita. 35 Esse furono causa d'intima amarezza per Isacco e per Rebecca».
Forse l'amarezza di Rebecca è una concausa che le avrebbe suggerito di spingere Giacobbe ad imbrogliare Isacco è ottenere la benedizione e il diritto di primogenitura con tutta l'eredità, sottraendola ad Esaù.
Ad ogni modo la generazione di Amalek segue questo percorso:
Gen 36,9 «Questa è la discendenza di Esaù, padre degli Idumei, nelle montagne di Seir. 10 Questi sono i nomi dei figli di Esaù: Elifaz, figlio di Ada, moglie di Esaù; Reuel, figlio di Basemat, moglie di Esaù. 11 I figli di Elifaz furono: Teman, Omar, Zefo, Gatam, Kenaz. 12 Elifaz, figlio di Esaù, aveva per concubina Timna, la quale ad Elifaz partorì Amalek. Questi sono i figli di Ada, moglie di Esaù. 13 Questi sono i figli di Reuel: Naat e Zerach, Samma e Mizza. Questi furono i figli di Basemat, moglie di Esaù. 14 Questi furono i figli di Oolibama, moglie di Esaù, figlia di Ana, figlio di Zibeon; essa partorì a Esaù Ieus, Iaalam e Core».
Per farla breve: Esaù sposa una donna ittita Ada, che gli partorisce Elifaz. Questi, a suo tempo, da una concubina avrà come figlio Amalek che darà nome al popolo che assale Israele appena fuggito dall'Egitto. Quindi Amalek, se così si può dire, porta uno stigma: discende da una donna ittita ed è figlio di una concubina.
17,8 «Allora Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. [...] 13Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo passandoli poi a fil di spada. 14Allora JHWH disse a Mosè: «Scrivi questo per ricordo nel libro e mettilo negli orecchi di Giosuè: io cancellerò del tutto la memoria di Amalek sotto il cielo!».
Dobbiamo riflettere sul versetto conclusivo di questo brano e cercare di capire chi sia o cosa rappresenta Amalek.
Abbiamo già avuto l'occasione di dire che la Bibbia non è il resoconto cronachistico del succedersi degli eventi, ma è piuttosto la sedimentazione dell'esperienza di Dio che migliaia di generazioni hanno fatto e che ci sono state tramandate. Dapprima tradizioni orali poi scritte e più volte riviste: la parte più rilevante della redazione finale avviene nel post-esilio. Quindi per comprendere pienamente Es 17,8-16 dobbiamo considerare il tema degli amaleciti o amalekiti nella sua unità e complessità. Quello che si dice di questo popolo non è quello che pensassero Mosè o Giosuè, ma è piuttosto quello che dicevano ai tempi del post esilio quando la Bibbia prende la struttura che oggi conosciamo. Di Amalek si ricordano tutti gli i racconti negativi che sono pervenuti ai nostri redattori e che riportiamo in ordine cronologico.
La Bibbia non riporta notizie di guerre con Amalek durante il periodo dell'insediamento o quello dei Giudici, ma ne troviamo uno subito all'inizio della Monarchia, quando ancora la sua struttura politica era alquanto fragile.
SAUL CONTRO AMALEK 1 Sam 15
Unto re da poco tempo, e per certi versi ancora sotto la guida del profeta Samuele, Saul si vede costretto ad uno scontro con Amalek avvenuto intorno al 1000 a.C. quando il primo re, Saul, era riuscito ad affrontare Amalek in una imboscata.
Qui Saul compie il primo peccato che lo porterà alla perdita del trono.
1Sam 15:1 «Samuele disse a Saul:2 Così dice JHWH degli eserciti: Ho considerato ciò che ha fatto Amalek a Israele, ciò che gli ha fatto per via, quando usciva dall'Egitto. 3 Va' dunque e colpisci Amalek e vota allo sterminio quanto gli appartiene, non lasciarti prendere da compassione per lui, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini».[...] 5 Saul venne alla città di Amalek e tese un'imboscata nella valle. 6 Disse inoltre Saul ai Keniti (o Madianiti): «Andate via, ritiratevi dagli Amaleciti prima che vi travolga insieme con loro, poiché avete usato benevolenza con tutti gli Israeliti, quando uscivano dall'Egitto». I Keniti (o Madianiti) si ritirarono da Amalek.7 Saul colpì Amalek da Avila procedendo verso Sur, che è di fronte all'Egitto.
8 Egli prese vivo Agag, re di Amalek, e passò a fil di spada tutto il popolo. [...] 9Ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio del bestiame minuto e grosso, gli animali grassi e gli agnelli, cioè tutto il meglio, e non vollero sterminarli; invece votarono allo sterminio tutto il bestiame scadente e patito».
Non possiamo riportare integralmente il brano, che però consigliamo di leggere, ma ci preme sottolineare la ragione della spedizione: in questo caso l'azione di Saul non era stata la risposta ad una razzia, come poi accadrà a Davide, ma si è trattato di una "guerra santa di sterminio (herem)" dichiarata da Dio per quello che Amalek aveva fatto agli schiavi in fuga dall'Egitto, che è quanto riporta il brano di Es 17, cha abbiamo esaminato sopra.
È importante rilevare il nome del re amalecita: "Agag" perché sarà richiamato più avanti nel libro di Ester.
Esamineremo il tema dello sterminio / herem nel corso della lettura del Deuteronomio perché qui è figura di punizione per quanto Amalek aveva fatto agli schiavi in fuga, mentre il suo significato è teologicamente più profondo.
Evidenziamo che lo sterminio di Amalek è richiesto da Dio tramite il profeta Samuele, allora si tratta a tutti gli effetti di una guerra di JHWH.
DAVIDE CONTRO AMALEK 1Sam 30
Anche Davide si trova a dover combattere contro Amalek. In questo racconto, che non possiamo riportare perché molto lungo, (e a maggior ragione suggeriamo di leggerlo) si narra che Amalek fece una delle tante razzie in una città meridionale di Giuda, Ziklag, e la distrusse appiccandole il fuoco, portando via donne e bambini con un ingente bottino..
In quel tempo Davide era prossimo a diventare re; Israele era già un regno che si era imposto sottomettendo alcuni popoli vicini, ma con gli amaleciti c'era stato poco da fare perché non si scontravano mai in campo aperto ma, appunto, compiuta la razzia, sparivano. Nel deserto, poi, era difficile rintracciarli.
1 Sam30, 3 «Tornò dunque Davide e gli uomini che erano con lui ed ecco la città era in preda alle fiamme; le loro donne, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via [Da Amalek]. 4 Davide e la sua gente alzarono la voce e piansero finché ne ebbero forza. 5 Le due mogli di Davide, Achinoàm di Izrèel e Abigail, già moglie di Nabal da Carmel, erano state condotte via. 6 Davide fu in grande angoscia perché tutta quella gente parlava di lapidarlo. Tutti avevano l'animo esasperato, ciascuno per i suoi figli e le sue figlie. Ma Davide ritrovò forza e coraggio in JHWH suo Dio. 7 Allora Davide disse al sacerdote Ebiatar figlio di Achimelech: «Portami l'efod». Ebiatar accostò l'efod a Davide. 8 Davide consultò JHWH e chiese: «Devo inseguire questa banda? La raggiungerò?». Gli rispose: «Inseguila, la raggiungerai e libererai i prigionieri». 9 Davide e i seicento uomini che erano con lui partirono e giunsero al torrente di Besor, dove quelli rimasti indietro si fermarono. 10 Davide continuò l'inseguimento con quattrocento uomini: si fermarono invece duecento uomini che erano troppo affaticati per passare il torrente di Besor».
In questo caso Davide sarà fortunato dato che un egiziano schiavo di Amalek, abbandonato perché in fin di vita, lo guida al campo degli amaleciti. Si realizza così quanto Dio aveva detto.
Così Davide è in grado di ricuperare bottino, uomini, bambini e donne tra cui due delle sue mogli che erano state rapite.
Anche in questo caso nella guerra di Davide con Amalek c'è di mezzo la consultazione di Dio è il suo presagio circa l'esito vittorioso della guerra. Allora possiamo dire che anche questa è "Guerra di JHWH. D'altra parte Dio non fa altro che essere coerente con quanto aveva decretato in Es. 17.
Nel nostro percorso tralasciamo i libri dei Profeti per non allungare troppo la nostra indagine e veniamo ad un libro alquanto recente, quello di Ester che è tutto intrecciato tra questa bellissima donna e un discendente di Amalek.
ESTER CONTRO AMALEK
Tentiamo un breve riassunto del libro di Ester, ma, al solito, è più che consigliabile leggerlo.
Nel libro di Ester composto nel II° secolo a. C. ma ambientato al tempo del primo post-esilio a Susa capitale della Persia, sotto il re Serse, Assuero per la Bibbia, troviamo un personaggio Amàn, figlio di Hammedàta l'Agaghita, cioè discendente di Agag, il re contro cui aveva combattuto Saul, quindi un amalecita, che era diventato primo ministro dell'Impero Persiano.
I persiani avevano costruito un impero esteso dall'India fino al Mediterraneo che comprendeva un grande numero di popoli. In questo enorme impero ogni popolo poteva continuare a coltivare le sue usanze, le sue leggi, la sua religione.
Gli ebrei, che lungo la storia avevano subito diverse vicissitudini e che in questo immenso territorio erano sparsi un po' dappertutto, potevano tranquillamente continuare a praticare i precetti della loro Legge. Uno di questi vietava di prostrarsi davanti ad un uomo perché l'unico davanti a cui inchinarsi è Dio.
Amàn si sente offeso da questa pratica e quando gli si presenta l'occasione propone al "Re dei Re", Assuero, di promulgare un editto che ordina di uccidere in un determinato giorno tutti gli ebrei che risiedono in tutto l'Impero, Giudea compresa.
La narrazione diventa drammatica, ma, purtroppo, non possiamo riportarla. Sarà Ester, una bellissima ragazza ebrea, che a suo tempo era stata condotta con violenza dentro lo harem di Assuero la quale, diventata regina, convincerà il re ad annullare quella legge. Metterà anche in evidenza la malvagità di Amàn che verrà impiccato. Ecco una parte del versetto della condanna di Amàn:
Est 8,12 [Parla Assuero imperatore di Persia] «Così è il caso di Amàn figlio di Hammedàta, il Macedone, il quale estraneo, per la verità, al sangue persiano e ben lontano dalla nostra bontà, accolto come ospite presso di noi, aveva tanto approfittato dell'amicizia che professiamo verso qualunque nazione, da essere proclamato nostro padre e da costituire la seconda personalità nel regno, venendo da tutti onorato con la prostrazione. Ma non reggendo al peso della sua superbia, egli si adoperò per privare noi del potere e della vita e con falsi e tortuosi argomenti richiese la pena di morte per il nostro salvatore e in ogni circostanza benefattore Mardocheo [che aveva fatto padre a Ester rimasta orfana], per l'irreprensibile consorte del nostro regno Ester e per tutto il loro popolo. Pensava infatti per questa via di sorprenderci nell'isolamento e di trasferire l'impero dei Persiani ai Macedoni».
Così il giorno previsto per la strage di tutti gli ebrei diventa giorno di una grande festa, chiamata di Purim, che dura due giorni e dagli ebrei è celebrata ancora oggi.
In questo versetto Amàn discendente di Amalek viene definito Macedone: la spiegazione la troviamo più sotto.
Nel libro di Ester, come nel racconto di Giuseppe (Gn 37 ss), Dio è presente solo sullo sfondo; non ci sono sacrifici, non ci sono profeti, non ci sono visioni, non ci sono rivelazioni, ma solo la pura fede nella certezza che Dio non abbandona i suoi fedeli. E alla fine si capisce come la tribolazione cui era stata sottoposta Ester all'inizio, faceva parte di un disegno più grande e imprevedibile.
Anche in questo caso così drammatico si può sostenere l'intervento di Dio che porta alla morte il discendente di Amalek e salva tutti gli ebrei.
Allora possiamo dire che anche questa è una "Guerra di JHWH", che annienta tutti gli amleciti.
I MACCABEI CONTRO ANTIOCO EPIFANE
Il libro di Ester è stato scritto quando a Gerusalemme regna Antioco Epifane, discendente da uno dei generali che alla morte di Alessandro Magno aveva ottenuta la parte dell'Impero Macedone comprendente la Siria e la Palestina all'incirca nel 300 a.C.
Ora, Antioco Epifane aveva impostato una dura politica di forzata ellenizzazione, in contrasto con le liberalità precedenti, descritta in 1Maccabei 1.
Quindi "il macedone" cui accenna il libro di Ester è Antioco Epifane per cui si pensa ad una continuità del MALE Assoluto che perseguita il popolo eletto si dalle sue origini..
1 Mac 1,41 «Poi il re prescrisse con decreto a tutto il suo regno, che tutti formassero un sol popolo 42 e ciascuno abbandonasse le proprie leggi. Tutti i popoli consentirono a fare secondo gli ordini del re. 43 Anche molti Israeliti accettarono di servirlo e sacrificarono agli idoli e profanarono il sabato. 44 Il re spedì ancora decreti per mezzo di messaggeri a Gerusalemme e alle città di Giuda, ordinando di seguire usanze straniere al loro paese, 45 di far cessare nel tempio gli olocausti, i sacrifici e le libazioni, di profanare i sabati e le feste 46 e di contaminare il santuario e i fedeli, 47 di innalzare altari, templi ed edicole e sacrificare carni suine e animali immondi, 48 di lasciare che i propri figli, non circoncisi, si contaminassero con ogni impurità e profanazione, 49 così da dimenticare la Legge e mutare ogni istituzione, 50 pena la morte a chiunque non avesse agito secondo gli ordini del re. 51 Secondo questi ordini scritti a tutto il regno, stabilì ispettori su tutto il popolo e intimò alle città di Giuda di sacrificare città per città. 52Anche molti del popolo si unirono a loro, tutti i traditori della Legge, e commisero il male nella regione 53 e ridussero Israele a nascondersi in ogni possibile rifugio.
54 Nell'anno centoquarantacinque (167 a. C.), il quindici di Casleu il re innalzò l'abominio della desolazione [un idolo sull'altare del tempio]. Anche nelle città vicine di Giuda eressero altari 55 e bruciarono incenso sulle porte delle case e nelle piazze. 56 Stracciavano i libri della legge che riuscivano a trovare e li gettavano nel fuoco. 57Se qualcuno veniva trovato in possesso di una copia del libro dell'alleanza o ardiva obbedire alla legge, la sentenza del re lo condannava a morte. 58 Con prepotenza trattavano gli Israeliti che venivano scoperti ogni mese nella città 59 e specialmente al venticinque del mese, quando sacrificavano sull'ara che era sopra l'altare dei sacrifici [nel tempio]. 60Mettevano a morte, secondo gli ordini, le donne che avevano fatto circoncidere i loro figli, 61con i bambini appesi al collo e con i familiari e quelli che li avevano circoncisi. 62 Tuttavia molti in Israele si fecero forza e animo a vicenda per non mangiare cibi immondi 63 e preferirono morire pur di non contaminarsi con quei cibi e non disonorare la santa alleanza; così appunto morirono».
Il simbolo di tutto questo viene sintetizzato con due parole: "abominio della desolazione" come riporta il testo originale. Tutto questo per un ebreo è il Male Assoluto.
Se è così il regime imposto da Antioco Epifane e suoi successori è una continuazione di quel Male che Israele incontra appena uscito dall'Egitto. Allora la guerra o guerriglia che i Maccabei impostano contro il re è una continuazione della Guerra di JHWH, anche se in questi racconti non ci sono, rivelazioni, visioni, profezie, ma solo la pura e nuda fede di chi vuole essere fedele alla Religione dei Padri.
RIPRESA SINTETICA
Cerchiamo ora di tracciare una pista di riflessione che ci aiuterà a comprendere meglio ed arricchire anche leggendo interamente i testi citati.
Il "mio popolo" "esce" - "yazah" - "esodo" - "viene alla luce", (lettura 2 di Esodo) uscendo dal grembo dell'Egitto, attraverso una "Guerra Santa" condotta da JHWH contro Faraone, il quale non è un personaggio storico, ma la personificazione del Male, il Male Assoluto perché con "ostinazione o indurimento del cuore" va direttamente contro il progetto di Dio.
Appena mossi i primi passi questo "popolo bambino" incontra un nemico, Amalek, che cerca di sopprimerlo. In questo modo Amalek diventa il prosecutore del disegno di Faraone: Amalek è la nuova figura storica del Male Assoluto... che però deve fare i conti con JHWH.
Più avanti gli scontri avvengono con il neo re Saul e per questo il profeta Samuele gli impone di sterminare del tutto Amalek. E Saul sarà rigettato come re perché non avendo eseguito completamente lo herem / sterminio, si è messo dalla parte del Male Assoluto.
Questo Male Assoluto fiancheggia tutta la storia del "mio popolo": lo trova Davide, e poi lo ritroviamo nel Libro di Ester in cui Dio sconfigge questo Male non mediante un esercito, ma..."una donna"! Infine lo ritroviamo anche nei due libi dei Maccabei.
Tutte queste "Guerre di JHWH" sono condotte perché il popolo della promessa, uno dei più piccoli e insignificanti, sia in grado di portare al mondo il quella salvezza che si realizzerà in pienezza nei giorni di pasqua, quando il Figlio dopo essere stato appeso alla croce risorgerà da morte. Come promessa rivolta a tutti gli uomini.
CONCLUSIONE
Fin qui abbiamo visto una elaborazione delle Guerre di JHWH sotto il profilo storico, vale a dire, Dio entra invisibilmente in azione attraverso l'aiuto concesso più e più volta al popolo prediletto.
Però c'è un'altra "Guerra di JHWH" meno visibile perché ha a che fare con entità spirituali. Di questo non molto è filtrato nella Bibbia in modo esplicito. Bisognerebbe rivolgersi ai libri Apocrifi dell'Antico Testamento, che tuttavia pur essendo apocrifi a volte sono citati da Gesù Cristo stesso.
Non vogliamo entrare in questo contesto e poniamo solo alcune domande.
Da dove viene il Serpente di Genesi?
Non è lì che Dio annuncia una guerra tra la stirpe della donna (Maria?) e il serpente?
E Gesù prima ancora di iniziare il suo ministero, prima ancora di aprir bocca non si trova davanti il diavolo?
E tutti i Vangeli non sono la dimostrazione di una guerra senza esclusione di colpi tra il diavolo/ satana/ serpente contro Gesù per evitare che salga sulla croce? Per questo punto vedi in Glosse Nota esegetica 9 " Il demonio nel Vangelo di Marco".
Allora possiamo dire che c'è una "Guerra di JHWH" contro potenze spirituali, iniziata già dall'inizio della creazione.
